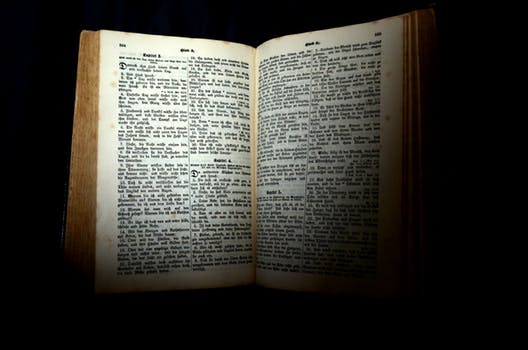
Parole G-O
Le parole G-O della filosofia rock stoica sono strumenti per pensare e parlare. Ecco alcune delle più importanti parole filosofiche (dalla G alla O) scelte nel repertorio originale della lingua greca antica e spiegate a modo nostro.
Qui l’elenco delle parole presenti in questa sezione.
Himeros (vedi la sottovoce Himeros nella sezione ARGOMENTI alla voce Affectus).
Mania (vedi anche la sottovoce Mania nella sezione ARGOMENTI alla voce Affectus).

Gnôsis
(γνῶσις)
“Conoscenza” intesa come forma di ‘scienza’ ampia e veritiera, di tipo benefico ossia capace di conferire il Bene al soggetto conoscente.
Riferimento in greco antico
τοῦτο τοίνυν τὸ τὴν ἀλήθειαν παρέχον τοῖς γιγνωσκομένοις καὶ τῷ γιγνώσκοντι τὴν δύναμιν ἀποδιδὸν τὴν τοῦ ἀγαθοῦ ἰδέαν φάθι εἶναι αἰτίαν δ’ ἐπιστήμης οὖσαν καὶ ἀληθείας, ὡς γιγνωσκομένης μὲν διὰ γνώσεως (Πλάτων – Πολιτεία, Ϛ´).
Traslitterazione
Toûto toínyn tò tèn alétheian paréchon toîs gignôskoménois kaì tôi gignôskonti tèn dýnamin apodidòn tèn toû agathoû idéan pháthi eînai aitían d’ epistémes oûsan kaì aletheías, hôs gignôskoménes mèn dià gnôseôs (Plátōn – Politeía, VI, 508e).
Traduzione
Questo elemento dunque, che trasmette la verità a ciò che è conosciuto e che conferisce a colui che conosce la facoltà di farlo, dì pure che è l’idea del Bene; ed essa è causa di scienza e di verità, in quanto questa viene appresa tramite la conoscenza [“gnôseôs“](Platone – Repubblica, Libro VI, 508e).
“Gnôsis” vuol dire “conoscenza”. Questo nome specifico (altre parole greche antiche significano pure “conoscenza”, ma con sfumature diverse) è presente in varie filosofie ellenistiche.
Per esempio, il termine “gnôsis” (da noi inserito fra le parole della filosofia rock stoica) viene ovviamente usato in relazione allo Gnosticismo. Nell’ambito di questo movimento filosofico, significa ancora “conoscenza”, ma nell’accezione di visione della vera natura dell’umanità in quanto universale (divina). Il riferimento è a una improvvisa liberazione dell’individuo dai vincoli dell’esistenza terrena. È l’accensione della scintilla divina nascosta in ogni uomo. Pertanto, in tale contesto, “gnôsis” vuol dire “conoscenza” nel senso di consapevolezza totalizzante (e rivoluzionaria) – da parte dell’individuo umano – di esser parte della natura divina del tutto.

GNOSIS COME INTELLEZIONE SUPERIORE
Negli scritti di Platone (greco: Plátōn, inglese: Plato), il termine, prevalentemente, non sembra indicare una illuminazione soprannaturale, mistica o squarciante. Esprime, comunque, un processo elevato, nobile, associato a concetti supremi (come il Bene), insomma una sorta di intelligenza superiore e una capacità acquisibile. Ecco uno scambio fra lo Straniero e Socrate (greco: Sōkrátēs, inglese: Socrates) in “Politico” 258e: <Straniero: “in questo modo, quindi, dividi tutta la scienza in due arti, chiamandone una ‘pratica’ (“praktikós“) e l’altra ‘puramente intellettuale’ (“gnostikós“)”. Socrate: “allora la scienza è una e queste sono le sue due forme“>.
Una parola in stretto collegamento con “gnôsis” è l’aggettivo “gnostikós“, abbastanza diffuso nel greco classico, con il significato di “cognitivo”. Platone usa l’aggettivo plurale “gnostikoí” e l’espressione femminile singolare “gnostikē epistēmē” nel suo appena citato “Politikós”.
Nella nostra filosofia, “gnôsis” è la consapevolezza ottenibile seguendo le regole di uno stile di vita austero, vigile e retto. In questo senso, la giustapposizione tra conoscenza e “gnôsis” segna la differenza tra il semplice apprendimento di dati e una comprensione molto più profonda, necessaria per la vera trasformazione della persona.
Brano suggerito: “Gnosis” – Ulver (1999) -> ASCOLTA SU YOUTUBE
Apri qui per scegliere cosa fare.
Torna alla home page di SOKRATIKO.IT oppure torna in testa a questa sezione PAROLE G-O oppure torna all’inizio di GNOSIS.

Hamartánō
(ἁμαρτάνω)
“Fallire il bersaglio”, non centrare l’obbiettivo, mancare il raggiungimento di un traguardo, di una meta, di un proposito.
Riferimento in greco antico
ἔτι τὸ μὲν ἁμαρτάνειν πολλαχῶς ἔστιν […] τὸ δὲ κατορθοῦν μοναχῶς (Ἀριστοτέλης – Ἠθικὰ Νικομάχεια, β´, ϛ´, ͵αργϛ´β).
Traslitterazione
Éti tò mèn hamartánein pollakhôs éstin […] tò dè katorthoûn monakhôs (Aristotélēs – Ēthikà Nikomácheia, II, 6, 1106b).
Traduzione
Inoltre, lo sbagliare [“hamartánein“] è possibile in molti modi […] il far bene invece in un modo solo (Aristotele – Etica Nicomachea, Libro II, 6, 1106b).
“Hamartánō” vuol dire “mancare il bersaglio”. In sintesi, questa antica parola greca significa “sbagliare”. Può riferirsi a un errore derivante dall’ignoranza, a un errore di giudizio, a un difetto del carattere o a una cattiva azione (peccato). Pertanto, “hamartánō” significa “fallire in qualcosa”, “mancare l’obbiettivo”, “andar male in qualcosa”.
Con il termine “hamartēmata” si indica il risultato di brutte abitudini, del seguire opinioni comuni, o di effettuare valutazioni sbagliate. Sono i nostri errori nell’esecuzione di azioni dalle quali può dipendere una catena di eventi negativi.
Dal verbo “hamartánō” (da noi incluso fra le parole della filosofia rock stoica) deriva il termine “hamartía“, un vocabolo moralmente neutro e non prescrittivo (‘errore fatale’).
“Hamartía” riguarda soprattutto la letteratura drammatica. Lo usa per la prima volta Aristotele (greco: Aristotélēs, inglese: Aristotle) in “Poetica”. Nella tragedia greca, con la parola “hamartía” s’intende, in genere, l’errore o il tragico difetto del protagonista, seguito da una serie di azioni il cui effetto è un’inversione di tendenza, cioè un ribaltamento dalla contentezza alla catastrofe.

SBAGLIARE E’ NORMALE, IMPORTANTE E’ CORREGGERSI
“Hamartánō” vuol dire “mancare il bersaglio”. Si tratta, quindi, di un evento abbastanza frequente nella nostra vita. Tutti “manchiamo il bersaglio”, almeno di tanto in tanto. Ed è assolutamente normale avere successo alle volte e talora fallire. Il problema sarebbe sbagliare sempre o fare sempre lo stesso errore.
Ma tutto diventerebbe ancora più grave se non fossimo in grado di accettare e comprendere il fallimento. Perché nella mancata accettazione delle sconfitte dimostreremmo insufficiente umiltà per progredire davvero nella vita.
Allo stesso modo, se non capissimo un insuccesso, allora ci mancherebbero gli strumenti per capovolgere la situazione e migliorare. Solo accettando i fallimenti e comprendendone le ragioni possiamo fare passi avanti e andare oltre.
Brano suggerito: “Off target” – Christ on a crutch (1989) -> ASCOLTA SU YOUTUBE
Apri qui per scegliere cosa fare.
Torna alla home page di SOKRATIKO.IT oppure torna in testa a questa sezione PAROLE G-O oppure torna all’inizio di HAMARTANO.
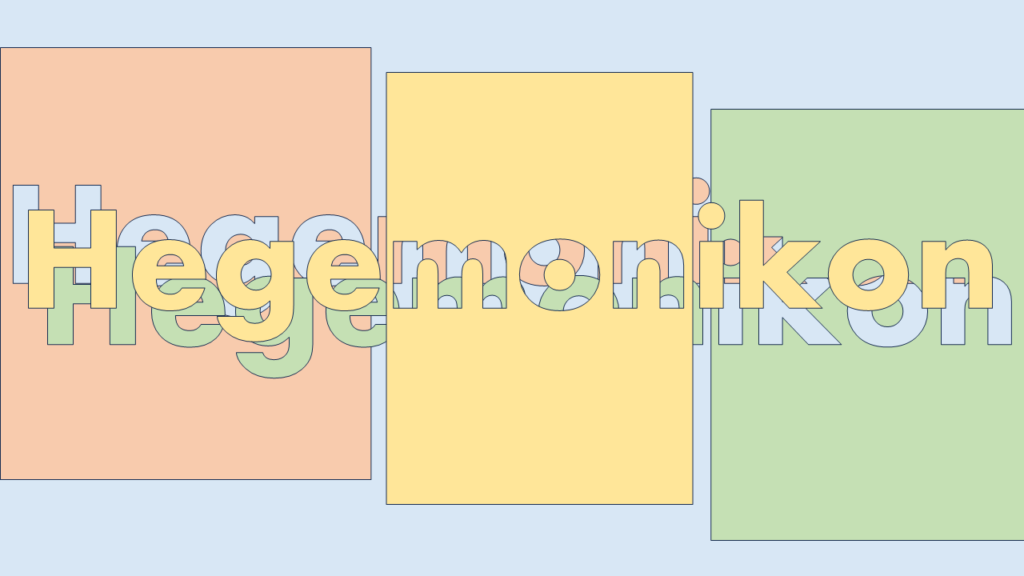
Hēgemonikón
(ἡγεμονικόν)
“Facoltà direttiva razionale”, cabina di regia della coscienza, ‘mente’ intesa come organo capace di ‘immaginazione’, ‘ragione’, ‘impulso’ e ‘assenso’.
Riferimento in greco antico
ἔνδον βλέπε· ἔνδον γὰρ ἡ πηγὴ τοῦ ἀγαθοῦ καὶ ἀεὶ ἀναβλύειν δυναμένη, ἐὰν ἀεὶ σκάπτῃς. τὸ ἡγεμονικόν σου σεαυτῷ ἀνάλωτον ποίει (Μάρκος Αὐρήλιος – Τὰ εἰς ἑαυτόν, Ζ´).
Traslitterazione
Éndon blépe· éndon gàr hē pēghḕ toû agathoû kaì aeì anablýein dynaménē, eàn aeì skáptēis. tò hēgemonikón sou seautôi análōton poíei (Márkos Aurḗlios – Tà eis heautón, VII).
Traduzione
Guarda dentro di te: dentro è la fonte del bene [“agathoû“], che può scaturire sempre se sempre scaverai. Rendi la tua facoltà dirigente [“hēgemonikón“] inespugnabile a te stesso (Marco Aurelio – Colloqui con sé stesso, Libro VII).
“Hēgemonikón” può essere tradotto come “guida razionale interiore”. Questo termine è utilizzato da molti filosofi dell’antica Grecia per indicare la parte intellettuale dominante dell’anima (la mente). In particolare, gli stoici distinguono “hēgemonikón” dall’apparato sensoriale. Infatti, i pensatori del nostro movimento filosofico identificano la “cabina di regia” dell’anima con “hēgemonikón“. Questo perché “hēgemonikón” riceve e assembla le impressioni “phantasíai” (plurale) trasmesse dai sensi.
“Hēgemonikón” (da noi inserita fra le parole della filosofia rock stoica) ha quattro facoltà: immaginazione, ragione, impulso e assenso. Innanzitutto, l’immaginazione: è una riproduzione sensoriale o mentale di fantasie passate. Poi, la ragione: è la facoltà in grado di dare un senso alle cose, applicando la logica. In terzo luogo, l’impulso: è l’inclinazione ad agire verso una fantasia, una impressione, un richiamo sensoriale. In conclusione, l’assenso: è il passo successivo a una valutazione positiva dell’oggetto del desiderio.

LA CABINA DI REGIA DELL’ANIMA
Secondo gli stoici, l’anima ha otto parti, da considerarsi articolazioni di “pneûma“. Di queste parti, sette sono i sensi: vista, udito, olfatto, gusto, tatto, facoltà riproduttiva, facoltà di parola. A essi si aggiunge la facoltà di comando centrale “hēgemonikón“. Attenzione perché tutte le parti dell’anima possono essere indicate come estensioni di “pneûma” aventi origine in “hēgemonikón“.
Ci sono parecchie analogie utili per spiegare l’architettura dell’anima: può essere assimilata a un polpo, a un albero, a una sorgente d’acqua, e anche a una ragnatela. In effetti, tali similitudini sottolineano la complessiva unità dell’anima e l’idea secondo cui le sue facoltà sono raccolte in “hēgemonikón“.
“Hēgemonikón” vuol dire “facoltà dirigente”. E la razionalità è cruciale nel determinare il suo ruolo di comando di una parte importante dell’anima.
Brano suggerito: “Intelligence” – IsOkenny (2022) -> ASCOLTA SU YOUTUBE
Apri qui per scegliere cosa fare.
Torna alla home page di SOKRATIKO.IT oppure torna in testa a questa sezione PAROLE G-O oppure torna all’inizio di HEGEMONIKON.
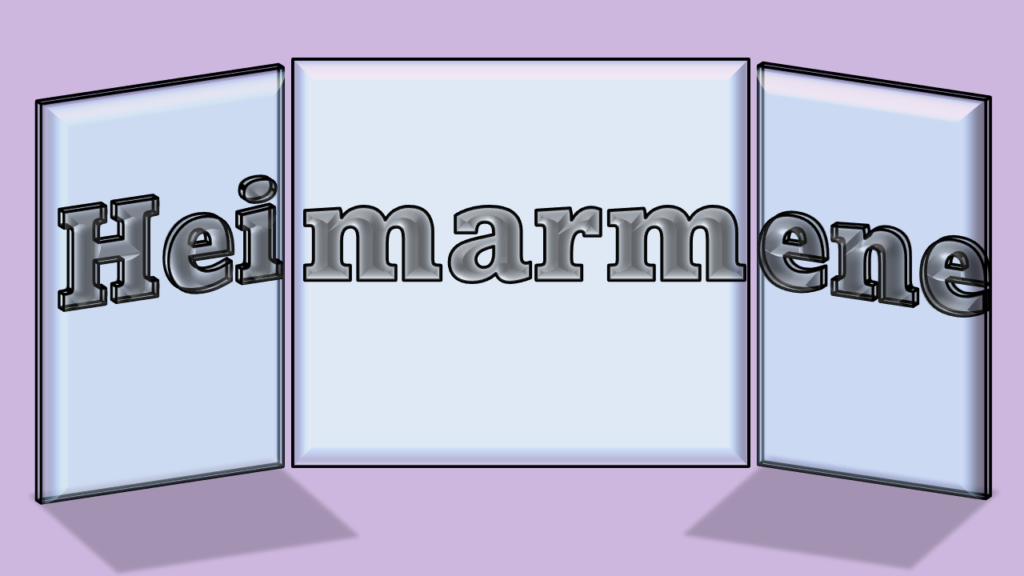
Heimarménē
(εἱμαρμένη)
“Destino ineluttabile”, fato, provvidenza, anche nella forma di una divinità femminile della mitologia greca.
Riferimento in greco antico
τὴν δὲ εἱμαρμένην αἰτίαν τῶν ὄντων εἰρομένην (Ζήνων ὁ Κιτιεύς, ἀπόσπασμα σῳζόμενον ἐν Διογένει Λαερτίῳ – Βίοι καὶ γνῶμαι τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ εὐδοκιμησάντων, ζ’, ρμθ’).
Traslitterazione
Tḕn dè heimarménēn aitían tôn óntōn eiroménēn (Zḗnōn ho Kitiéus, apóspasma sōizómenon en Diogénhei Laertíōi – Bíoi kaì gnômai tôn en philosophíāi eudokimēsántōn, VII, 149).
Traduzione
Il destino [“heimarménēn“] è la causa concatenata degli esseri (Zenone di Cizio, frammento conservato in Diogene Laerzio – Vite dei filosofi, VII, 149).
“Heimarménē” vuol dire “sorte, incarnazione del destino”. È una dea e il suo nome probabilmente deriva da una descrizione di tipo ontologico delle sue apparenze. Inoltre, è una creatura del fato nella mitologia greca. In particolare, rappresenta la sequenza ordinata di causa ed effetto, o, meglio, del destino dell’universo inteso nella sua unità. Questa nozione è l’opposto del destino delle singole persone. “Heimarménē” (da noi inserita fra le parole della filosofia rock stoica) appartiene a un gruppo di simili entità collegate alla nozione di destino come Aesa, Moira, Moros, Ananke, Adrasteia e Pepromene.
Sorge una contraddizione tra “Heimarménē” (provvidenza, destino, fato) e la libertà di scelta (potere dell’uomo sulla propria esistenza). Un problema impervio fin dall’inizio della filosofia e della teologia. La soluzione si può scorgere affermando: il destino ha a che fare con il mondo materiale (ineluttabile) mentre all’uomo resta la scelta delle proprie reazioni agli eventi del mondo materiale.

LA NATURA FISICA SEGUE IL SUO CORSO MA NOI ABBIAMO L’ANIMA
Il corpo umano e i sensi sono soggetti a “physis” (la natura, con leggi non modificabili dall’uomo), ma l’anima e la coscienza sono solo nostre.
“Heimarménē” vuol dire “incarnazione del destino”. La nozione di destino è importantissima nel pensiero antico. Non a caso è alto il numero di tragedie (rappresentazioni teatrali) in cui la provvidenza gioca un ruolo determinante.
Il destino è la forza impetuosa in grado di spazzare via aspirazioni, desideri, progetti e sogni dell’uomo (vedi Shakespeare). Come un fiume, scorre in avanti, incurante degli sforzi prodotti dalle anime umane. La spinta potente, caratteristica della provvidenza, mette a dura prova tutte le qualità e le capacità degli esseri senzienti. Abbiamo due modi per venire a patti con “Heimarménē“. Possiamo provare a sedurla, in modo amichevole e con astuzia. Oppure possiamo essere saggi e servizievoli, evitando di entrare in conflitto con lei.
Brano suggerito: “Destiny” – Jennifer Rush (1985) -> ASCOLTA SU YOUTUBE
Apri qui per scegliere cosa fare.
Torna alla home page di SOKRATIKO.IT oppure torna in testa a questa sezione PAROLE G-O oppure torna all’inizio di HEIMARMENE.

Héxis
(ἕξις)
“Disposizione”, condizione, stato d’animo, attitudine verso qualcosa o predisposizione ad agire in un certo modo in determinate circostanze.
Riferimento in greco antico
ἔστιν ἄρα ἡ ἀρετὴ ἕξις προαιρετική (Ἀριστοτέλης – Ηθικά Νικομάχεια, βʹ, ͵αργϛʹβ, λϛʹ).
Traslitterazione
Éstin ára hē aretē héxis proairetikḗ (Aristotélēs – Ēthikà Nikomácheia, II, 1106b 36).
Traduzione
La virtù [“aretē“] è dunque una disposizione [“héxis“] atta a determinare la scelta [“proairetikḗ“](Aristotele – Etica Nicomachea, Libro II, 1106b 36).
“Héxis” vuol dire “stato” o “disposizione”. Per noi, il termine indica soprattutto uno ‘stato d’animo’, una ‘disposizione verso qualcosa’, una ‘tendenza’ o una ‘abitudine’. Quindi, questa parola indica un concetto somigliante a “êthos” (con l’accento circonflesso)[carattere di una persona], da noi incluso fra i cardini della filosofia rock stoica, cioè, in fin dei conti, qualcosa di cui dobbiamo essere consapevoli e su cui possiamo intervenire.
Per dirla tutta, anche l’”éthos” (con l’accento acuto) [costume di un popolo] in cui siamo immersi (come in un’acqua ‘culturale’), può limitare la nostra piena presenza di spirito e lucidità. Invece, una vita filosofica completa ha bisogno del più alto livello di autocontrollo e capacità gestionale. L’”éthos” innesca alcune reazioni automatiche e risulta pericoloso perché agisce su una coscienza sonnolenta.

“Héxis” vuol dire “stato” o “disposizione”, sebbene Joe Sachs traduca la parola con “condizione attiva”. In ogni caso, come egli stesso precisa, non deve essere confusa con le condizioni passive dell’anima (sentimenti e pulsioni). Inoltre, non è un’abilità di cui siamo in possesso per natura.
Sachs ricorre alla stessa distinzione proposta da Aristotele (greco: Aristotélēs, inglese: Aristotle), nel testo “Categorie” 8b, quando analizza la parola “diatesi” con il significato di “disposizione”. In tale riflessione aristotelica, “diatesi” si applica solo a disposizioni passive e semplici, non difficili da rimuovere e modificare. Ad esempio, non è complicato cambiare il nostro esser caldi o freddi. Basta ventilarsi o coprirsi.
DISPOSIZIONI PROFONDE E ARTICOLATE
“Héxis” indica disposizioni più profonde e attive, come la conoscenza dettagliata di qualcosa in un modo non facilmente ignorabile. Un altro esempio di “héxis” in Aristotele è la salute (“hugieia“ oppure “hygieia“), traducibile con il termine “costituzione”.
In effetti, un’idea di “héxis” la si può ricavare dal contrasto con “enérgeia” (intesa come “attività”).
L’opposizione è abbastanza evidente nelle opere di Aristotele “Etica nicomachea” (inglese: “Nicomachean Ethics“) ed “Etica eudemia” (inglese: “Eudemian Ethics“). In questi due testi, l’attenzione del filosofo dell’antica Grecia si concentra sulla “eudaimonía” (felicità), giusto scopo della vita umana. “Héxis” viene contrapposto a “enérgeia” per mostrare la correttezza di una specifica definizione di “eudaimonía“, da lui proposta, come <attività (“enérgeia“) conforme alla virtù>.
Brano suggerito: “Sweet disposition” – Temper Trap (2008) -> ASCOLTA SU YOUTUBE
Apri qui per scegliere cosa fare.
Torna alla home page di SOKRATIKO.IT oppure torna in testa a questa sezione PAROLE G-O oppure torna all’inizio di HEXIS.

Hormḗ
(ὁρμή)
“Impulso”, trasporto, proiezione, appetito, attrazione, anche con il significato di ‘spirito della energia attiva’ nella mitologia greco-antica.
Riferimento in greco antico
ἀπόσβεσον τὴν φαντασίαν, στῆσον τὴν ὁρμήν (Μάρκος Αὐρήλιος – Τὰ εἰς ἑαυτόν, θʹ, ζʹ).
Traslitterazione
Apósbeson tḕn phantasían, stêson tḕn hormḗn (Márkos Aurḗlios – Tà eis heautón, IX, 7).
Traduzione
Spegni la rappresentazione mentale [“phantasían“], arresta l’impulso [“hormḗn“](Marco Aurelio – Colloqui con sé stesso, Libro IX, 7).
“Hormḗ” vuol dire “impulso”. Innanzitutto, questa entità della mitologia greca personifica ‘l’attrazione positiva verso un oggetto da cui consegue un’azione’. In secondo luogo, rappresenta una sorta di ‘innesco energetico’, l’inizio di un’azione, il richiamo a fare qualcosa, l’entusiasmo, la disponibilità, il mettersi in moto. Il personaggio mitologico opposto è Aergia, dea dell’accidia e dell’apatia. La parola contraria a “hormḗ” è “aphormḗ” (anche questa inclusa da noi fra le parole della filosofia rock stoica).
Marco Aurelio (greco: Marcus Aurelius Antoninus Augustus, inglese: Marcus Aurelius), nelle sue “Meditazioni”, riporta la seguente esortazione di Epitteto (greco: Epíktētos, inglese: Epictetus): “dobbiamo prestare particolare attenzione alla sfera dei nostri impulsi affinché siano soggetti a restrizioni, al bene comune, e siano proporzionati al valore effettivo“.
Seneca (latino: Lucius Annaeus Seneca, inglese: Seneca the Younger) usa spesso l’equivalente latino “impetus” nelle “Lettere morali”, ad esempio nel seguente passo: “la virtù risiede nel nostro giudizio, il quale dà origine all’impulso e chiarisce tutte le apparenze da cui trae origine l’impulso“.

IL MONDO DELLE PULSIONI
“Hormḗ” vuol dire ‘impulso’. Secondo Sir Percy Nunn, il concetto si riferisce alle pulsioni o agli impulsi intenzionali di un organismo, consci o meno. Lo studioso britannico trae ispirazione da Carl Gustav Jung. Ma il fondatore della psicologia analitica mettendo in relazione il termine con i valori psicologici esprime un significato più circoscritto.
Secondo Maria Montessori, dalle pulsioni interiori dipende il comportamento del bambino. Questi impulsi hanno lo scopo di auto-costruire l’individuo. In altri termini, spingono il bambino a diventare uno specifico adulto. L’opposto di questa idea è lo sviluppo del bambino per causalità. La tesi di Montessori si avvicina al concetto aristotelico di “enteléchia” (“en” + “telos“).
Il concetto è molto caro allo psicologo americano James Hillman. Secondo l’autore de “Il codice dell’Anima”, tutti abbiano un destino da compiere, una vocazione da seguire con dedizione e fedeltà. Pertanto, tutti dobbiamo comprendere e accettare la nostra missione personale nella vita. Se ci relazioniamo con il nostro seme originale (ghianda) troviamo la nostra strada verso la felicità (“eudaimonía“).
Brano suggerito: “Impulse” – Northlane (2015) -> ASCOLTA SU YOUTUBE
Apri qui per scegliere cosa fare.
Torna alla home page di SOKRATIKO.IT oppure torna in testa a questa sezione PAROLE G-O oppure torna all’inizio di HORME.

Húlē
(ὕλη)
“Materia”, nella gran parte delle accezioni note di questo termine, ma anche come elemento primario e fondante del cosmo.
Riferimento in greco antico
ἡ δὲ φύσις διχῶς, ἡ μὲν ὡς ὕλη ἡ δ᾽ ὡς μορφή (Ἀριστοτέλης – Φυσικὴ ἀκρόασις, βʹ, ρϟδʹα, ιβʹ- ιγʹ).
Traslitterazione
Hē dè phýsis dichôs, hē mèn hōs hýlē hē d’ hōs morphḗ (Aristotélēs – Physikḕ akróasis
2, 194a 12-13).
Traduzione
La natura [“phýsis“] (si intende) in due sensi: da un lato come materia [“hýlē“], dall’altro come forma [“morphḗ“] (Aristotele – Fisica, Libro II, 194a 12-13).
“Húlē” vuol dire “materia” o “materiale”. Questa antica parola greca è talvolta intercambiabile con “ousía” (sostanza).
Secondo Epitteto (greco: Epíktētos, inglese: Epictetus) le cose esterne sono ‘materia prima’ della nostra “proaíresis” (libertà di scelta) mentre “la materia prima per l’agire di una persona eccellente è la sua stessa ragione guida (“hēgemonikón“)”.
Marco Aurelio (greco: Marcus Aurelius Antoninus Augustus, inglese: Marcus Aurelius) spiega come possiamo “convertire qualsiasi ostacolo in ‘materia prima’ per i nostri scopi“.

“Húlē” (da noi aggiunta alle parole della filosofia rock stoica) vuol dire ‘materia’ o ‘materiale’ ed è anche la sostanza primaria del cosmo. Da questa materia, dunque, sorgono i quattro elementi (aria, acqua, terra, fuoco), secondo le dottrine di Empedocle (greco: Empedoklês, inglese: Empedocles) e di Aristotele (greco: Aristotélēs, inglese: Aristotle).
A proposito di Aristotele, è qui opportuno citare l’ilemorfismo, teoria secondo cui le cose sono combinazioni di materia e forma. Di conseguenza, tre fattori sono determinanti: le due “componenti” (materia e forma), ma pure il “modo” in cui le due si compongono insieme. Quindi, per Aristotele, il concetto di materia si deve intendere in termini di composizione. E, comunque, la materia svolge una certa funzione irrinunciabile nel composto. È, in qualche modo, il contributore passivo nell’atto di composizione.
FORMA E MATERIA NELL’ETICA
Aristotele basa la sua teoria etica su questo ilemorfismo. Secondo lui, infatti, un essere umano ha determinati talenti per via della sua forma. Quindi, il suo compito nella vita è esercitare queste capacità nel modo migliore e più completo possibile. Ora, la capacità umana più specifica, non presente nella forma terrena di nessun altro organismo, è la capacità di pensare. Pertanto, la migliore vita umana possibile è quella basata sul pensiero razionale.
Brano suggerito: “Spirits in the material world” – Police (1981) -> ASCOLTA SU YOUTUBE
Apri qui per scegliere cosa fare.
Torna alla home page di SOKRATIKO.IT oppure torna in testa a questa sezione PAROLE G-O oppure torna all’inizio di HULE.

Hypólēpsis
(ὑπόληψις)
“Giudizio”, formazione di una valutazione, acquisizione di una certezza, opinione a proposito di qualcuno, di una cosa oppure di un fatto.
Riferimento in greco antico
ὅτι πάντα ὑπόληψις (Μάρκος Αὐρήλιος – Τὰ εἰς ἑαυτόν, ιβ´, κβ´).
Traslitterazione
Hóti pánta hypólēpsis (Márkos Aurḗlios – Tà eis heautón, XII, 22).
Traduzione
Tutto è opinione [“hypólēpsis“](Marco Aurelio – Colloqui con sé stesso, Libro XII, 22).
“Hypólēpsis” vuol dire “giudizio”, “opinione”. È la ‘elaborazione mentale di un giudizio’, di una nozione valutativa, di una comprensione. Per Epitteto (greco: Epíktētos, inglese: Epictetus), quando ci convinciamo di qualcosa accade un processo mentale in tre fasi. 1. All’origine di un giudizio c’è il suo pre-concepimento (“prolēpsis“). 2. In seguito, c’è il concepimento del giudizio (“hypólēpsis“). 3. Infine, si arriva al giudizio formato, stabile, completo (“katálēpsis“).
Aristotele (greco: Aristotélēs, inglese: Aristotle) fa ampio uso di “hypólēpsis” (termine da noi inserito fra le parole della filosofia rock stoica). Per Jessica Moss (NYU) e Whitney Schwab (UMBC), la nozione di “hypólēpsis” corrisponde significativamente alla moderna nozione di ‘credenza’. Inoltre, è la nozione generale comprensiva di altri più specifici atteggiamenti cognitivi e svolge questo ruolo perché è l’atteggiamento del ‘prendere per vero qualcosa in quanto tale’.
Infatti, nel “De Anima” 427b24–26 aristotelico si legge “ci sono differenze all’interno della stessa “hypólēpsis“. Innanzitutto la conoscenza (“epistēmē“), in secondo luogo l’opinione (“dóxa“), seguita dalla saggezza pratica (“phrónēsis“), e gli opposti di queste“.
HYPOLEPSIS COME CONCETTO GENERALE DI GIUDIZIO
Nel pensiero di Aristotele, la conoscenza, l’opinione e la saggezza pratica sono pertanto tutte varianti di “hypólēpsis“, ossia rappresentano ‘specie’ del ‘genere’ “hypólēpsis“. Di conseguenza, gli opposti della conoscenza e della saggezza pratica si identificano con la conoscenza errata e con la saggezza basata su nozioni fallaci.
È meno chiaro invece quale potrebbe essere il contrario di “dóxa“, visto che essa, già in sé, è una opinione non supportata da elementi probanti. Risulta, tuttavia, abbastanza evidente la definizione di “hypólēpsis” in Aristotele, come un genere di altri processi di cognizione/valutazione.

“Hypólēpsis” vuol dire “giudizio di valore”, ma le interpretazioni, i dettagli e le implicazioni di questo termine sono molte. Questo succede spesso con le parole antiche quando abbiamo a disposizione scarsi indizi per ricavarne una traduzione e attualizzazione precisa.
Per di più, la filosofia è, essa stessa, sempre alla ricerca di nuovi termini e nuovi significati, perché costantemente impegnata nell’esplorazione di nuovi temi e nuovi orizzonti. Pertanto, la nostra mente dovrebbe restare flessibile e aperta quando si tratta di interpretare nozioni e termini complessi. Significati, sfumature e specificità potrebbero variare in modo importante a seconda dei pensatori.
Brano suggerito: “Appreciation” – King Sunny Adé (2000) -> ASCOLTA SU YOUTUBE
Apri qui per scegliere cosa fare.
Torna alla home page di SOKRATIKO.IT oppure torna in testa a questa sezione PAROLE G-O oppure torna all’inizio di HYPOLEPSIS.
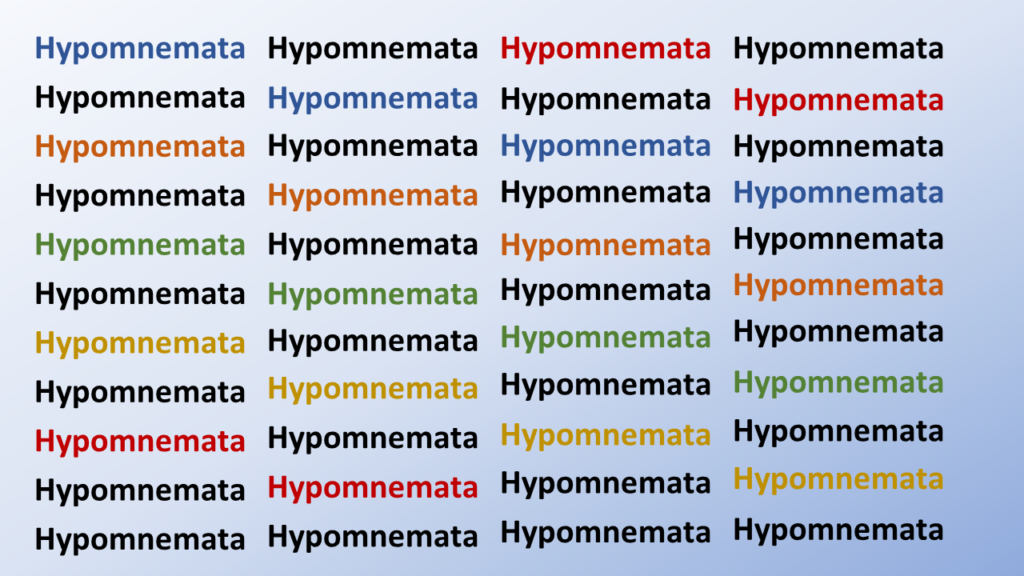
Hypomnēmata
(ὑπομνήματα)
“Blocco note”, appunti, taccuino per fissare alcuni punti, per annotare elementi da richiamare successivamente alla memoria.
Riferimento in greco antico
μηκέτι πλανῶ· οὔτε γὰρ τὰ ὑπομνήματά σου μέλλεις ἀναγινώσκειν (Μάρκος Αὐρήλιος – Τὰ εἰς ἑαυτόν, γʹ, ιδʹ).
Traslitterazione
Mēkéti planō· oute gar ta hypomnēmata sou melleis anaginōskein (Márkos Aurḗlios – Tà eis heautón, III, 14).
Traduzione
Non vagare più; non sei destinato infatti a rileggere i tuoi appunti [“hypomnēmata“](Marco Aurelio – Colloqui con sé stesso, Libro III, 14).
“Hypomnēmata” vuol dire “bloc notes” o “memo”. Questa antica parola greca designa un taccuino, quaderno o blocco degli appunti. Indica anche le note prese (spesso durante le lezioni) per memorizzare fatti od osservazioni rilevanti. In breve, indica sia gli oggetti su cui scrivere sia i loro contenuti.
Platone (greco: Plátōn, inglese: Plato) è tra i primi (ai suoi tempi) a riconoscere l’utilità della scrittura come supporto per la memoria. Per gli studenti della sua Accademia, infatti, sviluppa i principi “ipomnesici”.
Secondo Michel Foucault “gli “hypomnēmata” costituiscono una memoria materiale di cose lette, udite o pensate“. Riferendosi all’antica Grecia, Foucault scrive (1997, “Ethics: Subjectivity and Truth” – New York: The New Press, p. 273) “queste note sono un tesoro di informazioni e dati per la rilettura e la successiva meditazione. Costituiscono anche la materia prima per la scrittura di trattati più sistematici. In questi ultimi ci sono argomenti e mezzi per combattere contro alcuni difetti (come la rabbia, l’invidia, il pettegolezzo, l’adulazione). O per superare alcune circostanze difficili (un lutto, un esilio, una caduta, una disgrazia)“.
RILIEVO DEGLI APPUNTI NEL LAVORO FILOSOFICO
“Hypomnēmata” (fra le parole della filosofia rock stoica) vuol dire “bloc notes” o “memo”. Si tratta di strumenti da non considerare marginali per la filosofia antica. In effetti, rappresentano una componente cruciale degli esercizi spirituali (filosofici), come l’autoanalisi dell’anima. Portare sempre con sé i bloc notes e gli scritti fa parte di una vita filosofica. Occorre, infatti, assicurarsi la possibilità di una rapida consultazione delle note in caso di bisogno. Averle con sé potrebbe essere utile per approfittare di una pausa nella routine quotidiana o in caso di dubbi su cosa fare, cosa scegliere, cosa dire.
Brano suggerito: “Wonderful remark” – Van Morrison (1983) -> ASCOLTA SU YOUTUBE
Apri qui per scegliere cosa fare.
Torna alla home page di SOKRATIKO.IT oppure torna in testa a questa sezione PAROLE G-O oppure torna all’inizio di HYPOMNEMATA.
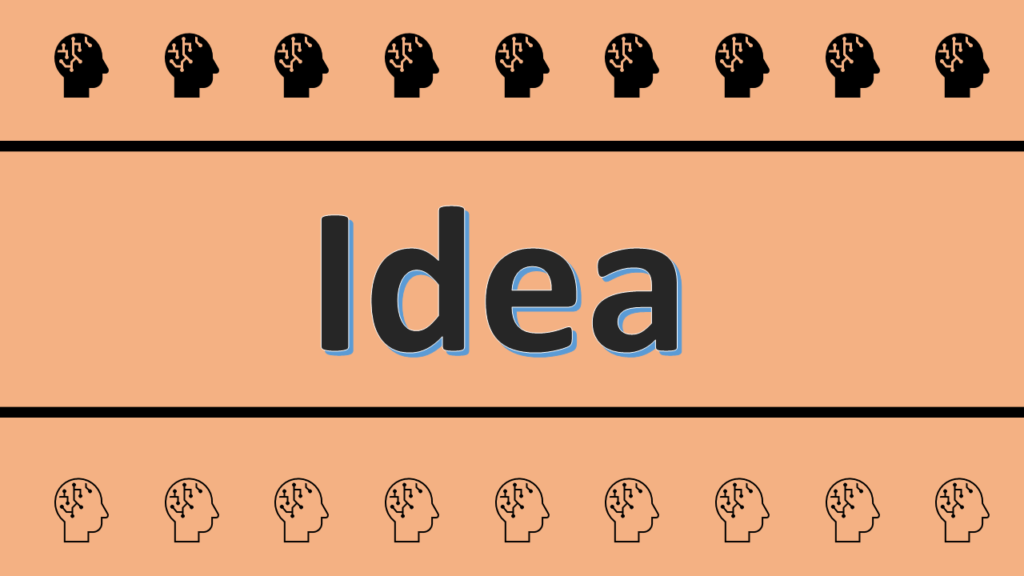
Idéā
(ἰδέα)
“Forma immutabile” e concreta di un elemento del mondo, modello generale di ciascun ente quotidiano, prototipo basilare di ogni componente del nostro mondo.
Riferimento in greco antico
τοῦτο τοίνυν τὸ τὴν ἀλήθειαν παρέχον τοῖς γιγνωσκομένοις καὶ τῷ γιγνώσκοντι τὴν δύναμιν ἀποδιδὸν τὴν τοῦ ἀγαθοῦ ἰδέαν φάθι εἶναι· (Πλάτων – Πολιτεία, ϛʹ, φηʹ ε).
Traslitterazione
Toûto toínyn tò tḕn alḗtheian paréchon toîs gignōskoménois kaì tô gignṓskonti tḕn dýnamin apodidòn tḕn toû agathoû idéān pháthi eînai; (Plátōn – Politeía, VI, 508e).
Traduzione
Questo elemento dunque, che conferisce la verità alle cose conoscibili e che dà al soggetto conoscente la facoltà di conoscere, di’ pure che è l’idea [“idéān“] del bene [“agathoû“]; (Platone – Repubblica, Libro VI, 508e).
“Idéā” si deve intendere come “forma invariante”. Questa parola può anche esprimere la nozione filosofica di “forma”, di “modello”, di “prototipo” in modo generale e onnicomprensivo.
Nell’antica Grecia, Platone (greco: Plátōn, inglese: Plato) avvia un’ampia analisi delle idee (forme) e del processo stesso di formazione del pensiero. Nei dialoghi denominati “Fedone“, “Simposio“, “Repubblica” e “Timeo” fa, infatti, riferimento a una serie di idee o forme. I termini usati da Platone per indicare tali forme sono “eîdos” e “idéā” (da noi considerate parole della filosofia rock stoica). Ma occorre stare attenti, perché quest’ultima potrebbe essere confusa con la nozione di ‘invenzione’ e ciò sarebbe fuorviante.
Secondo Platone, le forme non sono entità mentali, né dipendono dalla mente. Semmai sono entità la cui esistenza (effettiva) e natura (autentica) sono comprensibili ‘solo dalla mente’. Tuttavia, per esistere non è necessario siano afferrate, comprese, interiorizzate. In altre parole, una qualsiasi “idéā” esiste indipendentemente da chiunque abbia (o non abbia) pensieri su questa stessa “idéā“.

IMMUTABILITA’ DELLE IDEE
“Idéā” vuol dire “forma invariante”. Per Platone, ci sono almeno due mondi. Innanzitutto, questo nostro mondo costituito – in apparenza – da oggetti concreti; è il mondo colto dai nostri sensi (ingannevoli) e in continuo cambiamento. In secondo luogo, c’è un mondo immutabile di forme ideali colte dalla ragione pura. Il nostro mondo apparente quotidiano si fonda sul mondo delle idee. Le entità materiali di quaggiù sono transitorie e soggette a proprietà contraddittorie, mentre le idee sono immutabili, stabili e perfette.
In molti passaggi, Platone accarezza il concetto secondo cui le cose materiali possono essere solo oggetto di opinione (“dóxa“) e non di conoscenza vera. Pertanto, la conoscenza vera riguarderebbe unicamente le idee immutabili. Inoltre, le idee per Platone svolgono la funzione di “universali” (nel senso attribuito a questo termine dalla filosofia stoica) ma esistenti per davvero e non solo nella nostra capacità mentale di astrazione.
Quindi, le forme di cui parla il discepolo di Socrate (greco: Sōkrátēs, inglese: Socrates) rappresentano tipi (esemplari) di cose, come qualità, modelli e relazioni. Proprio come pietre, alberi, scatole, vasi e vestiti si riferiscono a oggetti in questo mondo, similmente ‘pietrezza’, ‘alberezza’, ‘scatolezza’, ‘vasezza’ e ‘vestitezza’ si riferiscono a oggetti in un altro mondo.
Brano suggerito: “Bad idea” – Blind Channel (2022) -> ASCOLTA SU YOUTUBE
Apri qui per scegliere cosa fare.
Torna alla home page di SOKRATIKO.IT oppure torna in testa a questa sezione PAROLE G-O oppure torna all’inizio di IDEA.

Kairós
(καιρός)
“Momento giusto”, attimo favorevole, occasione propizia, congiuntura positiva, opportunità temporale giusta, benevole, da cogliere.
Riferimento in greco antico
ὁ βίος βραχύς, ἡ δὲ τέχνη μακρή, ὁ δὲ καιρὸς ὀξύς, ἡ δὲ πεῖρα σφαλερή, ἡ δὲ κρίσις χαλεπή (Ἱπποκράτης – Ἀφορισμοί, Αʹ, αʹ).
Traslitterazione
Ho bíos brachýs, hē dè téchnē makrḗ, ho dè kairòs oxýs, hē dè peîra sphalerḗ, hē dè krísis chalepḗ (Hippokrátēs – Aphorismoí, I, 1).
Traduzione
La vita è breve, l’arte [“téchnē“] è lunga, il momento opportuno [“kairòs“] è fuggevole, l’esperienza ingannevole, il giudizio difficile (Ippocrate – Aforismi, Libro I, 1).
“Kairós” vuol dire “momento propizio”. Questo sostantivo del vocabolario della filosofia greca esprime la nozione di “momento giusto”, “attimo da cogliere”, “occasione”.
Gli antichi greci usano due parole per la nozione di “tempo”: “chrónos” (χρόνος scritto in traslitterazione anche come “khrónos”) e “kairós“. Innanzitutto, “chrónos“ si riferisce al tempo cronologico o sequenziale. In secondo luogo, “kairós” indica il momento giusto od opportuno per l’azione. “Chrónos” è quantitativo mentre “kairós” ha una natura prevalentemente qualitativa.
Il termine “kairós” è molto diffuso nell’antica Grecia, tra le scuole di pensiero più rilevanti. Soprattutto le scuole sofiste e quelle dei loro ‘concorrenti’, guidate da filosofi come Platone (greco: Plátōn, inglese: Plato).
“Kairós” (da noi inserita fra le parole della filosofia rock stoica) fa parte dello schema sofistico della retorica insieme alle nozioni di “prépon” e “dynatón“. Queste due nozioni, combinate con “kairós“, sono gli strumenti per una retorica di successo. “Prépon” esprime l’idea secondo cui il discorso deve essere conforme sia al ‘pubblico’ sia alla ‘circostanza’. “Dynatón” indica il ‘possibile’, o ciò di cui l’oratore vuole convincere il pubblico.

KAIRÓS E TIRO CON L’ARCO
“Kairós” vuol dire “momento propizio”. Nel suo lavoro etimologico del 1951, Richard Broxton Onians fa risalire la radice della parola a ‘tiro con l’arco’ e ‘tessitura’. Nel tiro con l’arco, “kairós” indica il momento in cui una freccia può essere lanciata con forza ed equilibrio adatti a colpire e penetrare il bersaglio. Nella tessitura, “kairós” è il momento in cui la navetta passa attraverso i fili sul telaio.
Anche, Eric Charles White, nel suo “Kaironomia” del 1983, ricorre allo stesso concetto. Scrive, infatti, di “una lunga apertura simile a un tunnel all’interno della quale deve passare la freccia dell’arciere” e anche di “quando il tessitore deve tirare il filo attraverso uno spazio in apertura momentanea nell’ordito della stoffa sottoposta a tessitura“. Questi esempi si riferiscono chiaramente a una precisa scelta di tempo importante al fine di ottenere il risultato ottimale.
Brano suggerito: “The right time” – The Corrs (1996) -> ASCOLTA SU YOUTUBE
Apri qui per scegliere cosa fare.
Torna alla home page di SOKRATIKO.IT oppure torna in testa a questa sezione PAROLE G-O oppure torna all’inizio di KAIROS.

Kalόn
(καλόν)
“Bellezza perfetta”, bellezza ideale, bellezza morale intesa come forma sublime di bellezza in grado di realizzare un ideale di perfezione.
Riferimento in greco antico
χαλεπὰ τὰ καλά (Πλάτων – Πολιτεία, Δ, υλε´γ).
Traslitterazione
Chalepà tà kalá (Plátōn – Politeía, IV, 435c).
Traduzione
Le cose belle [“καλά“] sono difficili (Platone – Repubblica, Libro IV, 435c).
“Kalόn” vuol dire “bellezza morale”. Per i filosofi greci antichi, il moralmente lodevole (il buono) è anche bello e gradevole. Nel loro pensiero, c’è una sorta di unità e coerenza tra bontà, bellezza e piacere. In altre parole, una cosa moralmente valida non può essere né brutta né spiacevole. Una cosa buona è certamente sia bella sia piacevole. Di conseguenza, se percepiamo una bellezza morale come brutta o magari sgradevole, ciò deve dipendere da un nostro errore.
Per esempio, un soldato inchinato, di propria volontà, allo scopo di esprimere sincero rispetto e ammirazione davanti al suo valoroso comandante compie un atto buono e bello. Oltre alla sua bellezza, una scena del genere dà anche piacere agli occhi dello spettatore e di chi ne è protagonista. Quindi, siamo di fronte a un atto moralmente positivo, bello e piacevole.
Il termine greco antico “kalόn” (da noi inserita fra le parole della filosofia rock stoica) è in opposizione al termine “aischrόn” quest’ultimo usato per indicare il “male morale”.

UNIVERSO E VITA SONO KALÓN
Platone (greco: Plátōn, inglese: Plato) considera “kalόn” uno degli attributi dell’universo e della nostra stessa esistenza. Per lui, la bellezza assoluta è identica al bene assoluto. Inoltre, essa è identica al veramente piacevole, come lo è per Aristotele (greco: Aristotélēs, inglese: Aristotle) in “Etica Eudemia” I.1, 1214a1–8. Pertanto, l’aristotelico ‘uomo buono’ agisce <per amore del bello (“to kalόn“)> (“Etica Nicomachea” IV.2, 1122b6-7.
Per questo motivo, si attribuisce ad Aristotele la nozione di ‘persona ideale’ intesa come quella capace di agire secondo la morale e anche – se si presenta l’occasione – in modo altruistico. Naturalmente, un tale atteggiamento è profondamente diverso dall’essere preoccupati per il proprio piacere.
“Kalόn” vuol dire “bellezza morale” o “bellezza perfetta”. Questa parola esprime anche la nozione di “bellezza ideale”. Ma questo tipo di ‘bello’ e ‘ammirevole’ non è solo morale e ideale. Infatti, certamente il termine include qualità fisiche apprezzabili. Altrimenti si tratterebbe di “buono” e non di “bello”. Come detto, il bello è anche buono.
Brano suggerito: “You’re gorgeous” – Babybird (1996) -> ASCOLTA SU YOUTUBE
Apri qui per scegliere cosa fare.
Torna alla home page di SOKRATIKO.IT oppure torna in testa a questa sezione PAROLE G-O oppure torna all’inizio di KALON.

Katalepsis
“Apprendimento”, comprensione, qualcosa da afferrare mentalmente e a cui poi assentire pienamente in quanto veritiera.
“Katalepsis” vuol dire “comprensione”. La parola è in stretta relazione con i concetti di “afferrare”, “cogliere”, “ritenere”, “apprendere”. Nella filosofia stoica, il termine esprime l’idea di apprendimento, intendimento, cognizione.
Per gli stoici, infatti, la nostra mente è piena di impressioni (“phantasiai“), alcune vere e altre false. Si considerano vere quando sono affermate veramente, false quando sono affermate erroneamente. Facciamo un esempio delle ultime: credere rotto un remo – mezzo immerso nell’acqua – perché sembra esserlo (alla vista), è un’impressione falsa.
Quando Oreste, nella sua follia, scambia Elettra per una Furia, ha un’impressione sia vera sia falsa. In primo luogo, ‘vera’ perché vede davvero qualcuno (Elettra). Secondariamente, ‘falsa’ perché lei (Elettra) non è una Furia.
Inoltre, secondo gli stoici, la mente distingue intuitivamente tra impressioni reali e false. Pertanto, non bisognerebbe dare credito a tutte le nostre percezioni. In effetti, dovremmo fidarci solo delle percezioni in grado di mostrare alcune caratteristiche speciali delle cose come ci appaiono. Queste sono dette “kataleptic phantasiai” cioè ‘percezioni comprensibili’.

IMPRESSIONI CORRISPONDENTI AL VERO
“Katalepsis” (fra le parole della filosofia rock stoica) vuol dire “comprensione”. Una “kataleptic phantasia” è quella derivante da un oggetto realmente esistente. In un certo senso, la “kataleptic phantasia” è una copia di quell’oggetto e non può avere origine da nessun altro oggetto.
Per esempio, possiamo vedere un prato mentre camminiamo realmente in campagna. Ma possiamo anche vedere lo stesso prato in una creazione mentale perfetta e meravigliosa. Ora, la prima percezione arriva con i profumi e un po’ di brezza. Mentre la seconda non ci offre né fragranze né vento. In altri termini, la prima percezione mostra alcune caratteristiche speciali. Quindi, è una “kataleptic phantasia“. Infine – va notato – un’immagine potrebbe benissimo essere l’immagine di un’immagine.
Brano suggerito: “I think I understand” – Joni Mitchell (1969) -> ASCOLTA SU YOUTUBE
Apri qui per scegliere cosa fare.
Torna alla home page di SOKRATIKO.IT oppure torna in testa a questa sezione PAROLE G-O oppure torna all’inizio di KATALEPSIS.

Kathegetes
“Maestro”, tutore, coadiutore, persona dotata delle caratteristiche idonee a trasmettere un sapere anche testimoniandolo con esempi concreti e quotidiani.
“Kathegetes” vuol dire “maestro”. Questa antica parola greca indica chi svolge alcuni compiti del maestro, della guida, del tutore. Qui su sokratiko.it ci riferiamo ad alcuni istruttori delle nostre scuole filosofiche di derivazione socratica (in primis lo Stoicismo).
In qualche contesto, il termine “kathegetes” sembra non corrispondere esattamente a “hegemon” cioè leader. In effetti, “hegemon” significa prioritariamente comandante o capo. Pertanto, la parola alluderebbe al maestro più importante di una scuola. Invece, “kathegetes” potrebbe riferirsi anche all’assistente, al collaboratore principale o al leader associato.

LIVELLI DI IMPORTANZA
“Kathegetes” (fra le parole della filosofia rock stoica) vuol dire “maestro”, ma non ‘maestro principale’. Non è necessariamente una funzione secondaria o marginale. Per esempio, come sappiamo, Aristotele (greco: Aristotélēs, inglese: Aristotle), a diciassette o diciotto anni, si unisce all’Accademia di Platone (greco: Plátōn, inglese: Plato) ad Atene e vi rimane fino all’età di trentasette anni (347 a.C. circa). Probabilmente (possiamo soltanto presumerlo perché le prove sono scarse) nell’Accademia, Aristotele diventa un “kathegetes“.
Poco dopo la morte di Platone, Aristotele lascia Atene e, su richiesta di Filippo II di Macedonia, fa da tutore ad Alessandro Magno, a partire dal 343 a.C. Fonda una biblioteca nel Liceo, di fondamentale utilità per la produzione di molte dei suoi numerosi libri su rotoli di papiro.
Il compito degli insegnanti filosofici non è solo la tradizionale ‘consegna’ della conoscenza. Devono anche essere ‘modelli’ di comportamento, mostrando in modo pratico come dare senso compiuto ai propri insegnamenti nel corso della vita di tutti i giorni. Tuttavia, la loro funzione più specifica è quella di ‘aiutare’ il soggetto (allievo) nella sua ricerca interiore.
Questo perché ogni individuo deve sempre svolgere un lavoro fondamentale su se stesso. Un lavoro per il quale si richiede la guida e la competenza di maestri preparati e virtuosi.
Brano suggerito: “Meeting the master” – Greta Van Fleet (2023) -> ASCOLTA SU YOUTUBE
Apri qui per scegliere cosa fare.
Torna alla home page di SOKRATIKO.IT oppure torna in testa a questa sezione PAROLE G-O oppure torna all’inizio di KATHEGETES.

Kathekon
“Dovere innato”, azione naturale, decisione spontanea, un agire secondo la giustizia universale ossia secondo natura, in accordo con il Tutto.
“Kathekon” vuol dire “dovere naturale”. Questa antica parola greca ha il significato di “comportamento appropriato”, “azione adeguata”, “attività conveniente per l’ordine naturale”. A ciò si aggiunge anche quello di “funzione corretta”. Marco Tullio Cicerone (latino: Marcus Tullius Cicero, inglese: Cicero) traduce “kathekon” in latino con “officium” (servizio). Invece, per Seneca (latino: Lucius Annaeus Seneca, inglese: Seneca the Younger), il termine greco “kathekon” diventa in latino “convenientia“.
Nell’etica stoica è frequente il confronto tra “kathēkonta” (plurale di “kathekon“) e “katorthōmata” (plurale di “katorthōma“), cioè “azioni perfette”. Secondo la filosofia stoica, l’uomo (e tutti gli altri esseri viventi) devono “comportarsi secondo Natura”. In effetti, questo è il significato principale di “kathēkon“.
Il termine indica proprio un comportamento naturale, semplice, coerente, tipico di un livello base e istintivo riguardante tutte le persone. Ma a uno stadio molto più alto (raggiungibile solo dai saggi), c’è “katorthōma” (azione perfetta). Tuttavia, una “katorthōma” potrebbe benissimo essere valutata dalle persone comuni come semplicemente orribile. Questo perché un individuo ordinario potrebbe faticare a vederla in tutta la prospettiva necessaria. Per esempio, potrebbe essere una “katorthōma” la uccisione di alcuni innocenti se in gioco ci fosse la vita di migliaia di persone innocue.

NATURALEZZA E SEMPLICITA’ DELLE AZIONI APPROPRIATE
“Kathekon” (fra le parole della filosofia rock stoica) vuol dire “dovere naturale” ed esprime una nozione semplice. Molto semplice appunto perché naturale. Quindi, qualsiasi “kathekon” dovrebbe sorgere interiormente in modo spontaneo, genuino e non finto. Per esempio, è un “dovere naturale” prendersi cura dei propri figli. Ciò accade in modo spontaneo e sincero. In altri termini, non si pone il dubbio né si rimugina su un tema come il sostentamento e la protezione dei propri figli. È una cosa naturale.
Brano suggerito: “Spontaneous me” – Lindsey Stirling (2011) -> ASCOLTA SU YOUTUBE
Apri qui per scegliere cosa fare.
Torna alla home page di SOKRATIKO.IT oppure torna in testa a questa sezione PAROLE G-O oppure torna all’inizio di KATHEKON.

Koinos
“Comune”, condiviso, in accordo con gli altri, pubblico, partecipato all’interno di una collettività.
“Koinos” vuol dire “comune”. Altre traduzioni di questa antica parola greca sono “condiviso”, “diffuso”, “pubblico”. Il termine ha una stretta relazione con le nozioni di comunità, alleanza, amicizia, comunanza, cooperazione.
L’idea di azioni per il bene comune ricorre sovente negli scritti di Marco Aurelio (greco: Marcus Aurelius Antoninus Augustus, inglese: Marcus Aurelius). Per esempio in questo passaggio dedicato al senso della nostra esistenza: “il frutto di questa breve vita sia un buon carattere e agire per il bene comune“. L’idea torna quando promuove un rituale mattutino per ricordare a noi stessi quali devono essere i nostri obiettivi e allora scrive: “abbiamo per natura lo scopo di lavorare in comune con gli altri“.

COMUNANZA E RECIPROCITÀ
“Koinos” (fra le parole della filosofia rock stoica) vuol dire “comune”. Un termine simile, per indicare la reciprocità, compare in Marco Aurelio ed Epitteto (greco: Epíktētos, inglese: Epictetus). È “allelon“, usato in espressioni in cui si sottolinea il nostro dovere di vivere “l’uno per l’altro” o “gli uni per gli altri”.
La nostra filosofia, com’è evidente, si concentra sull’individuo. Ma lo fa per portare giovamento conseguente all’intera comunità. Infatti, all’inizio della cultura della CURA DI SÈ (epoca socratica), il lavoro da compiere su se stessi ha il compito di preparare i giovani al governo. La cultura della “epimeleia heautou” cambia solo in epoca romana e diventa un comportamento generale. Nell’Antica Grecia deriva dalla necessità di educare le persone immature e predisporle a diventare classe dirigente.
La cultura filosofica della CURA DI SÈ ha la sua origine nell’idea di ‘servizio alla comunità’. In effetti, Alcibiade (greco: Alkibiádēs, inglese: Alcibiades) è giovane e ambizioso, ma analfabeta e ignorante. A Socrate (greco: Sōkrátēs, inglese: Socrates) bastano poche domande per metterlo alle strette. E, in pochi minuti, lo stesso Alcibiade capisce di aver bisogno di una guida.
Brano suggerito: “All we are” – Warlock (1987) -> ASCOLTA SU YOUTUBE
Apri qui per scegliere cosa fare.
Torna alla home page di SOKRATIKO.IT oppure torna in testa a questa sezione PAROLE G-O oppure torna all’inizio di KOINOS.

Kosmos
“Universo”, realtà ordinata in quanto sottoposta a leggi ineludibili, mondo come organicità del tangibile.
“Kosmos” vuol dire “universo”. Quindi, questo termine greco antico corrisponde al concetto di “mondo”, nel senso di “tutta la nostra realtà”. “Kosmos” è l’opposto di “chaos” (stato di vuoto precedente alla creazione dell’universo). Pertanto – in un discorso filosofico – “kosmos” designa anche l’ordine onnicomprensivo, il “logos“, cioè la legge generale di tutta la realtà. La parola “kosmos” implica, dunque, l’idea dell’universo come un sistema o entità complessa e ordinata.
Il filosofo greco ionico Pitagora (greco: Pythagóras, inglese: Pythagoras) è il primo ad usare la parola “κόσμος” per l’ordine dell’universo. In quel tempo (c. 570 – c. 495 a.C.), il verbo “kosmein” significa normalmente “disporre”, “preparare”. Ma esprime, in particolare, il concetto di <ordinare e sistemare (truppe per la battaglia) e schierare (un esercito)>. Significa anche <insediare (un governo o un regime)>. Inoltre, è l’equivalente di <adornare, abbellire, corredare, vestire> (soprattutto in riferimento alle donne).
Quindi “kosmos” ha anche un senso vicino a <ornamento dell’abito di una donna, abbellimento>. Da questo significato derivano parole come “cosmetici”.

UNA PAROLA PER IL TUTTO
Soltanto dopo molto tempo, il termine entra a far parte del linguaggio moderno, nel XIX secolo. È il geografo e poliedrico Alexander von Humboldt a fare un nuovo uso della parola dal greco antico. La sceglie, infatti, per il suo trattato in cinque volumi “Kosmos”. Il lavoro di von Humboldt influenza la percezione olistica dell’universo visto come un’entità interagente. “Kosmos” (fra le parole della filosofia rock stoica) vuol dire “universo” e la sua versione inglese “cosmos” risale solo al 1848.
La cosmologia è l’esame e lo studio del cosmo. Nella sua accezione più ampia, comprende diversi approcci: scientifico, religioso e pure filosofico. Tutte le cosmologie condividono il compito di comprendere l’ordine dell’essere e della realtà. In questo senso, la maggior parte delle religioni e dei sistemi filosofici ha una propria cosmologia.
Brano suggerito: “Across the universe” – The Beatles (1969) -> ASCOLTA SU YOUTUBE
Apri qui per scegliere cosa fare.
Torna alla home page di SOKRATIKO.IT oppure torna in testa a questa sezione PAROLE G-O oppure torna all’inizio di KOSMOS.

Lexis
“Espressione”, stile del discorso, maniera di parlare, dicitura, modo di dire, tono dell’eloquio.
“Lexis” vuol dire “stile di discorso”. In generale, questa parola del greco antico è l’equivalente di “discorso”, “dizione”, “espressione”.
Il nostro approccio filosofico alla vita quotidiana è diligente, scrupoloso e attento. Pertanto, includiamo il giusto modo di parlare tra le diverse attività da svolgere in piena consapevolezza. In un discorso, infatti, non sono importanti solo i contenuti. Similmente contano lo stile e la raffinatezza espressiva.
Quindi, stare attenti al modo di parlare (cosa diciamo e come lo diciamo) non è questione marginale. In una vita filosofica, anche questo è fondamentale, insieme a molti altri comportamenti, per esempio il modo in cui respiriamo o in cui camminiamo, quello in cui mangiamo o in cui beviamo.
Niente va trascurato. Nemmeno come ridiamo o ci sediamo in poltrona è secondario. Perché la nostra filosofia ci richiede di fare tutto con presenza di spirito e scrupolo. Siffatto imperativo è visibile e valido soprattutto quando lo applichiamo ai piccoli dettagli o a cose apparentemente meno importanti.
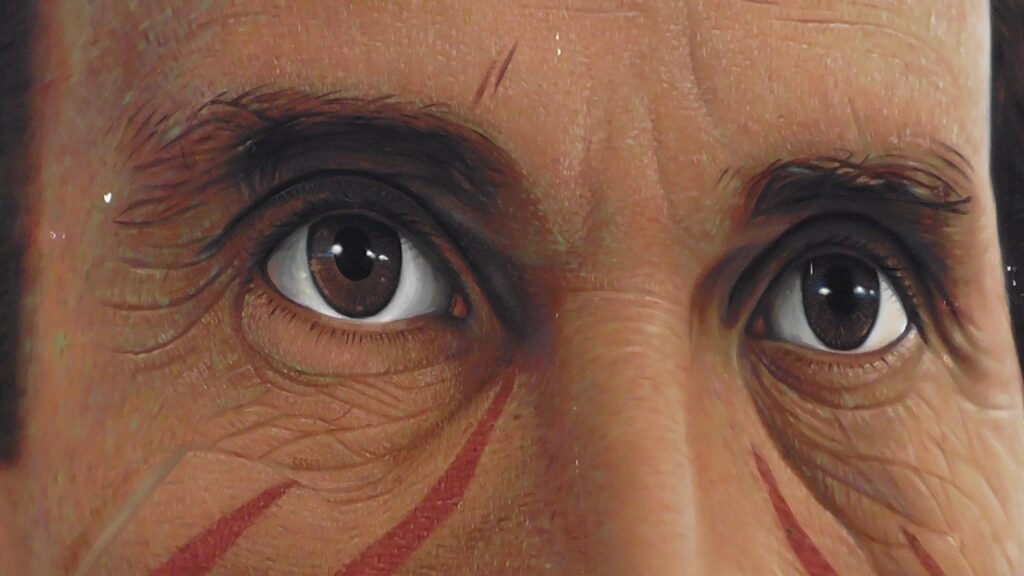
CURA DELL’ESPRESSIONE
Per Platone (greco: Plátōn, inglese: Plato) “lexis” significa “stile di discorso” e ciò include “mimesis” (imitazione) e “diegesis” (narrazione). Secondo Gerard Genette, “la divisione teorica di Platone, contrapponendo i due modi puri ed eterogenei di narrazione e imitazione, all’interno della dizione poetica, suscita e stabilisce una classificazione pratica dei generi. E include le due modalità distinte… e una modalità mista, per esempio quella dell’Iliade“.
Nell’opera “Iliade” (greco: “Iliás“, inglese: “Iliad“), poema epico greco scritto da Omero (greco: Hómēros, inglese: Homer), il ‘modo misto’ è ben presente. Secondo Gerald Prince, la “diegesis“, nell’”Iliade”, non è solo una narrazione di fantasia. In effetti, è associata con il mondo immaginario e la rappresentazione/ri-racconto della storia. Inoltre, la “mimesis” nell’”Iliade” è l’imitazione della vita quotidiana nell’antica Grecia, ma in maniera romanzata. “Diegesis” e “mimesis” insieme rappresentano l’intera gamma coperta dal termine “lexis“ (fra le parole della filosofia rock stoica).
Brano suggerito: “More than words” – Extreme (1991) -> ASCOLTA SU YOUTUBE
Apri qui per scegliere cosa fare.
Torna alla home page di SOKRATIKO.IT oppure torna in testa a questa sezione PAROLE G-O oppure torna all’inizio di LEXIS.

Logos
“Principio generale”, legge universale, regola del tutto, fondamento essenziale, origine e fine in senso complessivo e assoluto.
“Logos” vuol dire “legge universale’”. Altri modi per tradurre questo popolare termine greco antico sono “anima mundi” e “principio regolatore”. Tuttavia, “logos” ha una varietà di altri significati, come “opinione”, “fondamento”, “parola”, “orazione”, “ragione”, “discorso”.
In filosofia, Eraclito (greco: Hērákleitos, inglese: Heraclitus) è forse il primo a usare il termine “logos“. Lo menziona per indicare un (il) principio di ordine e conoscenza. Pertanto, “logos” diventa la parola adottata per trasmettere le idee di ‘natura’, ‘dio’, ‘struttura’.
Per Aristotele (greco: Aristotélēs, inglese: Aristotle) ha i significati di ‘discorso’ e ‘ragione’. Inoltre con “logos” il filosofo di Stagira esprime la nozione di ‘argomento’ in retorica. In questo ambito, “logos” è una delle tre modalità di persuasione insieme a “ethos” e “pathos“.

LA RAGIONE SEMINALE
Gli stoici chiamano “logos spermatikos” (ragione seminale) il principio generativo dell’universo. Tale nozione viene poi ripresa dal Neoplatonismo.
Filone importa il termine “logos” nella filosofia ebraica distinguendo tra “logos prophorikos” (discorso pronunciato) e “logos endiathetos” (discorso interiore).
Il Vangelo di Giovanni qualifica come divino il “logos” attraverso cui tutte le cose esistono e identifica inoltre Gesù Cristo con il “logos” incarnato.
Il termine è presente anche nel Sufismo e nella psicologia analitica di Carl Gustav Jung.
Nonostante la traduzione convenzionale con “parola”, per noi “logos” (fra le parole della filosofia rock stoica) vuol dire soprattutto “legge universale”. Infatti, per indicare “parola” in senso grammaticale, non usiamo “logos“, ma il termine “lexis“. Ad ogni modo, “logos” e “lexis” derivano entrambi da “légō“ il cui significato è ‘contare’, raccontare’, ‘dire’, ‘parlare’.
Brano suggerito: “The logical song” – Scooter (1979) -> ASCOLTA SU YOUTUBE
Apri qui per scegliere cosa fare.
Torna alla home page di SOKRATIKO.IT oppure torna in testa a questa sezione PAROLE G-O oppure torna all’inizio di LOGOS.
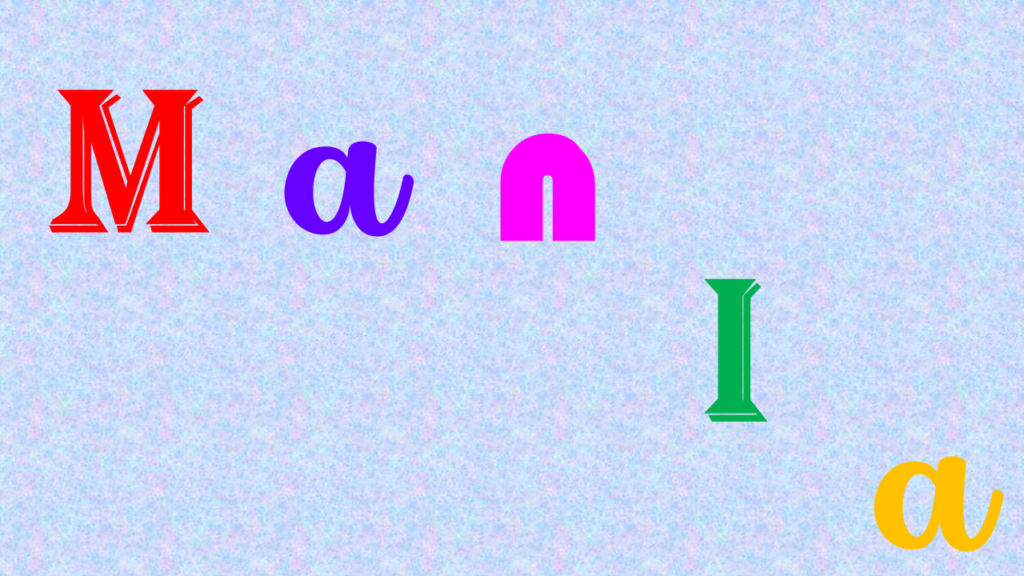
Mania
“Follia divina”, stato di ispirazione sovrannaturale, ossessione maniacale, alienazione intesa anche con risvolti positivi, creativi e introspettivi.
“Mania” vuol dire “follia divina”. Per molti filosofi dei tempi antichi, la ‘follia ispirata’ espressa dal termine “mania” implica aspetti positivi così come negativi. Oggi la parola “mania” ha significati decisamente diversi.
Platone (greco: Plátōn, inglese: Plato) identifica quattro tipi di “mania“. E i loro rispettivi trattamenti sono associati alla divinità considerata responsabile di ciascun particolare tipo.
“Theia mania” è il termine usato da Socrate (greco: Sōkrátēs, inglese: Socrates) e Platone. Si riferisce a una comportamento insolito dovuto all’azione di un dio. Nel dialogo intitolato “Fedro“, Socrate (greco: Sōkrátēs, inglese: Socrates) descrive lo stato di ispirazione divina. “Nelle famiglie dove si accumulano vaste ricchezze ci sono terribili piaghe e afflizioni dell’anima. Comunque, la “mania” offre un rimedio, nella misura in cui è un dono degli dei, purché si sia adeguatamente indemoniati e posseduti nel corso dei corretti rituali di espiazione“.
Nello stesso dialogo, si trova un altro passaggio in tal senso: “in realtà, le cose migliori ci sono venute dalla “mania””. Uno sviluppo di questo concetto è presente in un altro dialogo: “Ione“. Nelle culture orientali, la “mania” è un catalizzatore e un mezzo per la comprensione profonda delle dimensioni spirituali.

MANIA COME ISPIRAZIONE SOVRANNATURALE
Secondo il poeta Virgilio, nel Libro VI dell’”Eneide“, la Sibilla cumana effettua le sue profezie in uno stato maniacale. “Il suo viso cambia colore. Le sue ciocche attorcigliate fluiscono liberamente. Il seno ansante si gonfia del sangue selvaggio del suo cuore. La sua statura sembra più elevata. Il suo linguaggio oltre l’umano“.
In conclusione, dobbiamo citare, in relazione alla follia divina nella Antica Grecia, le Menadi (o Baccanti). Queste donne sperimentano una forte forma di follia spirituale da attribuire all’intervento del dio Dioniso.
“Mania” (fra le parole della filosofia rock stoica) vuol dire “follia divina”. E nel mondo classico, “l’amore a prima vista” s’inserisce nella cornice dell’idea generale di amore appassionato, una sorta di follia.
Brano suggerito: “Maniac” – Michael Sembello (1983) -> ASCOLTA SU YOUTUBE
Apri qui per scegliere cosa fare.
Torna alla home page di SOKRATIKO.IT oppure torna in testa a questa sezione PAROLE G-O oppure torna all’inizio di MANIA.

Noesis
“Intuizione profonda”, forma di conoscenza tramite cui l’anima entra in contatto e compenetrazione originaria con la realtà.
“Noesis” vuol dire “intuizione profonda”. Distinta dal sapere discorsivo e conseguenziale della “dianoia” e opposta alla “doxa“, ossia all’opinione (conoscenza comune superficiale), la ‘conoscenza noetica’ per Platone (greco: Plátōn, inglese: Plato) è il grado più alto del sapere nel quadro delle conoscenze ottenibili tramite l’anima (oggi l’anima è la ‘mente’).
La “noesis” può anche essere definita come forma di conoscenza assoluta, non mediata e primigenia. Una conoscenza non prensile (cioè non di un soggetto conoscente il quale ‘prende’ l’oggetto da conoscere, lo afferra con la propria anima, lo possiede con la mente), ma fatta di ‘fusione’ fra soggetto e oggetto in modo da annullare, di fatto, il dualismo stesso di soggetto e oggetto. E’ la conoscenza degli animali i quali stanno nella realtà, sono immersi nella verità (senza bisogno di studiarla, esaminarla, comprenderla discorsivamente). “Noesis” (fra le parole della filosofia rock stoica) vuol dire “intuizione profonda”, la quale chiama in causa il “nous“, l’intelletto puro, la facoltà più ampia, naturale e potente dell’essere umano. In questo senso il “nous” è assimilabile alla spiritualità intesa come verità naturale e universalmente integrata dell’individuo.
Brano suggerito: “Intuition” – John Lennon (1973) -> ASCOLTA SU YOUTUBE
Apri qui per scegliere cosa fare.
Torna alla home page di SOKRATIKO.IT oppure torna in testa a questa sezione PAROLE G-O oppure torna all’inizio di NOESIS.
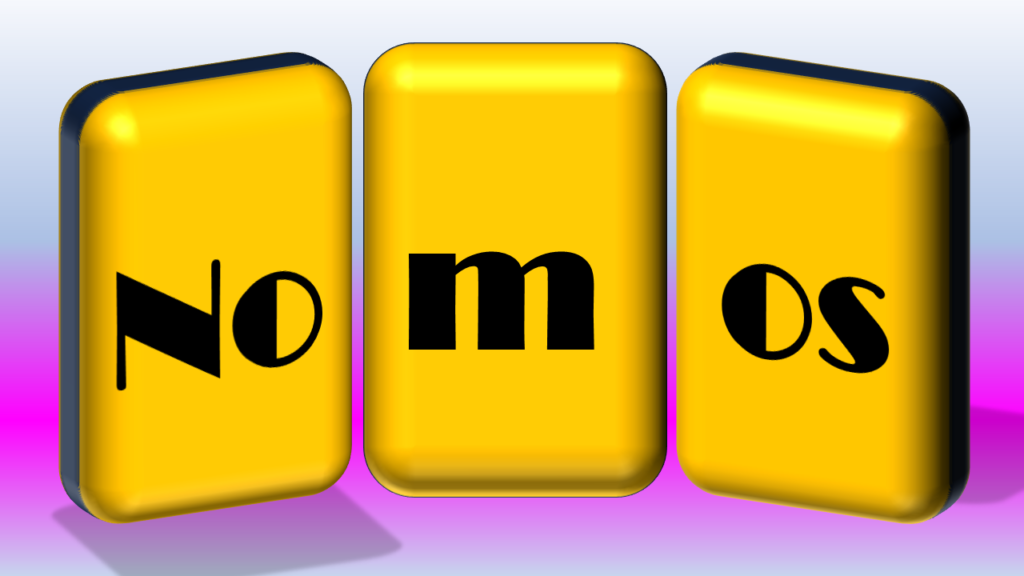
Nomos
“Legge”, principio regolatore, ordine., spirito delle leggi, degli statuti e delle ordinanze.
“Nomos” vuol dire “legge”. Inoltre, questa antica parola greca significa ‘diritto’ (in senso giuridico), ‘consuetudine’, ‘regola’, ‘ordine’.
Nella Grecia precristiana, ci sono intense discussioni intorno al contrasto tra “physis” (natura) e “nomos” (diritto). Tuttora, l’opposizione tra il ‘naturale’ e il ‘prodotto umano’ rappresenta una delle questioni centrali dei dibattiti politici, sociali e filosofici.
Tra i tanti argomenti della disputa, spicca la domanda se la giustizia sia solo un insieme di regole arbitrarie di origine strettamente umana.
Secondo alcuni pensatori la legge ha (o dovrebbe avere) una base ‘oggettiva’ in natura. Pertanto, essa non potrebbe essere interamente e solo una ‘invenzione’ umana. Da ciò, però, sorgerebbe la possibilità di non obbedire ad alcune leggi. Per esempio, una norma potrebbe essere ignorata quando ritenuta in conflitto con bisogni, desideri e comportamenti naturali.

LO SPIRITO DELLA LEGGE
“Nomos” (fra le parole della filosofia rock stoica) vuol dire “legge”. Nell’antica religione greca Nomos è un’entità sovrannaturale. Quindi, la parola indicherebbe più il “logos” (il principio assoluto) della legge anziché la legge stessa. Ci riferiamo proprio allo spirito della legge, ai suoi motivi ispiratori, all’anima profonda della legge. In altri termini, stiamo parlando della forza implicita e dell’essenza ideale di una legge o di un intero sistema di leggi.
Un altro uso del termine “nomos” esprime l’idea della creazione del diritto umano nell’antica Grecia. Come è facile immaginare, produrre un insieme di leggi comporta una complessa operazione. Secondo l’antica visione mitologica, la moglie di Nomos è Eusebia (Pietà), e la loro figlia è Dike (Giustizia). Dalla combinazione di spiritualità (pietà) e diritto (“nomos“) deriva, pertanto, una nozione di giustizia piuttosto chiara.
Brano suggerito: “Long arm of the law” – Kenny Rogers (2010) -> ASCOLTA SU YOUTUBE
Apri qui per scegliere cosa fare.
Torna alla home page di SOKRATIKO.IT oppure torna in testa a questa sezione PAROLE G-O oppure torna all’inizio di NOMOS.

Oiesis
“Eccesso di autostima”, autoesaltazione, presunzione, esagerata sicurezza di sé, sovrabbondante fiducia in sé stessi.
“Oiesis” vuol dire “eccesso di autostima”. Altre traduzioni di questa antica parola greca sono ‘vanità’, ‘autoammirazione’, ‘presunzione’, ‘autoinganno’, ‘illusione’ e pure ‘opinione arrogante’.
Secondo Epitteto (greco: Epíktētos, inglese: Epictetus), il nostro compito principale è di rimuovere da noi stessi l’autoinganno e la diffidenza (“apistia“).
Eraclito (greco: Hērákleitos, inglese: Heraclitus) descrive l’autoinganno come “una terribile malattia” (citato in “Vite di eminenti filosofi”, 9.7 di Diogene Laerzio). Inoltre, gli stoici mettono a disposizione i loro ‘esercizi’ per testare e superare le autoillusioni. Pertanto, “oiesis” non gode di una buona reputazione tra i pensatori ai quali qui si fa riferimento. Una delle priorità della nostra ‘scuola filosofica’ è, infatti, la consapevolezza di sé e non l’autostima. In altri termini, dobbiamo lavorare su noi stessi non per far crescere il nostro ego, ma per prenderci cura della nostra vita (“epimeleia heautou“).
Non sempre è semplice distinguere tra CURA DI SÉ e autostima. Quindi, il supporto (in questa operazione analitica) da parte di un filosofo saggio potrebbe essere indispensabile. In ogni caso, è fondamentale mantenere l’attenzione puntata sull’anima senza incorrere in autocompiacimenti di qualsiasi sorta. L’umiltà e la decenza sono valori da conservare e tutelare in ogni circostanza.

FRENARE L’ALTA OPINIONE DI SÉ
“Oiesis” (fra le parole della filosofia rock stoica) vuol dire “eccesso di autostima”. Tale atteggiamento ha bisogno di una correzione, di un contrappeso, di una visione critica di sé da contemplare negli ‘esercizi per l’anima’ (“askesis“). L’esame dei propri difetti è importante, non solo per ragioni etiche, ma anche per la propria sopravvivenza.
Le persone con ego straripante, infatti, cadono improvvisamente in disgrazia. Perdono facilmente il senso della realtà illudendosi di poter compiere qualsiasi azione, senza rendersi conto di come stanno davvero le cose. Una tale interpretazione della realtà quotidiana, il più delle volte, diventa per loro una trappola in cui alla fine precipitano inconsapevolmente.
Per guarire da una malattia bisogna innanzitutto avere la consapevolezza di essere malati. Poi, è fondamentale individuare le caratteristiche del male da cui si è afflitti. Infine, bisogna conoscere la cura e adottarla. Lo stesso vale per l’ipertrofia dell’ego. Si deve riconoscere il proprio stato di imperfezione, attribuirlo a un ‘eccesso di autostima’ e quindi cominciare a rimettere i piedi per terra.
Brano suggerito: “Self esteem” – The Offspring (1994) -> ASCOLTA SU YOUTUBE
Apri qui per scegliere cosa fare.
Torna alla home page di SOKRATIKO.IT oppure torna in testa a questa sezione PAROLE G-O oppure torna all’inizio di OIESIS.

Oikeiosis
“Autopercezione”, possesso di sé, familiarità con sé, pienezza realizzata di sé, acquisizione percettiva del proprio essere.
“Oikeiosis” vuol dire “autopossesso”. Altre possibili traduzioni sono ‘appropriazione di sé’, ‘orientamento verso sé’, ‘familiarità con sé’, ‘affinità’, ‘affiliazione’ e persino ‘affetto’. In latino, equivale a “conciliatio“. Tuttavia, nel nostro discorso filosofico di orientamento stoico, “oikeiosis” indica il percepire pienamente sé stessi come fattore di autorealizzazione, fine ultimo degli esseri viventi.
L’origine di questa nozione risale all’opera del filosofo stoico Zenone di Cizio (greco: Zḕnōn ho Kitièus, inglese: Zeno of Citium). Inoltre, un altro pensatore stoico, Ierocle (greco: Hieroklês, inglese: Hierocles), vede nella “oikeiosis” la base di tutti gli impulsi animali così come dell’etica umana.
Nei suoi “Elementi di etica”, Ierocle riflette sulla vita degli animali. Nella prima fase della percezione, un animale ha coscienza del suo corpo. Inoltre, riconosce le sue sensazioni come ‘appartenenti a se stesso’. Tale consapevolezza è “proton oikeion“, cioè <la prima cosa propria e familiare>. È costante e al tempo stesso deriva dalla percezione degli oggetti esterni. Per Ierocle, questo fenomeno spiega perché i bambini hanno paura del buio. Il loro debole “senso di sé” teme la morte quando non siano presenti entità esterne a sé stessi.

PERCEPIRSI E APPARTENERSI
Secondo Ierocle, l’impulso di autoconservazione deriva da “oikeiosis“. “Un animale, quando avverte la prima percezione di se stesso, diventa subito padrone di se stesso nonché familiare a se stesso e alla propria costituzione”. Nel percepirsi e nel familiarizzare con sé, un animale trova valore in se stesso e nel proprio benessere.
“Oikeiosis“(fra le parole della filosofia rock stoica) vuol dire ‘auto-possesso’. Ierocle distingue i vari tipi di “oikeiosis” tra interni ed esterni. Quelli interni includono l’appropriazione del sé così come della propria costituzione. Le forme esterne includono la familiarizzazione con altre persone e un orientamento verso i beni esterni.
Brano suggerito: “Feel yourself” – Flamingosis ft. Marc Rebillet (2024) -> ASCOLTA SU YOUTUBE
Apri qui per scegliere cosa fare.
Torna alla home page di SOKRATIKO.IT oppure torna in testa a questa sezione PAROLE G-O oppure torna all’inizio di OIKEIOSIS.

Orexis
“Inclinazione”, desiderio, proiezione verso un bene possibile, voglia, processo di orientamento verso qualcosa o qualcuno.
“Orexis” vuol dire “desiderio”. Questa antica parola greca esprime l’inclinazione verso una cosa, l’appetizione, la brama, il desiderio per quella cosa. “Orexis” è in contrasto con “ekklisis” (avversione).
In Aristotele (greco: Aristotélēs, inglese: Aristotle), il termine indica la voglia, la bramosia, il desiderio intenso e fremente condiviso dall’uomo con gli animali. Quindi, si differenzia dalla scelta intenzionale (“prohairesis“) ossia da una funzione tipicamente umana, basata sul discernimento, non presente negli altri animali. La “prohairesis“, infatti, coinvolge tanto la capacità di ragionare quanto la capacità di deliberare.
Il binomio “orexis“/”ekklisis” è il primo dei tre “topoi“, da considerare “aree di allenamento filosofico” (“askesis“), volte a produrre coerenza e consapevolezza negli individui. Gli altri due “topoi” sono il binomio “horme“/”aphorme” (azione/inazione) e l’impegno mentale/etico rappresentato dal termine “synkatathesis” (giudizio, valutazione, assessment).

COMPLESSITA’ DELLE ATTIVITA’ PSICHICHE
Gli stoici indicano rispettivamente “pathos” (passione spontanea e incontrollata) ed “eupathos” (passione governata e armoniosa) come un esempio irrazionale (“alogon“) e uno razionale (“eulogon“) di quattro tipi di movimento psichico (“kineseis“).
Ecco uno schema riguardante le attività dell’anima al cospetto di cose positive o negative.
Innanzitutto, “inclinazione” (“orexis“) in risposta a un apparente bene potenziale.
Secondo, “avversione” (“ekklisis“) in risposta a un apparente male potenziale.
Terzo, “proiezione” (“eparsis“) in risposta a un apparente bene presente.
Quarto, “contrazione” (“sustole“) in risposta a un apparente male presente.
“Orexis“(fra le parole della filosofia rock stoica) vuol dire “desiderio”, ma la nozione di desiderio non è facile da definire e richiede alcune esperienze pratiche.
Secondo Margaret Graver (2007), i quattro movimenti esemplificati dagli stoici sono “risposte affettive”. Per altri studiosi, tuttavia, solo le “proiezioni” e “contrazioni” psichiche corrispondono a risposte affettive. Apparirebbero, dunque, come il risultato del successo o del fallimento di “orexis” ed “ekklisis“. Pertanto “orexis” ed “ekklisis” rappresentano, secondo tali studiosi, impulsi più puramente comportamentali di ricerca ed evitamento.
Questo argomento è molto complesso anche per gli accademici ed è difficile da approfondire in sede divulgativa.
Brano suggerito: “Inclination” – Marsh Kids (2014) -> ASCOLTA SU YOUTUBE
Apri qui per scegliere cosa fare.
Torna alla home page di SOKRATIKO.IT oppure torna in testa a questa sezione PAROLE G-O oppure torna all’inizio di OREXIS.
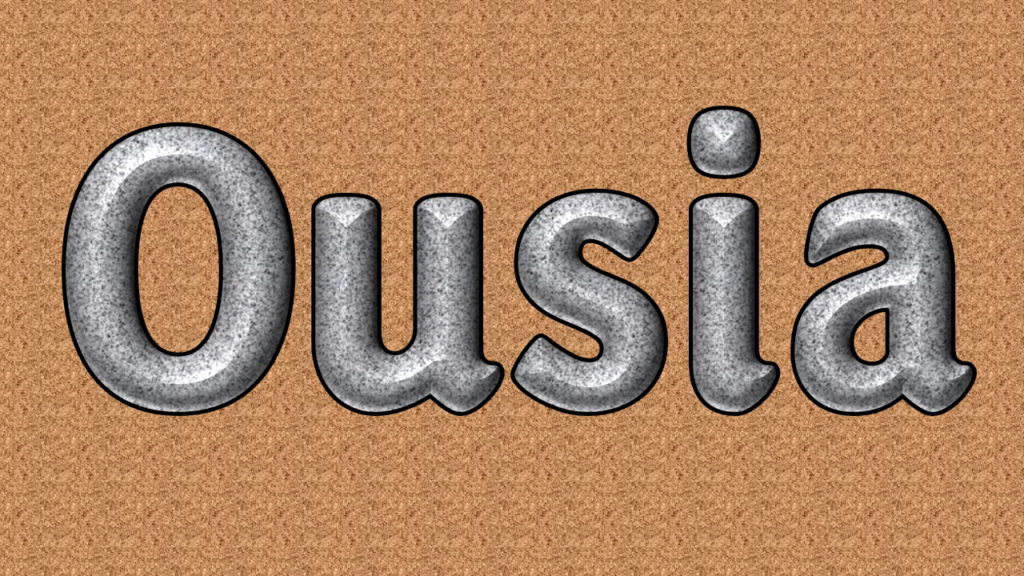
Ousia
“Essenza”, ‘essere’ (nel senso di materia perdurante al di là delle qualificazioni contingenti), fondamento immutabile alla base di ciò che è.
“Ousia” vuol dire “essenza” o “essere”, ma non esattamente ‘sostanza’. L’antica parola greca “ousia” è usata da filosofi come Platone (greco: Plátōn, inglese: Plato) e Aristotele (greco: Aristotélēs, inglese: Aristotle), per esprimere le nozioni di “essenza” o “essere”. Successivamente, il termine corrisponde alle parole latine “essentia” o “substantia“.
Nella filosofia contemporanea, la parola “ousia” è prevalentemente usata per i concetti di “essere” e “ontico”.
La questione riguardante “essere” ed “essenza” è una delle più coinvolgenti e stimolanti della filosofia. Per spiegare il problema, prendiamo un colore, per esempio il ‘rosso’. Quando indichiamo un colore, lo designiamo per associazione. Infatti, diciamo “una fragola è rossa”, “un pomodoro è rosso”, “il sangue è rosso”, “la Ferrari è rossa”. Ma cos’è il ‘rosso’ stesso? Difficile dirlo. Ci limitiamo a indicare alcune cose come rosse. Ma non diciamo mai ‘cosa è il rosso’ se non tramite accostamenti, esempi, abbinamenti.
Ebbene, “ousia” riguarda la risposta alla domanda “cosa è l’essere” (nel nostro caso: “cosa è il rosso”) quando la domanda è mirata e non ammette associazioni. Nel nostro esempio, cerchiamo la “ousia” (l’essenza) del rosso.
QUESTIONE DI LONTANISSIMA PROVENIENZA
Secondo Martin Heidegger, il significato originale della parola “ousia” si è perso nella sua traduzione in latino e, di conseguenza, anche nelle successive lingue moderne. Per il filosofo tedesco, “ousia” significherebbe proprio “essere”, non “sostanza” intesa quest’ultima come qualche ‘cosa’ o qualche ‘essere’ “soggiacente” (sostanza deriva da sub-stare ossia ‘stare sotto’). Inoltre, Heidegger usa il binomio “parusia“/”apousia“, per denotare ‘presenza’/’assenza’, e ricorre a “hypostasis” per indicare ‘esistenza’.

“Ousia“(fra le parole della filosofia rock stoica) vuol dire “essenza” o “essere”, due concetti filosofici e teologici molto importanti e dibattuti. La parola, infatti, è in uso anche tra i teologi cristiani. Il motivo si capisce facilmente. Se non c’è una “essenza”, al di là delle qualifiche, degli accidenti e delle contingenze, allora la realtà è sempre e solo incessante variazione e impermanenza. Per esempio, una specifica pietra sarebbe solo la somma di momenti diversi di una entità solida, inafferrabile in perenne trasformazione.
Brano suggerito: “Gist” – Lil Tecca (2023) -> ASCOLTA SU YOUTUBE
Apri qui per scegliere cosa fare.
Torna alla home page di SOKRATIKO.IT oppure torna in testa a questa sezione PAROLE G-O oppure torna all’inizio di OUSIA.
