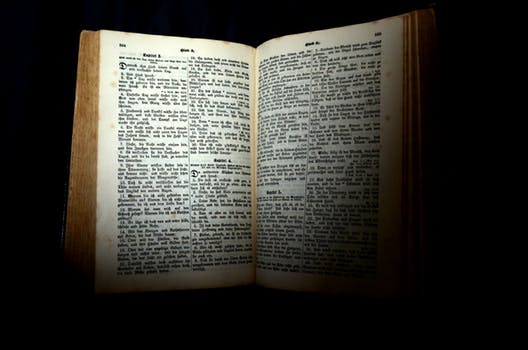
Parole P-Z
Le parole P-Z della filosofia rock stoica sono strumenti per pensare e parlare. Ecco alcune delle più importanti parole filosofiche (dalla P alla Z) scelte nel repertorio originale della lingua greca antica e spiegate a modo nostro.
Qui l’elenco delle parole presenti in questa sezione.
Philia (vedi la sottovoce Philia nella sezione ARGOMENTI alla voce Affectus).
Philautia (vedi la sottovoce Philautia nella sezione ARGOMENTI alla voce Affectus).
Pothos (vedi la sottovoce Pothos nella sezione ARGOMENTI alla voce Affectus).
Pragma (vedi la sottovoce Pragma nella sezione ARGOMENTI alla voce Affectus).
Storge (vedi la sottovoce Storge nella sezione ARGOMENTI alla voce Affectus).
Thelema (vedi la sottovoce Thelema nella sezione ARGOMENTI alla voce Affectus).
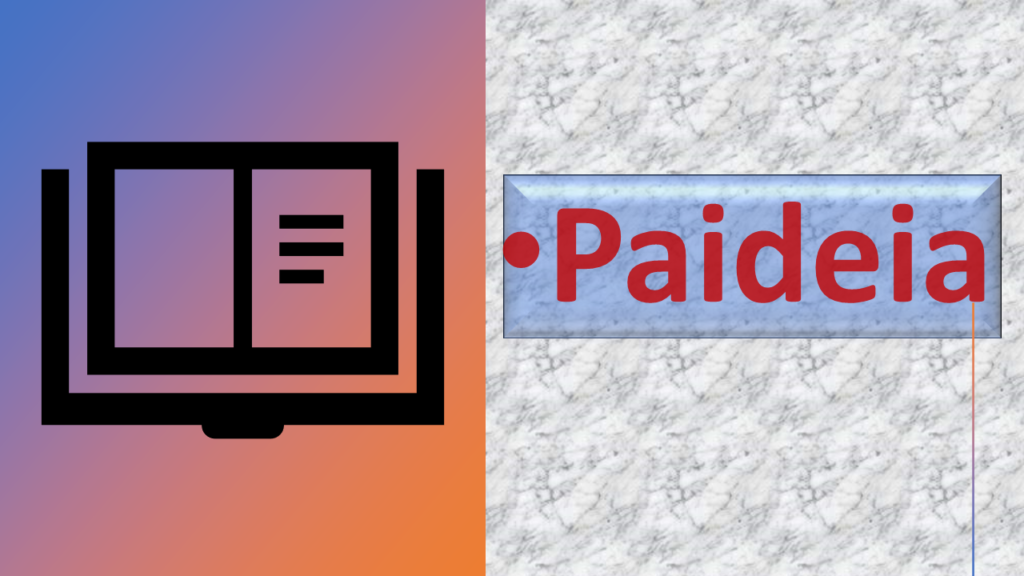
Paideia
“Istruzione”, educazione, insegnamento, formazione intesa anche in un senso integrale concernente la generalità del soggetto.
“Paideia” vuol dire “insegnamento”. L’idioma sta anche a significare ‘formazione scolastica’, ‘didattica’, ‘esercitazione’, ‘insegnamento’, ‘addestramento’, ‘scolarizzazione’, ‘istruzione’. Si riferisce, in particolare, all’educazione ideale dei giovani nell’antica Grecia. E’ un modello pedagogico comprensivo di tutoraggio pratico e di socializzazione all’interno dell’ordine aristocratico della “polis” (città-stato).
Infatti, un membro ideale della “polis” dovrebbe avere raffinatezza intellettuale, morale e fisica. Quindi, l’allenamento in ginnastica è indispensabile. Ma non meno indispensabile è un addestramento nel campo dell’educazione morale.
Per gli antichi greci, questa ‘educazione morale’ deriva dalla musica, dalla poesia e dalla filosofia. Secondo loro, occorre “essere sempre preminenti”. E questa è la nozione di “aretè” (virtù), ideale cardine di tutta la cultura greca.
Il concetto di “aretè” è in stretta relazione con il modello eroico, cioè con l’idea di un individuo di valore da stimare, rispettare e imitare. Secondo il classicista Werner Wilhelm Jaeger (“Paideia” II.56), la virtù, per i greci, consiste nella capacità di “tenere testa con le sole mani a nemici, ai mostri e ai pericoli di ogni tipo, uscendone vittoriosi“.
Questa mentalità spiega la cura dei greci stessi nel riprodurre e copiare solo la letteratura da loro considerata come “la migliore”.
Lo stesso spirito di emulazione si applica anche ai valori agonistici dei giochi olimpici. E, inoltre, all’arte in generale, grazie ai concorsi di poesia, tragedia e commedia, utili per favorirlo. “Aretè” e desiderio del primato sono evidenti in tutte le attività dei greci.

ISTRUZIONE IN NOME DELLA VIRTÙ
“Paideia“(fra le parole della filosofia rock stoica) vuol dire “insegnamento”. Da qui nasce l’idea di un’educazione in grado di promuovere, soprattutto nei giovani, l’eccellenza. Di conseguenza, diversi filosofi greci rendono disponibile il loro sapere fondando scuole e luoghi di apprendimento. Per esempio, sono molto importanti quelle create da Isocrate (greco: Isokrátēs, inglese: Isocrates) e Platone (greco: Platon, inglese: Plato), caratterizzate entrambe dal rifiuto del modello di educazione imperante ai loro tempi.
Nel suo “Antidosis”, Isocrate si difende dalle accuse secondo cui la formazione sarebbe un modo per traviare le persone. Al contrario, secondo lui, la didattica è fondamentale per creare una società equa. Ma le sue idee, nello specifico, sono in disaccordo con quelle di Platone. In “Contro i Sofisti”, Isocrate ha in mente “personaggi” come Platone, Gorgia (greco: Gorghías, inglese: Gorgias) e Protagora (greco: Prōtagóras, inglese: Protagoras) e imposta il suo ideale di “paideia” in contrasto con il loro.
Brano suggerito: “Adult education” – Daryl Hall & John Oates (1984) -> ASCOLTA SU YOUTUBE
Apri qui per scegliere cosa fare.
Torna alla home page di SOKRATIKO.IT oppure torna in testa a questa sezione PAROLE P-Z oppure torna all’inizio di PAIDEIA.

Parresia
“Parlar franco in circostanze rischiose”, esprimersi con franchezza sui potenti in loro presenza, dire chiaro e tondo il proprio pensiero su fatti, cose e persone.
“Parresia” vuol dire “franchezza verbale in circostanze rischiose”. Questo antico sostantivo greco si riferisce, per esempio, al parlare liberamente (in modo critico e senza riserve) di tiranni e dittatori, in loro presenza, quindi assumendosi rischi molto seri se non proprio mortali.
“Parresiaste” è chi pratica tale virtù, spingendosi fino al punto di mettere in gioco la propria vita in nome della franchezza. In effetti, non c’è nulla di ‘prezioso’ nel parlar franco se l’oratore non si espone a qualche pericolo a causa di tale comportamento. Nell’azione stessa della “parresia” l’individuo parlante dimostra personalità, forza d’animo e coraggio. Tutti questi tratti sono anche prove evidenti del suo autentico atteggiamento filosofico.

PARRESIA E ANDREIA
“Parresia“(fra le parole della filosofia rock stoica) vuol dire “franchezza verbale in circostanze rischiose”. Non è però una specifica forma di “andreia” (“coraggio”) come fosse un’applicazione del coraggio nel campo dell’oratoria. “Parresia” è qualcosa di diverso, qualcosa per cui sono richieste qualità differenti.
Per esempio, un giovane soldato potrebbe mostrarsi impavido lanciandosi nel bel mezzo di una violenta battaglia. Ma lo stesso soldato potrebbe avere qualche problema a criticare apertamente il proprio comandante. Questo accade perché è un soldato leale, addestrato a non mancare di rispetto ai suoi superiori. Inoltre, la schiettezza richiede uno stato d’animo articolato e un notevole livello di maturità. Non basta avere il coraggio di criticare un re, ma è necessario farlo senza tremare o mostrare alcun altro segno di timore.
Brano suggerito: “Straight talking” – Sheena Easton (1984) -> ASCOLTA SU YOUTUBE
Apri qui per scegliere cosa fare.
Torna alla home page di SOKRATIKO.IT oppure torna in testa a questa sezione PAROLE P-Z oppure torna all’inizio di PARRESIA.

Pathos
“Passione”, affezione, sentimento, turbamento, emozione, impressione, stato d’animo importante anche se talvolta passeggero.
“Pathos” vuol dire “passione”. L’antico idioma greco indica anche ‘emozione’ o una delle condizioni conseguenti a “horme“. Infatti, “horme” sta per “impulso” e, normalmente, un’emozione, un’affezione o un sentimento (“pathos“) viene dopo un impulso.
Per esempio, potrei avere ‘l’impulso’ (“horme“) di godermi un gelato. Seguendo tale ‘impulso’ forse proverei un “pathos” quale la nostalgia (magari pensando a un gelato assaporato in una piacevole circostanza del passato). Oppure mi troverei a fare i conti con un “pathos” di frustrazione perché non c’è nessun gelataio disponibile a portata di mano.
Molti filosofi rivelano profonda preoccupazione nei confronti delle passioni e delle emozioni. Gli stoici, in particolare, considerano i sentimenti e le sensazioni molto pericolosi quando non sono sotto controllo. Di solito gli affetti sono forti e, quindi, abbastanza impetuosi da far deragliare la condotta umana dalla prudenza, dalla giustizia, dalla temperanza e dalla fortezza (le quattro virtù cardinali). Per questo sono temibili.

PERICOLI DELLE PASSIONI
Gli avvertimenti dei filosofi contro i pericoli delle passioni sono sempre vigorosi. E poi ci sono le loro insistenti raccomandazioni affinché gli individui si dedichino a un allenamento serio (“askesis“) per raggiungere il livello più alto possibile di autocontrollo.
“Pathos“(fra le parole della filosofia rock stoica) vuol dire “passione”. Ma gestire le passioni non significa né sedarle né annullarle. In effetti, è perfettamente accettabile provare sentimenti intensi, dimostrando la propria vitalità. Inaccettabile è essere governati dalle passioni, come quando, per esempio, facciamo qualcosa spinti dalle nostre emozioni nonostante il nostro intelletto riconosca ciò come sbagliato.
Per il sofista Gorgia (greco: Gorghías, inglese: Gorgias), gli oratori catturano l’uditorio e lo conducono in qualsiasi direzione proprio usando il “pathos“. Come scrive in “Encomio di Elena”, le persone provano sentimenti specifici a causa di alcune parole. Certi termini portano piacere e altri arrecano dolore. “Proprio come farmaci diversi eliminano umori diversi dal corpo e alcuni mettono fine alle malattie o alla vita, così fanno i discorsi. Alcuni danno dolore, altri deliziano, altri terrorizzano, altri ispirano gli uditori al coraggio, e altri ancora con una certa vile persuasione drogano e ingannano l’anima“.
Brano suggerito: “Passion” – Rod Stewart (1980) -> ASCOLTA SU YOUTUBE
Apri qui per scegliere cosa fare.
Torna alla home page di SOKRATIKO.IT oppure torna in testa a questa sezione PAROLE P-Z oppure torna all’inizio di PATHOS.

Phantasia
“Apparenza”, impressione, rappresentazione mentale di qualcosa, di un concetto, di un ricordo.
“Phantasia” vuol dire “apparenza”. In greco antico, la parola significa anche ‘impressione’, cioè ‘informazione derivante da esperienza sensoriale’, ‘percezione’, ‘rappresentazione’.
Platone (greco: Platon, inglese: Plato) descrive “phantasia” come una miscela di percezione e opinione (quest’ultima, da sola, è “doxa“). Così facendo, aggiunge un elemento mentale alle percezioni derivanti solo dalla ‘esperienza sensoriale’. In effetti, le “opinioni” sono prodotti della nostra mente, mentre le percezioni nascono dai sensi. Tuttavia, le opinioni appartengono a un’area della nostra ‘mente’ (o possiamo dire ‘anima’) non del tutto logica e razionale.
In modo analogo, Aristotele (greco: Aristotélēs, inglese: Aristotle) pone la “phantasia” tra percezione e pensiero.
Secondo Epitteto (greco: Epíktētos, inglese: Epictetus) il compito di una persona buona ed eccellente è gestire le impressioni (“phantasiai“) in armonia con la natura.

IMPRESSIONI COME PRIMA RISPOSTA COGNITIVA
“Phantasia“(fra le parole della filosofia rock stoica) vuol dire “apparenza”. In particolare, per gli stoici, “phantasiai” sono valutazioni precognitive derivanti dalle nostre precedenti esperienze o dal nostro pensiero subconscio. Infatti, nello Stoicismo, le attività psicologiche, come il consenso mentale, la cognizione, l’impulso e la conoscenza, sono tutte estensioni (o risposte) a “phantasiai“. Zenone di Cizio (greco: Zḕnōn ho Kitièus, inglese: Zeno of Citium) descrive una “phantasia” come un’impressione (“tuposis“) avente luogo nell’”hegemonikon” (facoltà di comando).
I sensi, come sostiene Zenone, imprimono una sorta di impronta sull’anima, più o meno come un ‘anello con sigillo’ imprime la forma su una morbida cera.
Per gli stoici, alcune “phantasiai” ricevono il consenso mentre altre no. L’accettazione avviene quando l’anima considera una “apparenza” come vera. Per esempio, una opinione (“doxa“) è una credenza debole o falsa, pertanto i saggi evitano di darle consenso, semplicemente trattenendo l’approvazione finché la situazione non si chiarisce.
Tuttavia, è possibile percepire alcune “phantasiai” in circostanze abbastanza chiare, tali da far concludere a favore della loro autenticità. Queste sono “kataleptike” (adatte a comprendere). Quindi, le “kataleptike phantasiai” ottengono il nostro assenso in virtù della loro chiarezza. E rappresentano il criterio della verità.
Brano suggerito: “Fantastic” – Joe Strummer & The Mescaleros -> ASCOLTA SU YOUTUBE
Apri qui per scegliere cosa fare.
Torna alla home page di SOKRATIKO.IT oppure torna in testa a questa sezione PAROLE P-Z oppure torna all’inizio di PHANTASIA.

Phronesis
“Saggezza in atto”, agire filosofico, sapienza pratica, forma di conoscenza in grado di indirizzare nel modo migliore le scelte dell’individuo.
“Phronesis” vuol dire “saggezza pratica”. È una delle quattro virtù cardinali della antica filosofia greca a cui si riferisce questo sito. Le altre tre virtù cardinali sono giustizia (“dikayosine“), temperanza (“sōphrosynē“) e fortezza (“andreia“).
“Sophia” è un altro termine greco per “phronesis“, mentre in latino ci sono due parole per esprimere, più o meno, la stessa nozione: “prudentia” e “sapientia“.
Da alcuni testi di Platone (greco: Platon, inglese: Plato), apprendiamo la posizione di Socrate (greco: Sōkrátēs, inglese: Socrates): per lui, esercitare la “phronesis” è un’attività virtuosa. Pertanto, “phronesis” è una virtù e tutte le virtù sono forme di “phronesis“. Essere buoni significa essere una persona intelligente e ragionevole con pensieri intelligenti e ragionevoli. “Phronesis” (fra le parole della filosofia rock stoica) garantisce a chi la possiede una rimarchevole forza morale.
Nel “Menone” di Platone, Socrate illustra in che modo “phronesis“, intesa come ‘comprensione filosofica della realtà’, sia la qualità più importante. Spiega come questa virtù non possa essere insegnata singolarmente perché è l’obiettivo finale di un intero processo di auto-comprensione, di lavoro su di sé, di elaborazione filosofica. Certamente un maestro potrebbe essere d’aiuto, ma la ‘ricerca dell’anima’ dovrebbe essere sempre una operazione individuale e personale.

SAGGEZZA: CONDIZIONE E OBBIETTIVO DELLA VITA FILOSOFICA
La sfida a cercare e indagare la propria anima (con poco o nessun aiuto esterno) fa parte dell’intero sforzo filosofico, uno sforzo pratico, reale e individuale. Ancora una volta, la supervisione di un insegnante è altamente raccomandata, ma il peso (e la responsabilità) del percorso resta a carico del singolo.
“Phronesis” vuol dire “saggezza pratica”. Secondo Marco Aurelio (greco: Marcus Aurelius Antoninus Augustus, inglese: Marcus Aurelius), in Meditazioni 4.37, “sapienza e agire con giustizia sono la stessa cosa”. Una simile dichiarazione (da parte di un imperatore) è la migliore conferma di come la saggezza sia una qualità da riferire ad attività fattuali, reali, concrete, pratiche.
La sapienza deve necessariamente essere “phronesis” cioè “saggezza pratica”. Altrimenti, una saggezza teorica (senza implicazioni pratiche) sarebbe una nozione astratta, campata in aria, non verificata.
Brano suggerito: “Spirit of a boy, wisdom of a man” – Randy Travis (1998) -> ASCOLTA SU YOUTUBE
Apri qui per scegliere cosa fare.
Torna alla home page di SOKRATIKO.IT oppure torna in testa a questa sezione PAROLE P-Z oppure torna all’inizio di PHRONESIS.
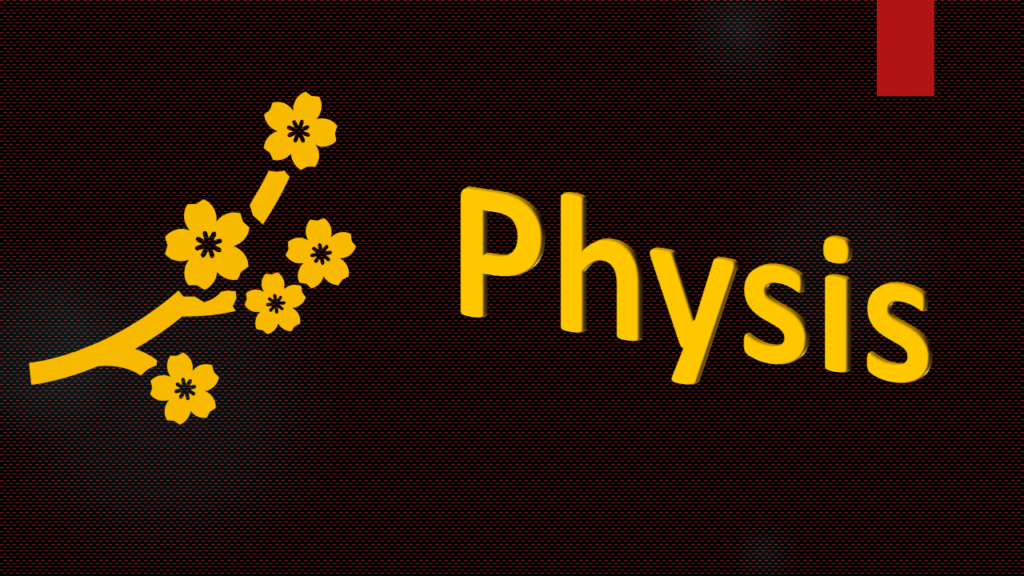
Physis
“Natura”, dimensione fisica universale, realtà prima e fondamentale, principio e causa di tutte le cose.
“Physis” vuol dire “natura”. Nella nostra filosofia (la filosofia del sito sokratiko.it), questo antico sostantivo greco si riferisce all’ordine naturale, al sistema fisico universale, al principio regolativo generale del mondo materiale. Per queste sue caratteristiche, in gran parte dello Stoicismo, il termine “physis” arriva a indicare anche Dio (o qualcosa di analogo).
Platone (greco: Platon, inglese: Plato) critica (nel libro 10 del testo denominato “Leggi”) chi scrive ‘sulla natura’ (“peri physeōs“). Secondo lui, non è opportuno focalizzarsi su un’interpretazione ‘naturalistica’ del mondo, trascurando il ruolo della ‘intenzione’. Infatti, per Platone una tale enfasi sulla natura implica una sorta di ‘ateismo naif’. Tra l’altro, il filosofo ateniese accusa Esiodo (greco; Hēsíodos, inglese: Hesiod) proprio di questo ‘peccato’. Gli dei di Esiodo, sostiene Platone, “crescono da entità primordiali” dopo l’instaurazione dell’universo fisico. Ciò implicherebbe un primato della natura sugli dei.

NATURA SECONDO ARISTOTELE
Aristotele (greco: Aristotélēs, inglese: Aristotle) conserva il significato di “physis” (fra le parole della filosofia rock stoica) come ‘crescita’, ‘sviluppo’. Tuttavia, secondo lui, una giusta definizione richiede le diverse prospettive delle quattro cause (“aitia“): materiale, efficiente, formale, finale.
Per Aristotele, la natura contiene le proprie fonti di: materia (causa materiale), di potere/movimento (causa efficiente), di forma (causa formale) e di fine (causa finale).
L’allievo di Platone è attento anche al rapporto tra arte/tecnica e natura.
“La distinzione tra arte e natura riguarda le loro diverse cause efficienti. “Physis” è la sua stessa fonte di movimento, mentre “techne” richiede sempre una fonte di movimento al di fuori di sé” (Janet Atwill in “The Interstices of Nature, Spontaneity, and Chance. Rhetoric Reclaimed: Aristotle and the Liberal Arts Tradition”. Ithaca, NY: Cornell UP, 1998).
Aristotele, nel suo ragionamento, individua e mette in luce l’idea secondo cui l’arte non contiene in sé la sua forma o fonte di movimento/cambiamento. Invece, in natura, è palese il processo di un seme in grado di diventare da solo, passo dopo passo, un albero. Questo è un tipo di sviluppo naturale dotato in sé della propria forza trainante (forza di cambiamento, di sviluppo, di movimento). Nessuna forza esterna, infatti, spinge il seme verso il suo stato finale, si tratta piuttosto di un processo innato volto a un fine specifico (“telos“).
Brano suggerito: “Earth song” – Michael Jackson (1995) -> ASCOLTA SU YOUTUBE
Apri qui per scegliere cosa fare.
Torna alla home page di SOKRATIKO.IT oppure torna in testa a questa sezione PAROLE P-Z oppure torna all’inizio di PHYSIS.
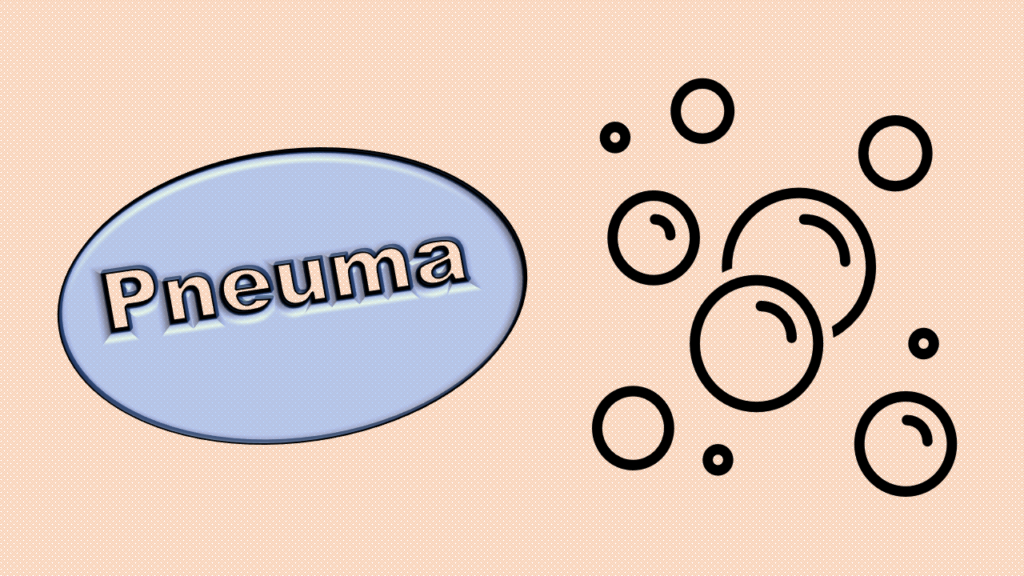
Pneuma
“Spirito”, soffio vitale, energia di vita, principio vitale, talvolta molto vicino a indicare ‘anima’.
“Pneuma” vuol dire “spirito”. Altri significati di questa antica parola greca sono ‘anima’, ‘aria’, ‘respiro’, ‘vitalità’, ‘animazione’. In alcuni contesti, comunque, il concetto di “anima” (‘coscienza’), è reso meglio dal termine “psyche“.
Epitteto (greco: Epíktētos, inglese: Epictetus) offre un’immagine molto suggestiva dello ‘spirito’ in cui tutte le cose esistono, alludendo al movimento di una boccia d’acqua rotante. A livello generale, un modo per attualizzare il concetto di “pneuma” è considerarlo qualcosa di paragonabile all’energia. Tale confronto si applica sia a livello fisiologico/psichico sia a livello fisico/cosmologico.
Nella cosmologia stoica, ogni elemento dell’universo dipende da due principi fondamentali, non creabili e non distruttibili. In primo luogo, la materia, passiva e statica. E poi, il “logos” o ragione divina, attiva e in movimento.
Secondo gli stoici, quando si parla di spiritualità umana, desideri e avversioni sono da considerarsi influenze negative a danno di una parte precisa dell’anima, quella corrispondente proprio al “pneuma“. Pertanto, “pneuma” sarebbe la parte inferiore dell’anima, separata dalla parte superiore “nous” (“intelletto”, “mente”).

SPIRITO, RESPIRO, SOFFIO
“Pneuma“(fra le parole della filosofia rock stoica) vuol dire “spirito”. Per alcuni filosofi stoici, la parola “pneuma” esprime l’idea del “respiro della vita”, di un “soffio vitale”. Quindi, sarebbe una miscela di due elementi: aria (in movimento) e fuoco (come calore). Per questi stoici, “pneuma” è il principio attivo e generativo, fondamentale per organizzare l’individuo e il cosmo.
Nella sua forma più alta, “pneuma” rappresenta l’anima umana (“psyiche“). Pertanto, l’anima umana è un frammento del “pneuma” inteso come anima di Dio (Zeus).
Brano suggerito: “Spirit in the sky” – Norman Greenbaum (1969) -> ASCOLTA SU YOUTUBE
Apri qui per scegliere cosa fare.
Torna alla home page di SOKRATIKO.IT oppure torna in testa a questa sezione PAROLE P-Z oppure torna all’inizio di PNEUMA.

Proegmena
“Naturalmente preferibile”, qualcosa di desiderabile e auspicabile anche se non filosoficamente rilevante.
“Proegmena” vuol dire “cose naturalmente desiderabili”. L’antica locuzione greca si applica a cose come la salute, il comfort, il benessere, la sicurezza. Designa anche ‘cose preferibili’, cioè cose magari ‘indifferenti’ in senso morale assoluto, ma con valore relativo positivo.
La nozione di “proegmena” ha il suo opposto in “apoproegmena“.
I filosofi stoici classificano gli “indifferenti” (cose in sé non buone ma nemmeno cattive) in tre classi precise. Innanzitutto, ci sono gli indifferenti preferibili. In secondo luogo, all’estremo opposto, gli indifferenti non preferibili (da respingere). Infine, gli assolutamente indifferenti.
La terza categoria di cose (assolutamente indifferenti) comprende elementi non in accordo con la nostra natura (diversamente dalle preferibili della prima categoria). Tuttavia, queste cose assolutamente indifferenti non ci sono avverse nella misura in cui lo sono le non preferibili della seconda classe (da respingere senza dubbi). Infatti, non sono in accordo ma nemmeno nettamente contrarie alla nostra natura (come invece le cose rifiutate). Comunque, “proegmena” è la prima delle tre classi sopra citate di indifferenti.

ACCETTAZIONE DELLE COSE NATURALI
“Proegmena“(fra le parole della filosofia rock stoica) vuol dire “cose naturalmente desiderabili”. Esempio: la “bellezza fisica” è una caratteristica considerata non importante, di per sé, dagli stoici. Quindi, in generale, è poco importante essere dotati di bellezza fisica. Più importanti sono la decenza, la rettitudine e così via.
Tuttavia, la “bellezza fisica” è normalmente desiderabile e inoltre preferibile alla bruttezza. Pertanto, la bellezza fisica è in linea con la nozione di “proegmena“.
Per alcuni stoici, il ‘piacere fisico’ (oggi si direbbe “sessualità”) è un esempio di ‘indifferenti preferibili’.
Secondo altri pensatori, il ‘piacere fisico’ ha aspetti positivi, ma non sufficienti per includerlo in questa categoria. Cicerone (latino: Marcus Tullius Cicero, inglese: Cicero) parla di “laetitia” (delizia) quando indica un’emozione preferibile. Ma cita anche la “voluptas” (piacere) per definire il piacere fisico (troppo allettante per essere tra gli ‘indifferenti preferibili’).
Le ‘cose preferibili’ sono, inoltre, cose primarie secondo natura. Pure le ‘cose sgradite’ sono cose primarie, ma in questo caso sono contrarie alla natura.
Brano suggerito: “My favorite things” – John Coltrane (1961) -> ASCOLTA SU YOUTUBE
Apri qui per scegliere cosa fare.
Torna alla home page di SOKRATIKO.IT oppure torna in testa a questa sezione PAROLE P-Z oppure torna all’inizio di PROEGMENA.
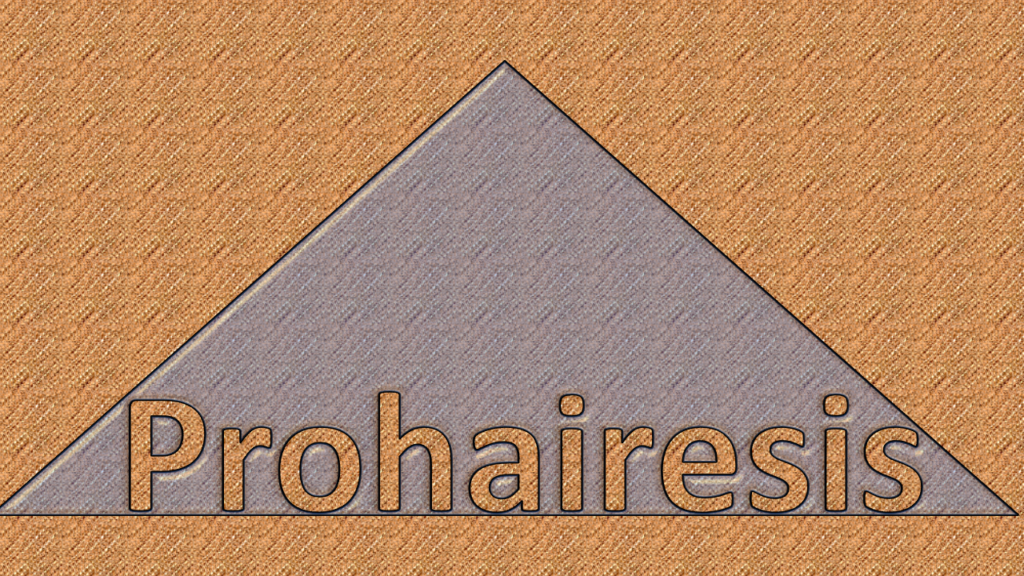
Prohairesis
“Scelta consapevole”, quindi effettuata al termine di un processo cosciente, decisione ponderata, opzione conseguente a una valutazione.
“Prohairesis” vuol dire “scelta deliberata”, decisione cosciente. Quindi, questa antica locuzione greca si usa nella sfera del libero arbitrio. Indica una volizione ragionata, voluta, determinata. I primi usi del termine si fanno risalire alla “Etica nicomachea” (inglese: “Nicomachean Ethics“) di Aristotele (greco: Aristotélēs, inglese: Aristotle) dove significa ‘scelta finalizzata’ ossia compiuta allo scopo di ottenere un certo fine.
Epitteto (greco: Epíktētos, inglese: Epictetus) usa “prohairesis“(fra le parole della filosofia rock stoica) per trattare della differenza fra gli uomini e gli altri animali. Questi ultimi non operano vere e proprie scelte poiché in loro dominano istinti e altri fattori non consci.
Ma di quali scelte stiamo parlando? Per il filosofo dell’Enkheiridion una sola cosa ricade veramente nel nostro controllo (cioè una sola cosa possiamo davvero scegliere). Infatti, per Epitteto, l’unica scelta in capo agli umani riguarda il diniego o l’assenso alle impressioni, alle emozioni, alle valutazioni immediate e spontanee. Per fare un esempio, quando siamo sul punto di essere turbati da una imprevista disgrazia, abbiamo sempre e comunque il potere (magari da sviluppare e affinare) di restare effettivamente turbati o di respingere il turbamento.

Altro esempio: una critica nei nostri riguardi è né in sé ‘cosa buona’ né in sé ‘cosa cattiva’ (sono solo parole al vento). Siamo noi a “scegliere” se farla diventare una cosa cattiva dando assenso interiore all’afflizione e all’ira (spontanee e quasi automatiche). Pertanto, potremmo tranquillamente (e consapevolmente) effettuare altre due azioni alternative. Prima di tutto potremmo scegliere di respingere lo spontaneo dispiacere di fronte alla critica nei nostri riguardi. E poi potremmo scegliere persino di esserne contenti. Evidentemente, quando ci abbandoniamo al dispiacere e all’amarezza dovuti alla critica nei nostri confronti, diamo un potere enorme agli altri. Diamo loro il potere di amareggiarci e dispiacerci. Ma se scegliamo noi uno stato d’animo migliore (cioè se scegliamo di essere contenti), nonostante la critica, allora sottraiamo agli altri il potere di farci del male.
Brano suggerito: “Choices” – The Hoosiers (2010) -> ASCOLTA SU YOUTUBE
Apri qui per scegliere cosa fare.
Torna alla home page di SOKRATIKO.IT oppure torna in testa a questa sezione PAROLE P-Z oppure torna all’inizio di PROHAIRESIS.

Prokope
“Progresso”, nel senso di miglioramento, avanzamento, passi in avanti, ma anche successi, prosperità, fortuna.
“Prokope” rende bene l’idea di un aspetto chiave della nostra filosofia: il “perfezionamento”. La prima ovvia premessa è quella di un potenziale umano sempre notevole, riguardante i margini di miglioramento validi, sempre, per tutti gli individui. La seconda premessa è quella dell’impegno, dello sforzo (e talvolta della vera e propria fatica) a cui occorre sottoporsi affinché il progresso sia possibile. E per progresso si intende il cammino per conseguire uno stato d’animo equilibrato, una capacità di discernimento penetrante, un distacco dalle futilità mondane e una rettitudine impeccabile.
Non è facile accertare e tanto meno misurare l’eventuale avanzamento lungo il percorso della vita filosofica. Questa operazione valutativa risulta particolarmente difficile quando la si deve compiere da soli, senza il supporto di una guida, di un direttore spirituale, di un maestro di coscienza. Tuttavia, l’autovalutazione – per quanto ardua – è un’altra operazione importante nell’addestramento (“askesis”) alla vita filosofica. Quindi, è corretto applicarsi studiosamente per diventare imparziali giudici di sé stessi. Solo osservandosi in azione si può cercare di capire se – in una determinata situazione tipica – si è compiuto o meno un passo avanti. Per esempio, una persona tendenzialmente collerica può verificare (da sola) se sia riuscita a controllarsi bene in una situazione irritante (magari la stessa situazione da cui in passato ha preso spunto per scatenare un pandemonio). Quindi, “prokope“(fra le parole della filosofia rock stoica) è oggetto di autovalutazione.
Obbiettivo della progressione filosofica sono le virtù cardinali: “sophrosyne” ossia prudenza, autocontrollo, temperanza; “andreia” ossia coraggio; “dikayosine” ossia rettitudine; “phronesis” ossia saggezza. E numerosi sono gli ostacoli lungo la via. In Epitteto (greco: Epíktētos, inglese: Epictetus) 4.2. 1–5 apprendiamo i pericoli delle cattive frequentazioni. Il filosofo di Ierapoli (ora in Turchia) ci tiene a sottolineare il rischio di non andare avanti nel cammino filosofico se si frequentano persone sbagliate. Gaio Musonio Rufo (latino: Gaius Musonius Rufus; inglese: Musonius Rufus) tocca lo stesso tema in 11.53. 21–22.
Brano suggerito: “Things can only get better” – Howard Jones (1985) -> ASCOLTA SU YOUTUBE
Apri qui per scegliere cosa fare.
Torna alla home page di SOKRATIKO.IT oppure torna in testa a questa sezione PAROLE P-Z oppure torna all’inizio di PROKOPE.
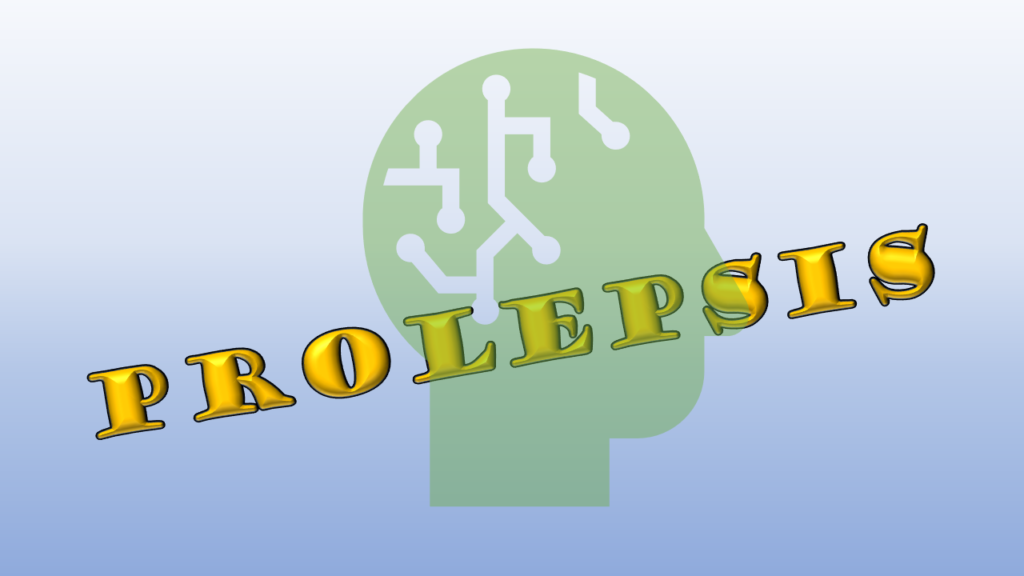
Prolepsis
“Preconcetto”, idea in fase preliminare, nozione in corso di formazione, anticipazione di una valutazione.
“Prolepsis” è da intendersi come “preliminare al concetto”. Si riferisce al germoglio di una concezione, ossia alla fase in cui una rappresentazione comincia a prendere forma nella coscienza dell’individuo. Epicuro (greco: Epíkouros, inglese: Epicurus) usa il termine con il significato di nozione generale (non dettagliata, non articolata). Il fondatore della scuola filosofica perpetuata nel suo nome, indica tre modalità tramite cui acquisiamo conoscenza della realtà. Il primo canale è quello delle sensazioni (“aisthêsis“) ed è quindi collegato a vista, olfatto, eccetera. La seconda via è quella delle pre-concezioni (“prolepsis“) ed essa risulta da una preliminare elaborazione mentale. Il terzo input è costituito dai sentimenti (“pathê“). Per la scuola epicurea – a differenza di molte altre correnti filosofiche – i sensi sono sempre portatori di verità. Infatti, quando siamo eventualmente ingannati dalle sensazioni, ciò accade non per un errore dei sensi ma per una errata nostra valutazione dei segnali da essi provenienti.
Veniamo nello specifico alle pre-concezioni. Esse si formano giorno dopo giorno nella coscienza attraverso la stratificazione di esperienze empiriche. Facciamo il caso della espressione <gatto nero>. Associando ogni volta questa definizione al quadrupede scuro il cui miagolio impariamo presto a distinguere da cinguettii e muggiti, si forma in noi l’idea sommaria del <gatto nero>. Perciò, se qualcuno dice <gatto nero> sorge immediatamente in noi un preconcetto (una idea generica) del tipo di animale a cui il nostro interlocutore si riferisce. Naturalmente, se dopo un secondo colui con il quale dialoghiamo ci mostra una piccola scultura gialla di un gatto a sei zampe, dobbiamo repentinamente correggere il preconcetto e adeguarlo a quanto i nostri occhi constatano in quell’istante.

La nozione epicurea di “prolepsis” (fra le parole della filosofia rock stoica) come “pre-conoscenza” costituisce anche una soluzione per un paradosso affrontato da Platone (greco: Platon, inglese: Plato) nel dialogo “Menone”. La questione è così posta: non si può imparare qualcosa di cui non si sa assolutamente nulla perché altrimenti non ci accorgeremmo nemmeno di aver imparato. E’ necessario avere una base di partenza per apprendere, se no l’apprendimento resterebbe sospeso nel nulla. Ecco, secondo questa teoria, le pre-concezioni sono le basi di cui l’apprendimento necessita.
Siamo in ballo e terminiamo il discorso epicureo sulle tre forme di acquisizione della realtà circostante. I sentimenti (“pathê“) sono simili alle sensazioni (“aisthêsis“), ma anche diversi. Infatti, le sensazioni percepiscono la realtà esterna mentre i sentimenti percepiscono la nostra recezione interiore dei dati provenienti dal mondo. In sintesi, i sentimenti sono orientati dal piacere o dal dolore da noi esperiti nelle diverse circostanze. Sentimenti piacevoli sono il frutto di una elaborazione positiva dei dati sensoriali. Sentimenti dolorosi sono il frutto di una elaborazione negativa dei dati sensoriali.
Diogene Laerzio completa il ragionamento attribuendo ai sentimenti una funzione orientativa. Perseguiamo cose, persone o situazioni da cui sappiamo di poter ottenere piacere. Di converso, rifuggiamo ciò da cui sappiamo (tramite i sentimenti) di poter trarre dolore. E ciò spiegherebbe perché alcuni desiderano cose rifuggite da altri. I sentimenti sono soggettivi e, quindi, possono differire da individuo a individuo.
Brano suggerito: “Prejudice” – Tim Minchin (2010) -> ASCOLTA SU YOUTUBE
Apri qui per scegliere cosa fare.
Torna alla home page di SOKRATIKO.IT oppure torna in testa a questa sezione PAROLE P-Z oppure torna all’inizio di PROLEPSIS.

Pronoia
“Previsione”, conoscenza di fatti e cose prima del loro accadere, provvidenza (soprattutto nel pensiero stoico).
“Pronoia” è termine di enorme portata nel vocabolario filosofico. Infatti, se è possibile avere una prescienza allora il futuro non è un divenire il cui costituirsi accade nel momento in cui accade. La preveggenza implicherebbe un evolversi del tempo sotto regole precise, non affidato alla casualità. Nel contesto greco-antico si tratta di un disegno ascrivibile alle divinità. Perciò, si tratta di “volontà divina” o di “divina provvidenza”.
Epitteto (greco: Epíktētos, inglese: Epictetus) 1.6.1-2 attribuisce due qualità alla “pronoia” (fra le parole della filosofia rock stoica): chiarezza e gratitudine. Anche in Marco Aurelio (greco: Marcus Aurelius Antoninus Augustus, inglese: Marcus Aurelius) troviamo riferimenti alla provvidenza, per esempio in 12.1.
Su questo tema, gli stoici sono in conflitto con gli Epicurei, per i quali l’intero universo è costituito dal continuo scontro e/o coesione fra miliardi di miliardi di atomi in casuale movimento. Lo Stoicismo, invece, fa riferimento al “logos” come legge e natura stessa dell’intero creato. Il “logos” permea e dirige ogni aspetto della realtà e tutto è sottostante a esso. Anche le divinità sono soggette al “logos” e, per certi aspetti, sono loro stesse il “logos“. Molte nozioni su questo argomento sono presenti nel secondo libro dell’opera “De Natura Deorum” di Marco Tullio Cicerone (latino: Marcus Tullius Cicero, inglese: Cicero). Nello scritto ciceroniano, un certo Quinto Lucilio Balbo espone la dottrina stoica della provvidenza da cui è generato il mondo, Inoltre, dalle stesse pagine emerge una forza e preminenza della Natura insieme alla posizione predominante dell’uomo nel creato. Questo ruolo prioritario degli umani è conferito loro dagli dei.
Per dimostrare l’esistenza degli dei, il primo argomento a cui ricorre Cicerone – per bocca di Lucilio Balbo – è la incontestabile bellezza del creato. Tale splendore può trovare origine solo in una causa altrettanto bella e, quindi, divina. Il secondo argomento è la sensatezza di ogni cosa, la cui spiegazione può essere solo una sensatezza superiore a cui tutto si conforma. Gli dei governano il mondo e infondono in esso un senso preciso. Se non vediamo alcun senso è un nostro problema. Siamo noi, molto spesso, a non capire la logica divina. D’altro canto, se la capissimo sempre, saremmo a nostra volta divini e non umani.
Per gli stoici, Natura, Fato e Provvidenza sono praticamente sinonimi, interconnessi tutti con il concetto di “logos” universale.
Brano suggerito: “Foresight” – Grip Inc. (1999) -> ASCOLTA SU YOUTUBE
Apri qui per scegliere cosa fare.
Torna alla home page di SOKRATIKO.IT oppure torna in testa a questa sezione PAROLE P-Z oppure torna all’inizio di PRONOIA.
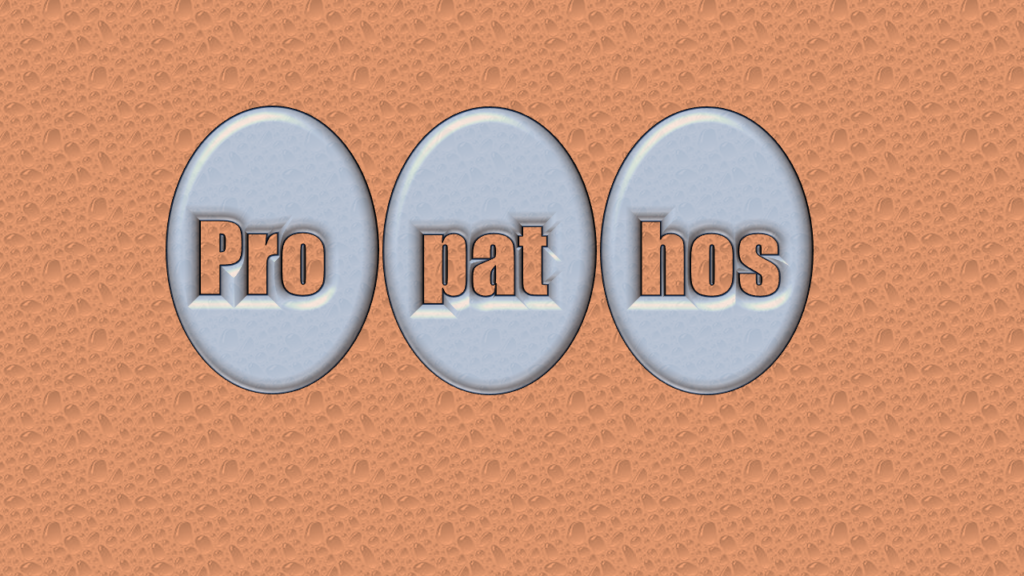
Propathos
“Reazione istintiva”, quindi uno stato di carattere emotivo potenzialmente pericoloso se non sottoposta a supervisione e controllo.
La parola “propathos” consente qualche chiarimento su come vengono considerate le passioni (emozioni, reazioni, sentimenti, ecc.) nella filosofia stoica. Persiste, infatti, l’equivoco per cui gli stoici rifiuterebbero ogni affetto o sentimento. Invece, ciò da loro effettivamente respinto è il dominio incontrollato sul soggetto da parte delle reazioni istintive o di una sfera emotiva fuori controllo. D’altro canto, se gli esseri umani non provassero nulla, nel loro cuore, sarebbero macchine, materia inerte, insomma qualcosa di molto lontano dall’ideale stoico.
Il termine “propathos” (fra le parole della filosofia rock stoica) indica proprio la passione immediata, istintiva, priva di mediazioni. Essa è parte della natura umana, è automatica e non può essere evitata (se non in persone di notevole esperienza e saggezza), almeno nel suo sorgere contingente. Detto ciò, compete al soggetto dotato di raziocinio prendere immediatamente coscienza di ogni ‘passione’ appena sorge nell’animo. Egli deve oggettivarla, osservarla e valutarla con precisione. In questo modo, può comprenderne la natura, la sensatezza, la profondità e le conseguenze. A questo punto, il soggetto può dare assenso all’affezione sorta nel suo stesso animo oppure rifiutarla (se malevole, nociva, inopportuna) oppure gestirla, controllarla, modificarla.

La distinzione effettuata dagli stoici è fra “propathos” ed “eupathos“. Quest’ultimo indica il sentimento buono, accettato, corretto, virtuoso e, quindi, conforme al “logos“. Solo le impressioni e i moti dell’anima “giusti” consentono di raggiungere l’obbiettivo principale di questa scuola filosofica, cioè permettono la “apatheia” (imperturbabile tranquillità d’animo).
Le nozioni stoiche di “pathos” e “apatheia” hanno punti in comune con le prime tre delle Quattro Nobili Verità del Buddhismo. La vita è sofferenza (dukkha); la sofferenza dipende da passioni e desideri (samudaya); bisogna pertanto rimuovere l’attaccamento alle futili cose mondane, alle persone e ai valori erronei (nirodha). La Quarta Nobile Verità è la ottuplice pratica spirituale (marga) per la cessazione del dolore.
Concetti simili sono presenti nel testo sacro induista “Bhagavadgītā“, a sua volta parte del grande poema epico “Mahābhārata“.
Brano suggerito: “Animal instinct” – The Cranberries (1999) -> ASCOLTA SU YOUTUBE
Apri qui per scegliere cosa fare.
Torna alla home page di SOKRATIKO.IT oppure torna in testa a questa sezione PAROLE P-Z oppure torna all’inizio di PROPATHOS.

Prosoche
“Attenzione”, atteggiamento mentale di costante diligenza, lucidità, attenzione e presenza, in una condizione di vigilanza priva di sforzo e fatica.
“Prosoche“ significa “attenzione”, nel senso di ‘diligenza’, ‘presenza mentale’, ‘vigilanza’ e ‘cura’. Nel quadro della nostra filosofia, questo termine greco antico riguarda il fondamentale atteggiamento stoico dell’accortezza e della sollecitudine. Si tratta di una vera e propria postura di base da adottare sempre nei confronti del mondo, degli altri e di sé stessi. Perciò, lo stoico sa di dover sempre tenere occhi e mente bene aperti, senza distrazioni e superficialità. Dunque, stiamo parlando di una persistente tensione dello spirito, da non equivocare, però, con ansietà o trepidazione. Anzi, la continua sorveglianza qui auspicata deve essere espressione di menti solide, serene, curiose, aperte.
“Prosoche” (fra le parole della filosofia rock stoica) significa “attenzione”, in una modalità paragonabile a una corda di violino in attesa di essere suonata. La corda è tesa, ma non vibra, non stride, resta in attesa, pronta a reagire alle sollecitazioni dell’archetto.
Epitteto (greco: Epíktētos, inglese: Epictetus) dice: “l’anima è come un vaso colmo d’acqua. Le impressioni sono come raggi di luce su quell’acqua. Naturalmente, se agitiamo l’acqua, i raggi di luce appaiono agitarsi anch’essi, ma di fatto i raggi in quanto tali non sono toccati. Allo stesso modo, una persona soggetta a vertigine vede il mondo ruotargli intorno, ma solo illusoriamente. Sia nel caso dei raggi sia nel caso della vertigine, sono i nostri sensi a vedere movimenti in realtà inesistenti. Così, quando si acquieta la mente in cui risiedono i sensi, tutto ritorna a posto“.
Marco Aurelio (greco: Marcus Aurelius Antoninus Augustus, inglese: Marcus Aurelius) 11.16 usa una volta la parola “prosoche” nelle sue “Meditazioni”, quando riflette sul poco tempo a noi offerto dalla vita. Un tempo talmente breve, a parere dell’imperatore romano, da non poter (da non dover) essere sprecato in faccende stupide e insignificanti.
Grazie alla “prosoche“, chi conduce una esistenza filosofica dovrebbe sempre essere cosciente di cosa fa e di dove si trova, così da assumere le giuste decisioni e i corretti comportamenti.
Il livello di attenzione richiesto dalla nostra filosofia conduce a una sollecitudine comprendente anche aspetti su cui molti non si soffermano. Per esempio, l’andatura del passo di marcia in talune circostanze, il tono della voce in certe situazioni, il modo in cui si dorme e si mangia, come rivolgere lo sguardo o come tendere la mano per salutare, eccetera.
Brano suggerito: “Careful” – Paramore (2010) -> ASCOLTA SU YOUTUBE
Apri qui per scegliere cosa fare.
Torna alla home page di SOKRATIKO.IT oppure torna in testa a questa sezione PAROLE P-Z oppure torna all’inizio di PROSOCHE.

Psyche
“Anima”, respiro vitale, soffio energetico di tipo primario, ombra calda esistenziale, elemento imprescindibile della natura umana.
“Psyche” è ‘anima razionale’. Possiamo tradurre il termine anche con ‘spirito’, ‘sé’, ‘coscienza’, ‘mente’ (ognuno di questi vocaboli presenta accezioni e accenti semantici diversi). L’equivalente latino in Seneca (latino: Lucius Annaeus Seneca, inglese: Seneca the Younger) è “animus“, la parte intellettiva del soggetto.
Occorre velocemente ricordare il materialismo degli stoici e la conseguente loro convinzione al riguardo della sostanzialità fisica anche dell’anima. Non arrivano a quantificarne il peso in 21 grammi come fatto da Duncan MacDougall nel 1907, ma comunque, per loro l’anima è un elemento concreto.

In origine, la nozione di “psyche” è legata al respiro (“pneuma“). Infatti, le prime ricorrenze del termine di cui ci stiamo occupando (per esempio, in Omero) alludono a una materia simile al fiato e persistente dopo la morte dell’individuo, come un fantasma. Solo con lo sviluppo del pensiero filosofico (dopo i tempi di Omero), si comincia a usare la parola “psyche” per indicare il luogo nel soggetto in cui albergano pensieri ed emozioni. Nel quarto secolo prima di Cristo diventa normale usare il termine in opposizione a “soma” cioè “corpo”.
Per gli stoici, “psyche” è caratterizzata da una scala corrispondente a differenti stati di coscienza. Per esempio, una persona deceduta è una persona privata completamente della propria anima (grado zero). Invece, chi dorme o chi sviene è una persona deprivata solo di una parte di “psyche“.
“Psyche” (fra le parole della filosofia rock stoica) è ‘anima razionale’. Se questa ‘anima’ è aggettivata (come, appunto, ‘razionale’) allora dobbiamo dedurre l’esistenza di altre anime aggettivate in altri modi. In alternativa, dovremmo pensare a una sola anima, ma composta da parti differenti a cui si applicano aggettivi differenti. In effetti, sarebbe sufficiente una sola altra parte dell’anima e cioè una parte ‘irrazionale’.
Come è noto, in psicologia (notare qui la derivazione del termine ‘psicologia’ proprio da “psyche“) abbondano teorie basate su differenti parti e/o funzioni della psiche. Una delle prime articolate teorie in tal senso è quella di Sigmund Freud, secondo il quale la psiche è composta da ‘id’, ‘ego’ e ‘superego’. Lo stesso Freud aveva precedentemente suddiviso la psiche in ‘conscio’, ‘preconscio’ e ‘inconscio’. In quest’ultima concezione, il ‘conscio’ contiene fatti di cui siamo consapevoli; il ‘preconscio’ riguarderebbe elementi in procinto di divenire consci; ‘inconscio’ è il luogo in cui risiede ciò di cui non siamo consapevoli.
Brano suggerito: “Psyche” – Massive Attack (2010) -> ASCOLTA SU YOUTUBE
Apri qui per scegliere cosa fare.
Torna alla home page di SOKRATIKO.IT oppure torna in testa a questa sezione PAROLE P-Z oppure torna all’inizio di PSYCHE.
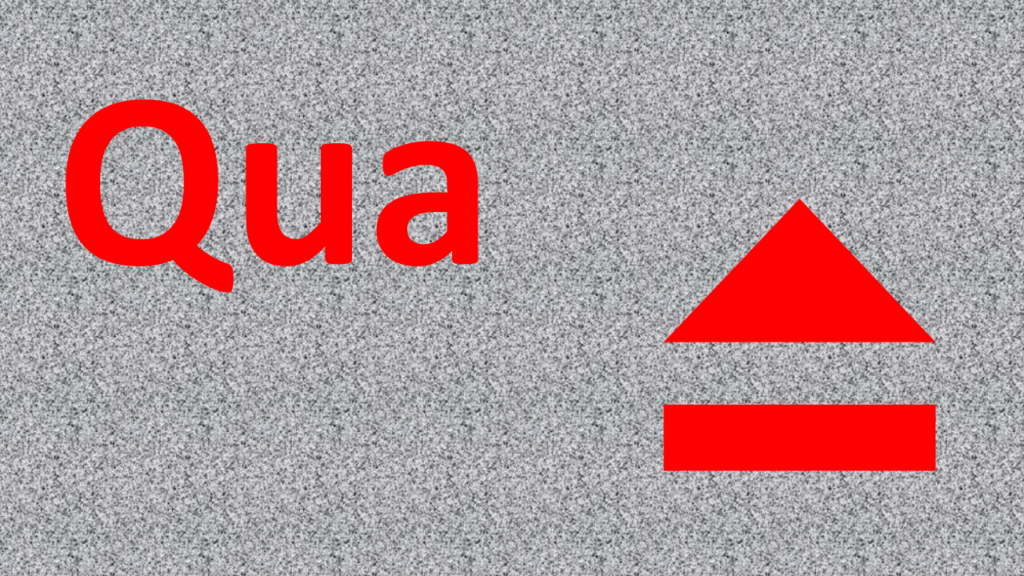
Qua
“In quanto”, espressione in sé generica, ma il cui rilievo filosofico si mostra quando diciamo, per esempio, “L’Essere in quanto Essere”.
“Qua“ è “in quanto”. Questa espressione è ben conosciuta dagli studiosi di filosofia perché Aristotele (greco: Aristotélēs, inglese: Aristotle) la usa diverse volte nel parlare del suo lavoro da noi conosciuto come “Metafisica“. Infatti, il filosofo di Stagira non ricorre mai alla parola “metafisica” e usa molteplici altre espressioni per riferirsi alla materia del suo studio. Una di tali espressioni è, appunto, <lo studio dell’Essere in quanto Essere>. Un’altra è <prima filosofia>. Ma egli usa anche parole come ‘sapienza’ e ‘teologia’ (l’apice della conoscenza).
Noi possiamo dire “in quanto” oppure “per quanto” o anche “sotto l’aspetto di” o “proprio come”. Quindi, una frase come <lo studio del colore “qua” colore> deve essere tradotta <lo studio del colore “in quanto” colore> oppure <lo studio del colore “per quanto” esso è colore> o <lo studio del colore “proprio come” colore> e significherebbe <studiare esattamente la natura stessa del colore>, <studiare l’essenza propria del colore>.
“Qua” (fra le parole della filosofia rock stoica) è “in quanto”. Perciò possiamo considerare il lavoro sopra citato di Aristotele come uno studio sull’essenza dell’Essere, sulla natura propria dell’Essere, insomma sull’Essere in quanto Essere. Si tratta di capire cosa è universalmente dicibile dell’Essere, cosa riguarda ogni Essere, cosa significa veramente, in fondo, in ultima istanza, Essere. Ecco perché l’analisi aristotelica dell’Essere in quanto essere chiama in causa alcune caratteristiche dell’Essere: Essere come categorie, Essere come accidente, Essere come vero, Essere come atto e potenza.
Diverse sono le questioni affrontate da Aristotele in “Metafisica”. Cosa è l’esistere? Che tipi di cose esistono? Come fanno le cose a continuare le loro esistenze nonostante continui cambiamenti? In tutta la sua ricerca, egli cerca di scavare sempre più a fondo, verso l’essenziale, andando oltre le contingenze e le particolarità. Ricordiamo una cosa: ai suoi tempi erano alquanto in voga le tesi sull’Essere di Eraclito (greco: Hērákleitos, inglese: Heraclitus) e di Parmenide (greco: Parmenídēs; inglese: Parmenides), con la prima focalizzata sul cambiamento e la seconda centrata sulla permanenza.
Brano suggerito: “It is what it is” – Abe Parker (2024) -> ASCOLTA SU YOUTUBE
Apri qui per scegliere cosa fare.
Torna alla home page di SOKRATIKO.IT oppure torna in testa a questa sezione PAROLE P-Z oppure torna all’inizio di QUA.

Rhetorike
“Arte del discorso”, con forte accento sulla capacità di convincere l’uditorio e non necessariamente di affermare il vero.
“Rhetorike” è “arte del discorso”. Probabilmente, questa parola entra in uso nella cerchia di Socrate (greco: Sōkrátēs, inglese: Socrates) nel quinto secolo prima di Cristo. Poi fa la sua comparsa nel dialogo “Gorgia” di Platone (greco: Platon, inglese Plato), scritto intorno al 385 prima di Cristo.
“Rhetorike” indica l’arte di parlare in pubblico la cui affermazione risale proprio alla antica Grecia negli stessi tempi in cui fiorisce pure il pensiero filosofico. Inevitabile il duro contrasto fra retori e filosofi. La retorica mira a convincere l’uditorio con qualsiasi espediente mentre la filosofia cerca la verità al di là di ogni apparenza, di illusione e di credenza.
L’arte del discorso, comunque, risulta utile e prende piede nelle assemblee deliberative, nelle corti di giustizia e in molti altri contesti. Nasce una attenzione specifica verso il potere della parola e della sua capacità di persuadere gli ascoltatori.

In “Gorgia”, Socrate chiede al retore Gorgia (greco: Gorghías; inglese: Gorgias) di illustrare la vera natura della retorica: “Caro Gorgia, perché non ci dici tu stesso in quale arte sei esperto e perciò come dovremmo noi definirti?“. Poi, come suo costume, Socrate non concede tregua al pur abile parlatore e lo incalza su vari argomenti connessi all’arte del discorso. Emerge molto presto l’opinione socratica: sebbene la retorica abbia tutto il potenziale per essere corretta e informativa, in realtà si riduce a un modo per raggirare e sedurre l’interlocutore. Per fare ciò, la retorica adotta anche lo stratagemma di far sentire l’ascoltatore importante nel momento in cui egli si identifica con l’astuto e apparentemente corretto ragionamento del retore.
“Rhetorike” (fra le parole della filosofia rock stoica) è “arte del discorso”. Pertanto, è un’arte. Un’arte niente affatto facile. Richiede molteplici qualità e un addestramento piuttosto impegnativo. Tuttavia, le qualità e la fatica richieste dalla pratica della retorica non sono propriamente ‘nobili’ visto il prevalente uso ‘ingannevole’ e non esattamente al servizio della verità. Anzi, secondo molti filosofi, la retorica non si limita a trascurare o ignorare la verità, ma si propone proprio – scientemente – di aggirarla, coprirla, nasconderla. Da questo aspetto nasce la vera guerra intellettuale dei filosofi contro i retori. Non può essere altrimenti: i veri filosofi sono disposti a morire per la verità mentre i retori quasi considerano la verità una scocciatura, un ostacolo, un impedimento.
Brano suggerito: “Power of speech” – Bob Evans (2009) -> ASCOLTA SU YOUTUBE
Apri qui per scegliere cosa fare.
Torna alla home page di SOKRATIKO.IT oppure torna in testa a questa sezione PAROLE P-Z oppure torna all’inizio di RHETORIKE .

Sophos
“Saggio”, con specifico riferimento a una persona dotata di virtù, serena, pacificata, attenta, presente, e – come tale – riconosciuta dagli altri.
“Sophos“ è “saggio” (“sophia” è la saggezza). La parola greco-antica indica una persona ‘sapiente’, ‘virtuosa’, dotata delle qualità definite dal termine “phronesis“.
In campo etico, la desiderabile condizione di “sophos” rappresenta il punto di arrivo ideale degli stoici. Infatti, tutto il loro processo di addestramento alla giusta forma di esistenza (“askesis“) ha, in ultima istanza, l’obbiettivo di condurre alla saggezza, alla sapienza, alla massima virtù.
Ricordiamo: la virtù è una volontà sempre perfettamente allineata alla Natura, sempre in armonia con il naturale corso dell’universo. Quindi, il “sophos” è chi conduce una esistenza in pieno accordo con i ritmi e le dinamiche del creato. Conseguentemente, il “sophos” è scevro da tensioni, conflitti, frizioni, contrasti e incongruenze rispetto all’ordine supremo delle cose.
Inutile dire quanto questo traguardo sia difficilissimo da conseguire, Gli stessi Stoici dubitano dell’esistenza di esseri umani capaci di conseguirlo pienamente e durevolmente. Certamente grandi maestri come Socrate (greco: Sōkrátēs, inglese: Socrates) oppure Diogene il Cinico (greco: Diogénēs ho Kynikós; inglese: Diogenes) si sono avvicinati moltissimo a questo standard. Ma a distanza di così tanto tempo le loro figure sono state anche mitizzate e idealizzate.

“Sophos” (fra le parole della filosofia rock stoica) è “saggio”. Perciò, sarebbe importante definire accuratamente la saggezza per assegnare il titolo di “saggio” con ragion veduta. Limitarsi a parlare di una completa consonanza con la Natura potrebbe sembrare non sufficiente. Tuttavia, una vita perfettamente conforme alla Natura è già qualcosa di enorme da raggiungere. Soprattutto quando si considera il percorso effettuato per millenni dall’umanità proprio allontanandosi dalla Natura, manipolandola, asservendola, umiliandola, disconoscendola. La mente, il ragionamento e la logica hanno preso il sopravvento su qualità molto più naturali come istinto, sensazioni e intuizioni. Riportare la natura in noi è quasi impossibile. Chi ci riesce ne ricava una ricompensa enorme, perché il riallineamento con l’energia e la forza del Tutto spalanca prospettive straordinarie.
Per gli Stoici, il “sophos” è praticamente immune da ogni possibile disgrazia, per il fatto stesso di non considerare nulla una “disgrazia”. Quindi, se gli cade in testa un albero e resta paralizzato il “sapiente” (il vero sapiente) sa accettare questo evento come qualcosa di inscritto inevitabilmente nell’ordine delle cose. E se non sa il perché di questo evento sa comunque attribuirsi la colpa di non sapere il perché di questo evento, in quanto sa almeno, egli stesso, di essere solo un piccolo ignorante. Rammentiamo qui un ‘asset’ socratico basilare: sapere di non sapere. Pertanto, ogni fatto il cui accadere è normalmente considerato una disgrazia (malattia, indigenza, riprovazione da parte degli altri, morte) non tocca il “sophos“. Egualmente, il sapiente non si rallegra di fatti generalmente approvati dagli altri, come ricchezza, fama, potere.
In un certo senso, fanno eccezione rispetto a questo atteggiamento massimamente indifferente l’ignoranza e la conoscenza. Lo stoico soffre più dell’ignoranza altrui la propria ignoranza perché intuisce di dover raggiungere un elevato grado di sapere proprio per sottrarsi a tutte le convenzioni illusorie e ingannevoli. Non dimentichiamo l’etimologia della parola “filosofia”: amore per la sapienza. In questa parola c’è la tensione verso la conoscenza, il desiderio di conseguire la conoscenza, pur nella consapevolezza di non poterla mai conseguire pienamente. Concludendo, il “sophos” è una sorta di figura ideale irraggiungibile. Ma come dice il proverbio: bisogna puntare alla luna per raggiungere almeno la cima dell’albero.
Brano suggerito: “Wise women” – Moonchild (2019) -> ASCOLTA SU YOUTUBE
Apri qui per scegliere cosa fare.
Torna alla home page di SOKRATIKO.IT oppure torna in testa a questa sezione PAROLE P-Z oppure torna all’inizio di SOPHOS .
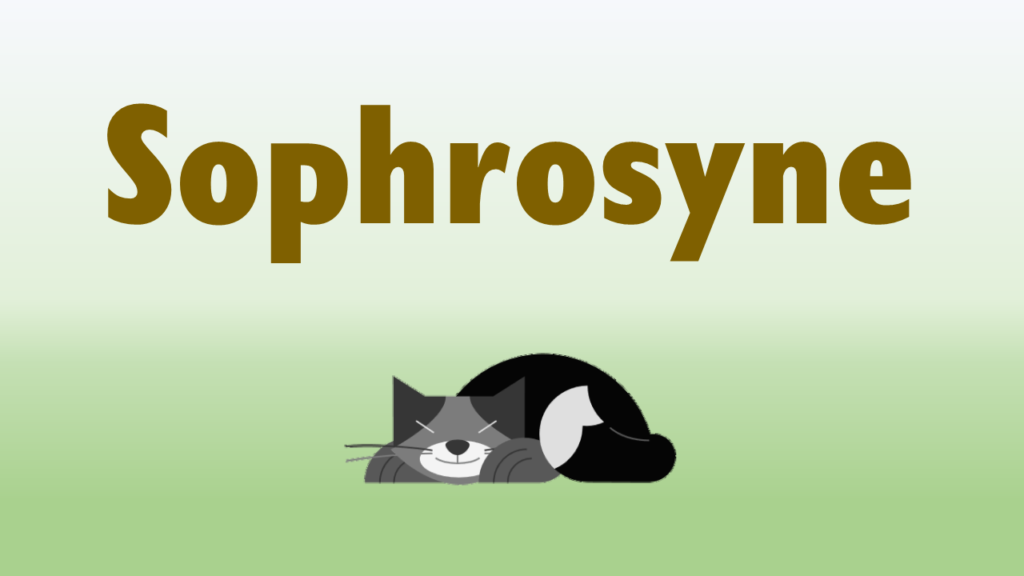
Sophrosyne
“Temperanza”, una delle quattro più importanti qualità di un individuo, insieme a coraggio (“andreia“), giustizia (“dikaiosyne“) e saggezza (“sophia“).
“Sophrosyne” è “temperanza”, ‘sobrietà’, ‘moderazione’. Secondo il pensiero filosofico antico a cui facciamo riferimento, si tratta di una delle quattro virtù cardinali. Le altre tre sono: “andreia” (coraggio), “dikayosine” (giustizia) e la qualità del “sophos” ossia la “sophia” (saggezza).
“Sophrosyne” (fra le parole della filosofia rock stoica) è “temperanza”, il tema principale del dialogo platonico “Carmide“. Il testo (considerato giovanile) di Platone (greco: Platon, inglese Plato) è aporetico (cioè non conduce a una soluzione certa) ed areteico (cioè si occupa di “aretè“, la virtù). Infatti, in “Carmide” vengono valutate diverse definizioni di virtù senza giungere a una decisione finale univoca. Emerge, tuttavia, con una certa preponderanza, la necessità per il virtuoso di avere una purezza morale comportante alcune cristalline ricadute comportamentali.
In un altro dialogo platonico, “Cratilo” è presente una descrizione di “sophrosyne” quale ‘sanità morale’ .
Infine, in un terzo libro di Platone, “Fedro“, la virtù chiamata “sophrosyne” è intesa come elemento di mediazione fra le componenti appetitive (volitive in senso materiale) e quelle spirituali dell’individuo.

Anche Zenone di Cizio (greco: Zḕnōn ho Kitièus, inglese: Zeno of Citium) considera “sophrosyne” una delle quattro principali caratteristiche di un’autentica esistenza filosofica. Per molti esponenti dello Stoicismo quali Gaio Musonio Rufo (latino: Gaius Musonius Rufus; inglese: Musonius Rufus), Seneca (latino: Lucius Annaeus Seneca, inglese: Seneca the Younger), Epitteto (greco: Epíktētos, inglese: Epictetus) e anche per Marco Aurelio (greco: Marcus Aurelius Antoninus Augustus, inglese: Marcus Aurelius) la funzione principale di “sophrosyne” è limitare, contenere e controllare le appetizioni umane.
Marco Tullio Cicerone (latino: Marcus Tullius Cicero, inglese: Cicero) prende in considerazione quattro parole latine per tradurre appropriatamente “sophrosyne“: “temperantia” (temperanza), “moderatio” (moderazione), “modestia” (modestia) e “frugalitas” (frugalità). In generale, pur in presenza di alcune differenze e sfumature, i vari termini fanno tutti riferimento a un atteggiamento misurato, composto, cauto, distaccato, capace di smussare e di mediare.
Tematiche notevolmente connesse a “sophrosyne“ sono prominenti in opere di Eschilo, Sofocle ed Euripide. Citiamo, in particolare, la tragedia “Ippolito” di Euripide in cui la virtù è rappresentata dalla dea Artemide e trova la sua personificazione proprio nel protagonista Ippolito.
Brano suggerito: “Restrain” – Poco (1972) -> ASCOLTA SU YOUTUBE
Apri qui per scegliere cosa fare.
Torna alla home page di SOKRATIKO.IT oppure torna in testa a questa sezione PAROLE P-Z oppure torna all’inizio di SOPHROSYNE.

Sympatheia
“Affinità”, accordo, consonanza, vicinanza, mutua interdipendenza, vibrazione all’unisono.
“Sympatheia” è “affinità”. Altri termini adeguati a esprimere questo concetto sono: ‘accordo’, ‘consonanza’, ‘simpatia’, ‘vicinanza’, ‘mutua interdipendenza’, ‘interesse’, ‘comprensione’.
La nozione di “sympatheia” è piuttosto importante nel pensiero di Plotino (greco: Plotinos, inglese: Plotinus). Come è noto, l’autore di “Enneadi” elabora alcune tesi di Platone (greco: Platon, inglese Plato) – in particolare quelle contenute in “Timeo“ – e anche diverse nozioni dello Stoicismo. Tuttavia, Plotino si smarca da certe dottrine stoiche, per esempio dal “fisicalismo”. Infatti, per il filosofo di Licopoli “sympatheia” è la consonanza totale di una realtà essenzialmente incorporea. Per esempio, attribuisce proprio a “sympatheia” la connessione fra loro di fenomeni spazialmente distanti. Secondo lui, tutto è interconnesso in virtù dell’appartenenza a una sola anima universale. E ci sono ambiti in cui ciò appare molto evidente: influenze astrali, magia, divinazione, preghiere, percezioni.

In “Meditazioni“, Marco Aurelio (greco: Marcus Aurelius Antoninus Augustus, inglese: Marcus Aurelius) fornisce istruzioni per tenere in mente le idee più importanti. “Riflettere spesso sulle interconnessioni e mutue dipendenze fra tutte le cose dell’universo”. La gran parte del pensiero stoico poggia su questa nozione di una tessitura unica e universale con cui ogni cosa si collega a tutte le altre. L’imperatore romano e filosofo stoico è convinto dell’importanza di una corretta interpretazione di “symaptheia” perché se tutti capiscono di essere connessi agli altri, ne può conseguire maggiore rispetto reciproco e concordia. Se poi gli umani comprendono di essere connessi non solo fra loro ma pure con le pietre, le piante, la pioggia, gli insetti e gli altri animali, allora la consonanza diventa assoluta. “L’universo ha creato creature senzienti per i loro vantaggi reciproci, con un occhio alla cooperazione e mai al danneggiamento“.
“Sympatheia” (fra le parole della filosofia rock stoica) è “affinità”. Quando gli altri soffrono, anche noi soffriamo. Quando il mondo soffre, anche noi soffriamo. Marco Aurelio dice: “se qualcosa fa male all’alveare allora fa male all’ape“.
Insomma, lo Stoicismo considera ogni cosa come componente di un immenso, unico, organismo. Tutto condivide la medesima sostanza. Tutti respirano la stessa aria. E naturalmente discendiamo tutti dalla medesima catena evolutiva, indipendentemente da etnie, luoghi di nascita, culture, ricchezze e stato di salute.
Brano suggerito: “Sympathy for the devil” – The Rolling Stones (1968) -> ASCOLTA SU YOUTUBE
Apri qui per scegliere cosa fare.
Torna alla home page di SOKRATIKO.IT oppure torna in testa a questa sezione PAROLE P-Z oppure torna all’inizio di SYMPATHEIA.
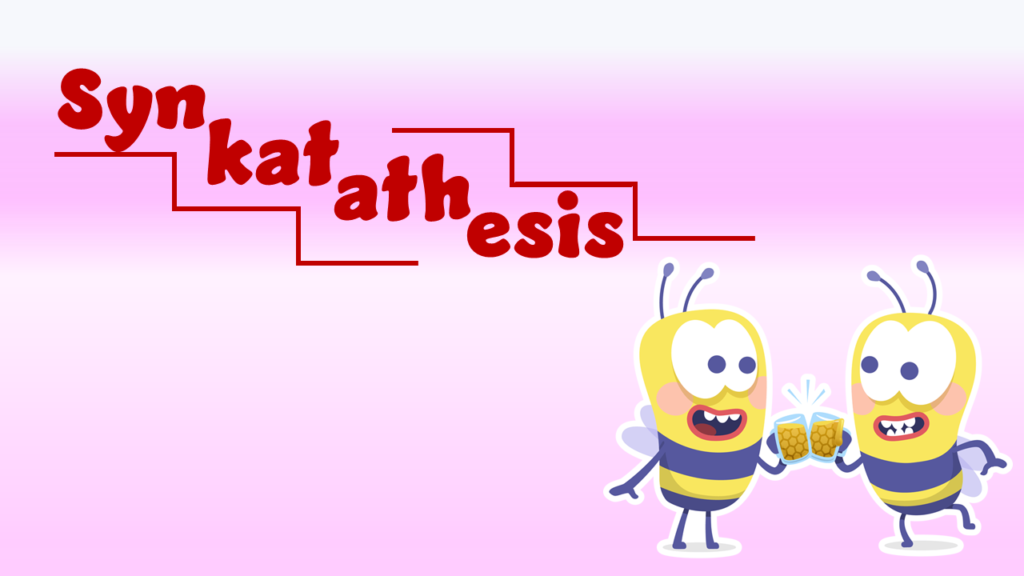
Synkatathesis
“Assenso”, inteso come accettazione interiore (assenso a sé stessi) dei dati elaborati da corpo e mente per poter intraprendere un’azione.
“Synkatathesis” è “assenso”, inteso come recezione interiore delle percezioni processate dai sensi e dalla mente. Nello Stoicismo, quindi, si tratta di un’approvazione delle sensazioni e delle istanze raccolte dinanzi a un oggetto, un evento, un fenomeno, così da poter fornire una reazione adeguata..
Nello specifico, “synkatathesis” è il terzo livello di coerenza e consequenzialità nel processo volizione/valutazione o rifiuto/giudizio. Infatti, è parte di una sequenza il cui scopo è di consentirci un modo giusto di affrontare la realtà.
Il primo step della sequenza è “aisthesis” risultante dalla attivazione dei nostri sensi. Per esempio, se un sasso ci colpisce al volto i nostri sensi si attivano immediatamente e producono una serie di stimoli di varia natura (dolore, allerta, produzione di adrenalina, eccetera).

Il secondo grado è “phantasia” consistente nella creazione delle rappresentazioni con cui è possibile il passaggio dall’apparato sensoriale all’anima (alla mente). Per esempio, mentre “aisthesis” ci fornisce le sensazioni di dolore (urto, bruciore, stordimento, ecc.) , “phantasia” ci fornisce l’idea di un oggetto in collisione con il nostro volto, forse non molto grande, probabilmente di forma irregolare, giunto con una certa velocità e da una certa angolazione.
Attenzione, le “phantasiai” sono prodotte non solo da fatti e oggetti esterni ma anche da condizioni interiori (predisposizioni, processi organici, malfunzionamenti e molto altro). Comunque, sia il primo livello (estetico/sensoriale) sia il secondo livello (rappresentativo) sono essenzialmente passivi. In altre parole, non è chiamata in causa la nostra libertà di scelta.
Al terzo livello troviamo ciò di cui ci stiamo occupando, cioè “synkatathesis“. E’ una sorta di “logos” allocato dentro noi stessi (un riflesso del “logos” universale) preposto al compito di dare assenso (o rifiutarlo oppure magari sospendere il giudizio) alle rappresentazioni del secondo ‘step‘. Continuando nell’esempio del sasso al volto, il “logos” interiore (“synkatathesis“) potrebbe decidere di respingere la rappresentazione di un sasso non molto grande, di forma irregolare, eccetera. Tale rifiuto della rappresentazione formatasi in noi rapidamente e automaticamente potrebbe dipendere da molte esperienze analoghe in cui abbiamo, poi, verificato non trattarsi affatto di un sasso ma di un grosso insetto.
Come è evidente, questo terzo livello implica una certa libertà individuale sottraendosi alle istintualità dei primi due. Non si tratta di una libertà assoluta, in quanto la terza fase del processo è ovviamente legata alla seconda (la quale è, a sua volta, legata alla prima), ma comunque c’è un margine di decisione da parte del soggetto.
“Synkatathesis” (fra le parole della filosofia rock stoica) è “assenso”. Ma come si è appena argomentato, si tratta di un assenso non completamente libero. Infatti, potremmo valutare di essere stati colpiti al volto da un calabrone e non da una pietra, ma non potremmo mai giungere alla conclusione di essere stati colpiti da una leggerissima ala di farfalla. Se propendessimo per l’idea della farfalla ciò dipenderebbe da follia, malattia, stato di grave alterazione psico-fisica o allucinazioni.
Brano suggerito: “Body and soul” – Billie Holiday (1957) -> ASCOLTA SU YOUTUBE
Apri qui per scegliere cosa fare.
Torna alla home page di SOKRATIKO.IT oppure torna in testa a questa sezione PAROLE P-Z oppure torna all’inizio di SYNKATATHESIS.

Techne
“Competenza pratica”, capacità, ‘expertise’, tecnica, abilità, conoscenza tecnica, arte materiale, sapienza pratica.
“Techne” è “competenza pratica”. Nella filosofia dell’Antica Grecia questa parola designa ‘expertise’, ‘capacità’, ‘mestiere’, ‘arte materiale’.
Marco Aurelio (greco: Marcus Aurelius Antoninus Augustus, inglese: Marcus Aurelius) 11.5 afferma: “la nostra “techne” consiste nell’essere buoni esseri umani“. La frase dell’imperatore romano è ben più profonda di quanto si possa ritenere a prima vista. Egli non dice, per esempio, “la nostra finalità consiste nell’essere buoni esseri umani”. Marco Aurelio usa il termine “techne“, un termine collocato in ambito pratico. Vuole dire: dobbiamo essere buoni nella pratica, nella vita materiale, fattivamente (non solo nelle intenzioni e nelle parole).
C’è differenza fra la parola “techne” e la parola “episteme” poiché si riferiscono a due ambiti diversi anche se non privi di punti di contatto. Il contatto è rappresentato dall’area concettuale della “conoscenza” comune a entrambi i termini. E, infatti, Platone (greco: Platon, inglese Plato) talvolta usa i due idiomi in modo intercambiabile mentre altre volte sembra distinguerli abbastanza marcatamente. Quando usati in senso piuttosto ampio e generale, i due termini significano egualmente “conoscenza”. Invece, in discorsi più specifici, le differenze fra “conoscenza teorica” (“episteme“) e “competenza pratica” (“techne“) emergono abbastanza bene. Per esempio, Aristotele (greco: Aristotélēs, inglese: Aristotle) usa le due parole in modo diversificato.

Senza dubbio, “techne” implica aspetti più pratici e fattuali: come fare qualcosa con perizia e accuratezza. Viceversa, “episteme” implica questioni maggiormente teoriche: cosa significa un concetto e con quali conseguenze.
“Techne” è “competenza pratica”. Per gli antichi greci, la parola indica anche le arti meccaniche, comprese medicina e musica.
L’aforisma inglese “gentlemen don’t work with their hands” (i gentiluomini non lavorano usando le mani) trae origine proprio da una concezione in voga nella antica Grecia. Le operazioni manuali sono destinate alle classi inferiori mentre le classi superiori possono occuparsi delle arti liberali destinate agli uomini liberi. Tuttavia, come sempre accade con le parole, i significati e le implicazioni possono mutare a seconda dei contesti e dei tempi storici.
Brano suggerito: “Skills” – Gang Starr (2006) -> ASCOLTA SU YOUTUBE
Apri qui per scegliere cosa fare.
Torna alla home page di SOKRATIKO.IT oppure torna in testa a questa sezione PAROLE P-Z oppure torna all’inizio di TECHNE.

Telos
“Obbiettivo”, traguardo, scopo, fine, meta conclusiva, approdo finale, punto di arrivo.
“Telos” è “scopo”. Nel quadro della nostra filosofia, questo termine indica ‘il fine’, ‘l’obbiettivo conclusivo’ degli studi, dell’addestramento, del processo formativo, dell’esistenza. Aristotele (greco: Aristotélēs, inglese: Aristotle) sostiene fortemente l’idea di un punto d’arrivo di ogni cosa e chiama, appunto, “telos” questo ‘obbiettivo’.
La parola significa pure ‘intento’, ‘destinazione’, ‘traguardo’, ‘approdo’. tuttavia Aristotele la usa in un modo molto specifico. Il filosofo di Stagira, il cui stesso nome deriva dall’unione di ἄριστος (“aristos“) «migliore» e τέλος (“telos“) «fine» fa riferimento soprattutto al “telos” insito dall’origine in ogni cosa. Ritiene, infatti, ogni elemento del creato provvisto di un proprio obbiettivo a cui è inevitabilmente destinato. Si tratta della ragione stessa per cui ogni cosa esiste.
La parola “telos” è contenuta nell’espressione aristotelica “entelecheia“, traducibile come “ciò grazie a cui diventa attuale quanto resterebbe solo potenziale”. L’idea di “entelecheia” (una forza, una energia, un ‘drive‘) è connessa alla differenziazione aristotelica fra ‘materia’ e ‘forma’, fra ‘potenza’ e ‘atto’.
In qualche modo, il concetto è stato recentemente ripreso in chiave psicoanalitica da James Hillman. Nasciamo tutti con una funzione da assolvere: se la individuiamo e la compiamo siamo pienamente realizzati.
Forse aveva in mente qualcosa del genere il poeta Dylan Thomas quando scrisse “La forza che dalla verde miccia spinge il fiore“.
In ogni cosa è inscritto un destino. In ognuno di noi c’è il seme di quanto deve successivamente compiersi. Il seme di una quercia, nella sua originaria piccolezza, contiene già tutte le informazioni necessarie e sufficienti al successivo sviluppo di un albero grosso, alto, duraturo. Pertanto, il “telos” della quercia è di seguire le istruzioni contenute nel proprio seme. Così come il “telos” di un uovo è diventare pulcino e poi gallina. Insomma, il compito è semplice e soprattutto chiaro.
Ma noi non possiamo cavarcela con la stessa semplice traiettoria di un seme o di un uovo. Noi siamo dotati di una mente complessa con cui si origina una libertà di scelta molto più ampia di quelle concesse a semi e uova. La sciagura per noi è di avere una mente più elaborata degli altri esseri viventi, ma non al punto da evitarci errori. Così la libertà di scelta si traduce per noi in una libertà di sbagliare, una libertà di uscire dal giusto cammino, una libertà di deviare.
La quercia ha pochissimi margini nel percorso a cui è destinata. Inoltre, tali margini dipendono non da lei ma da circostanze esterne (abbondanza o meno di acqua, presenza o meno di luce solare nel punto in cui è caduto il seme, arrivo di esseri umani intenzionati a costruire un edificio proprio in quel posto, eccetera). I nostri margini sono certamente più ampi. E dipendono molto da scelte nostre.

“Telos” è “scopo”. L’esistenza necessita di “scopo”. Tutti noi ne abbiamo uno. Ma proprio la elaboratezza della nostra mente (unita alla montagna di spazzatura di cui la riempiamo) ci offusca la vista – e il cuore – non facendoci vedere il nostro scopo. Non a caso sono soprattutto i bambini (la cui mente non si è ancora irrimediabilmente impadronita di tutto) a saper bene cosa vogliono fare. Ci sono bambini, per esempio, la cui lucidità e determinazione su cosa vogliono fare da grandi lascia allibiti.
Purtroppo, per gli umani la faccenda non si limita alla generale incapacità di riconoscere il proprio destino, il proprio scopo, il motivo della propria esistenza, Infatti, non di rado, gli umani agiscono addirittura contro il proprio fine, contro la propria indole, contro le proprie inclinazioni personali. Ciò, per esempio, non accade agli animali. Un lupo non può scegliere di diventare agnello.
Naturalmente, la questione della libertà di scelta è fondamentale per la filosofia (e per la teologia). La questione umana, in fondo, può essere ridotta a questo aspetto. Tutti noi possiamo sempre scegliere la nostra reazione agli eventi. Possiamo soprattutto scegliere la reazione non immediata, non a caldo. Scopo della filosofia a cui qui facciamo riferimento, comunque, è di giungere a un tale livello di autocontrollo da poter scegliere pure come reagire nell’immediatezza di una circostanza capace di destare istinti primordiali. E’ solo questione di allenamento (“askesis“) e di forza di volontà (anche essa, comunque, dipendente dall’addestramento).
Si rigetta, pertanto, ogni argomentazione del tipo “mi dispiace, io reagisco così perché son fatto così”. Data la possibilità di uscire dal seminato (rispetto alla obbligatorietà a cui sono soggetti semi e uova) la medesima possibilità può essere richiamata anche per rimettersi in carreggiata, recuperando il proprio scopo, la propria più autentica natura, la propria vocazione.
Brano suggerito: “Target” – Tommy Lee Sparta (2018) -> ASCOLTA SU YOUTUBE
Apri qui per scegliere cosa fare.
Torna alla home page di SOKRATIKO.IT oppure torna in testa a questa sezione PAROLE P-Z oppure torna all’inizio di TELOS.
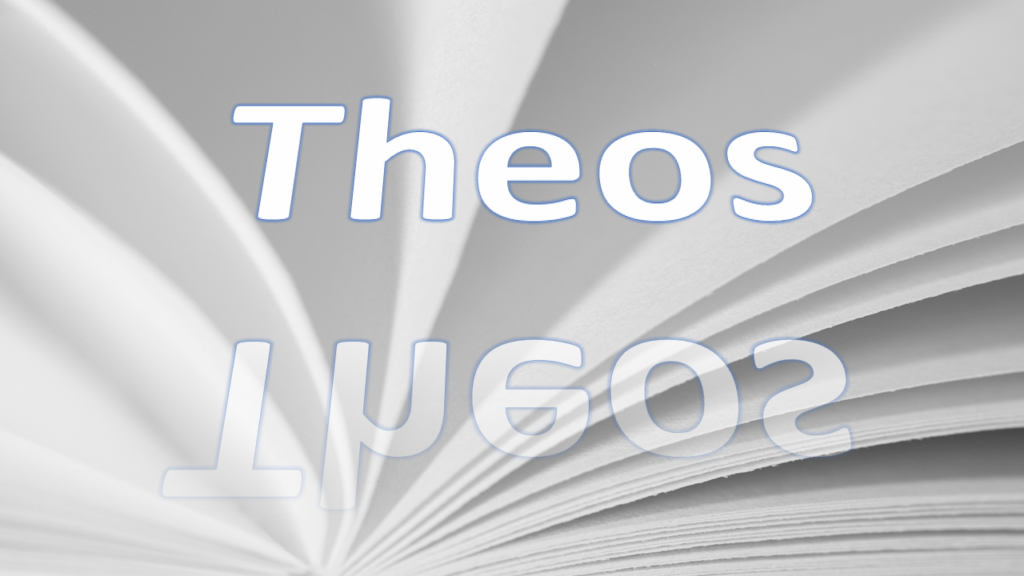
Theos
“Dio”, divinità, potenza assoluta, principio universale, ordine del creato, entità superiore, logica regolatrice e onnicomprensiva.
“Theos” è “dio”. Questa parola della Grecia antica è traducibile anche come ‘divinità’. Il termine fa riferimento a una entità in possesso di poteri supremi con cui conferisce un ordine all’universo. La medesima entità attribuisce agli esseri umani la loro ragione e la loro libertà di scelta.
Naturalmente, una entità connessa a tali poteri costituisce una questione filosofica (teologica) complessa. Essa si presenta come talmente “altra” rispetto alla natura umana da risultare inafferrabile e ineffabile. La si può solo intuire e la si può solo definire in modo apofatico. Comunque, non è questa la sede per affrontare le implicazioni riguardanti il concetto di “dio”. Qui ci basta riferire il termine “theos” al ‘principio ultimo’, alla ‘legge suprema’, alla ‘energia universale’, alla ‘causa del tutto’.

C’è qualcosa oltre le molecole, oltre gli atomi, oltre le particella subatomiche. C’è una vibrazione, movimento, energia, spirito. Questa forza, questa oscillazione, è alla base dell’espansione dell’universo, ma anche alla base dell’esistenza di un moscerino o della nostra mente.
Per secoli le menti più acute, curiose e infaticabili si sono spese senza risparmio per affrontare il problema di ‘dio’, dell’uno, dell’assoluto, dell’eterno, dell’onnipotente, dell’onnisciente. Molte sono giunte a conclusioni simili sul nostro rappresentare una parte di questo ‘tutto’, di questa totalità onnipervasiva. Il fatto stesso di essere a nostra volta compresi nell’assolutezza (come parte, come componente, come risultante) determina il nostro problema di non poter osservare la questione da una posizione terza, esterna e neutrale. Ecco perché ci affidiamo a percezioni e intuizioni senza riuscire a trovare risposte esaurienti.
“Theos” è “dio”. Millenni di vana speculazione intellettuale sul problema di dio indicano come unica strada percorribile quella della spiritualità. Insomma, gli strumenti della logica e del ragionamento si sono dimostrati palesemente insufficienti per maneggiare la questione dell’assoluto. La nostra mente è a proprio agio nell’elaborare un uso pratico e utile dell’energia elettrica, ma annaspa dinanzi a dio. Tuttavia, la meditazione, la preghiera, l’astrazione e altre pratiche spirituali sembrano costituire le modalità con cui maggiormente siamo in grado di avvicinarci a ‘dio’. Naturalmente, possiamo annoverare le più varie forme d’arte fra le pratiche spirituali. Un brano musicale particolarmente ispirato può avvicinarci a ‘dio’ più di un testo teologico di tremila pagine. E lo stesso vale per una importante opera cinematografica o pittorica. In effetti, sembra proprio necessario spegnere la mente argomentativa e lasciarsi riempire dal ‘tutto’ senza elucubrazioni cervellotiche.
Brano suggerito: “All power” – Nathaniel Bassey (2020) -> ASCOLTA SU YOUTUBE
Apri qui per scegliere cosa fare.
Torna alla home page di SOKRATIKO.IT oppure torna in testa a questa sezione PAROLE P-Z oppure torna all’inizio di THEOS.
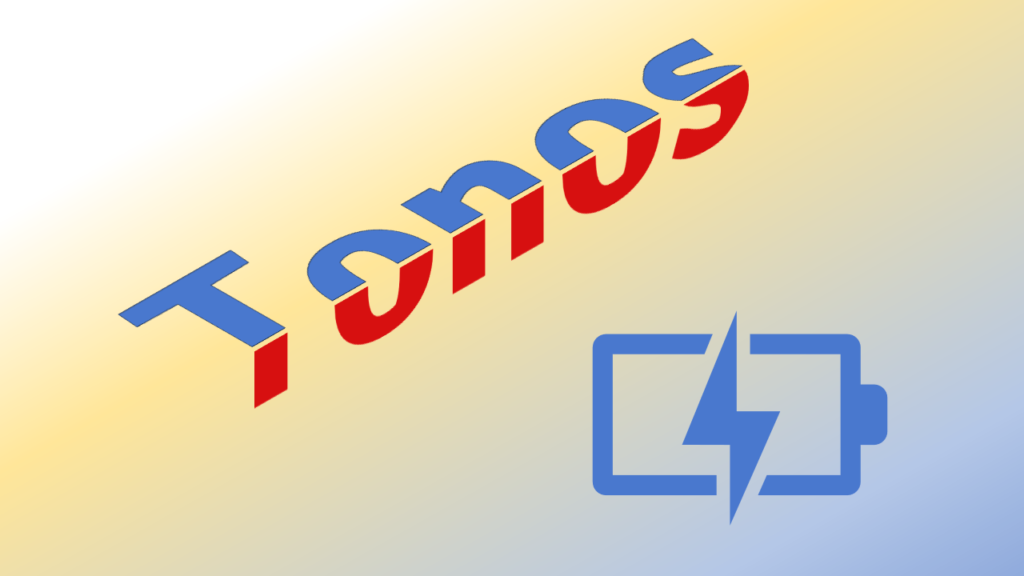
Tonos
“Tensione”, sorta di energia e vibrazione alla base di attrazione e repulsione, ma più generalmente di ogni azione e movimento.
“Tonos” è ‘tensione’. Principio fisico di attrazione e repulsione, tensione interiore con cui si originano virtù e vizi umani. Per comprendere “tonos” è utile la nozione di “pneuma“, ‘soffio vitale’, miscela di aria (movimento) e fuoco (calore). Nella Grecia antica, filosofi e fisici (fra le due ‘professioni’ non c’era gran differenza) considerano tre tipi di “pneuma” fatti di aria e fuoco. Primo, il “pneuma” inteso come condizione cronica, il quale conferisce a tutte le cose stabilità e coesione (“hexis“). È presente anche in pietre e altri oggetti inanimati. Nemesio attribuisce il potere del “pneuma” al suo moto di trazione (“tonicê kinêsis“). In pratica, il “pneuma” agisce verso l’esterno, producendo qualità e quantità, e verso l’interno, dando luogo a unità e sostanza. Ogni individualità è caratterizzata dall’equilibrio del proprio “pneuma” con cui si tiene insieme e, allo stesso tempo, si distingue dalle altre individualità.
Il secondo tipo di “pneuma” è la ‘forza vitale’. Il terzo tipo è il “pneuma” inteso come ‘anima’.

“Tonos” è ‘tensione’, spinta ideale con cui la nostra filosofia promuove anche la dignità e il decoro in tutti gli individui.
In ultima analisi, nella filosofia stoica il “pneuma” è il principio generativo attivo alla base di tutte le individualità e di tutto il cosmo. Nella sua manifestazione più elevata, “pneuma” costituisce l’animo umano (“psyche“), il quale è a sua volta una porzione del “pneuma” inteso come ‘anima di dio’.
Come forza capace di dare struttura alla materia il “pneuma” esiste anche nelle entità inanimate. Una possibilità di attualizzare il concetto di “tonos” è di considerarlo uno degli effetti dell’energia (a livello fisico ma anche spirituale).
Brano suggerito: “Tension” – Avenged Sevenfold (2008) -> ASCOLTA SU YOUTUBE
Apri qui per scegliere cosa fare.
Torna alla home page di SOKRATIKO.IT oppure torna in testa a questa sezione PAROLE P-Z oppure torna all’inizio di TONOS.
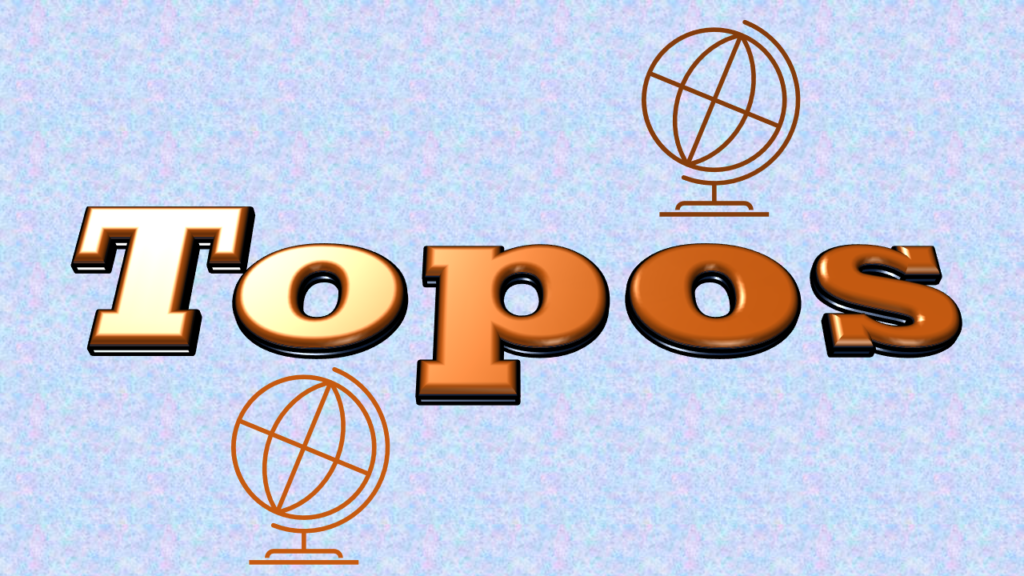
Topos
“Luogo”, non solo in senso fisico e geografico, ma anche figurativo come nel caso di un luogo del discorso (argomento).
“Topos” è “luogo”, da intendere in misura più ampia e flessibile rispetto alla mera localizzazione fisica. Infatti, la parola greca è traducibile come ‘sito’ (in latino “locus“) ma può anche designare luoghi figurativi, luoghi del discorso, per esempio nel senso di ‘argomento’, ‘tema’, ‘questione’.
Nella retorica classica, “topos” si riferisce al metodo per lo sviluppo delle argomentazioni. Per esempio, i “topoi” sono formule standard (giochi di parole, proverbi, espressioni idiomatiche) a cui i retori ricorrono per costruire ragionamenti e discorsi.
L’espressione “topoi” è stata molto utilizzata da Aristotele (greco: Aristotélēs, inglese: Aristotle). L’espressione indica i “luoghi” in cui il parlante (o lo scrivente) colloca argomenti ritenuti appropriati per certi nuclei tematici. In tale contesto, i “topoi” sono strumenti e tecniche per la costruzione dei discorsi.
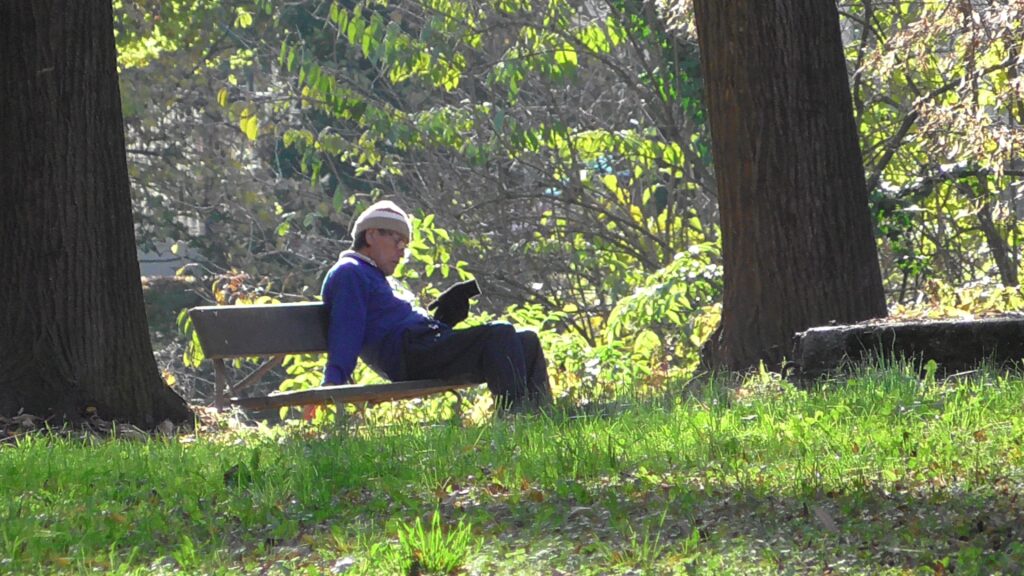
“Topos” è ‘luogo’. Nella sua “Retorica“, Aristotele identifica due tipologie di “topoi“. Il primo tipo è “generale” (“koinoi topoi“) e il secondo tipo è “particolare” (“idioi topoi“).
Brano suggerito: “Commonplace” – Vice Killer (2020) -> ASCOLTA SU YOUTUBE
Apri qui per scegliere cosa fare.
Torna alla home page di SOKRATIKO.IT oppure torna in testa a questa sezione PAROLE P-Z oppure torna all’inizio di TOPOS.
