
Maestri
Abbiamo appreso molti elementi della nostra filosofia da pochi grandi maestri di vita. La maggior parte di loro appartiene a epoche lontane, a dimostrazione di insegnamenti ed esempi solidi, efficaci, duraturi. Dello spirito rock essi mostravano (e ancora mostrano) una convinta opposizione ai conformismi e una gran voglia di pensare con la propria testa. Naturalmente anche fra i maestri di tanti secoli orsono (come fra i rocker dei nostri tempi), ci sono teste calde, persone eccentriche e tipi alquanto bizzarri. Ma sia fra i filosofi greco-romani sia fra i musicisti contemporanei è difficile trovare gente noiosa.
Qui l’elenco dei maestri presenti in questa sezione.
ANTIPATRO DI TARSO

Antípatros ho Tarséus
Filosofo greco antico di scuola stoica (II° secolo a.C.).
Un simpatico studente di università lo chiamava Antipatico il Distratto. Non è chiaro se scherzasse o avesse inteso male il nome. Comunque, non risultano aneddoti sull’eventuale antipatia (o distrazione) di Antipatro, filosofo stoico del secondo secolo avanti Cristo, inserito fra i nostri maestri.
E’ di Tarso (Tarsus), località poi nota grazie a Paolo Apostolo (anche conosciuto come Paolo di Tarso o Saulo di Tarso).
Antipatro è fra i nostri maestri, ma lui stesso è prima allievo e poi successore di Diogene di Babilonia o di Seleucia (greco: Dioghénēs ho Babylónios, inglese: Diogenes of Babylon) nel ruolo di numero uno della scuola stoica. E’ pure l’insegnante di Panezio di Rodi (greco: Panaitios ho Rodos, inglese: Panaetius of Rhodes).
In campo etico, Antipatro sembra assumere una posizione morale più forte rispetto al suo maestro Diogene. Tuttavia, non abbiamo documenti storici sufficienti per confermare in dettaglio il suo pensiero.
Di certo, il biografo Plutarco (greco: Ploútarchos, inglese: Plutarch) lo menziona, insieme a Zenone di Cizio (greco: Zḕnōn ho Kitièus, inglese: Zeno of Citium), a Cleante (greco: Kleánthēs, inglese: Cleanthes) e a Crisippo di Soli (greco: Chrýsippos ho Soléus, inglese: Chrysippus of Soli), come uno dei più importanti filosofi stoici. Cicerone (latino: Marcus Tullius Cicero, inglese: Cicero) ne cita la notevole acutezza di analisi.
ANTIPATRO VERSUS CARNEADE
Antipatro si impegna, con entusiasmo, nelle frequenti dispute intellettuali tra la sua scuola e l’Accademia. Nonostante ciò, pare si senta inadeguato nei dibattiti pubblici con il suo contemporaneo Carneade (greco: Karneadēs, inglese: Carneades). Così, con quest’ultimo, si limita al dialogo scritto: per questa predilezione della scrittura viene soprannominato “Rumore di penna”.
Scrive, come altri maestri, alcune opere sugli dei e sulla divinazione. A questo tema, piuttosto comune tra gli stoici, dedica anche due libri, in cui considera i sogni come indizi soprannaturali del futuro, raccogliendo storie di divinazione attribuibili a Socrate (greco: Sōkrátēs, inglese: Socrates). Antipatro considera gli dei come “esseri benedetti, incorruttibili, benevoli verso gli uomini”. Critica chi attribuisce loro “generazione e corruzione”. Antipatro si riferisce al “fato” come a un ‘dio’ (vedi anche la voce “heimarmene” nella sezione Parole G-O di questo sito). Inoltre, scrive un trattato intitolato “Peri Deisidaimonias” (“Sulla Superstizione“).
Antipatro di Tarso è indubbiamente un filosofo stoico, ma su questioni riguardanti diversi aspetti della sua filosofia morale, non disponiamo di molti riferimenti. Unica eccezione sono alcune affermazioni sull’applicazione dei precetti morali.
Vai alla home page di SOKRATIKO.IT oppure torna in testa alla sezione MAESTRI oppure torna all’inizio di ANTIPATRO DI TARSO
ANTISTENE

Antisthénēs
Filosofo greco antico, fondatore della scuola cinica (V secolo a.C.).
E’ discepolo di Socrate (greco: Sōkrátēs, inglese: Socrates). Tuttavia, la sua avventura filosofica inizia con i “nemici” di Socrate. Nei primi tempi, infatti, Antistene è studente di retorica con maestri del calibro di Gorgia (greco: Gorghías, inglese: Gorgias), campione di Sofistica. A Socrate non piace la retorica. E ancor meno piacciono i maestri sofisti, veri esperti nell’arte della parola e del discorso. Pertanto il passaggio di Antistene, da Gorgia a Socrate, è notevole. In campo musicale, sarebbe come se un maestro di chitarra passasse dal pop all’heavy metal. Tra l’altro, l’evoluzione di Antistene va oltre il riposizionamento da Gorgia a Socrate. Infatti, alla fine del percorso, Antistene diventa il primo esponente del Cinismo, predicando ascetismo, privazioni e altri comportamenti severi. Il Cinismo si chiama così perché i cinici si riuniscono nel Cinosarge, il ginnasio ateniese dove sono accettati anche i “semi-cittadini” (Antistene, di madre straniera, è un meteco).
Antistene è fra i nostri maestri ed è un discepolo di Socrate in quanto adotta, sviluppandoli, gli insegnamenti di quest’ultimo (non tutti), in particolare nell’etica. Nel passaggio da Gorgia a Socrate, Antistene passa dalla regola della ‘forma’ alla regola del ‘contenuto’, dall’attenzione alla ‘apparenza’ alla attenzione alla ‘sostanza’, dalla ‘superficie’ alla ‘profondità’. In effetti, diviene uno dei maestri di uno stile di vita in cui gli individui sono chiamati a vivere con virtù. Perciò, esorta tutti a non arrendersi alle seduzioni del piacere.
ANTISTENE E LA VIRTU’
Secondo Antistene, la migliore forma di esistenza è determinata dalla applicazione pratica delle virtù (vedi anche la voce “aretè” nella sezione Parole A-F di questo sito). Per chi segue tale precetto, un’azione virtuosa non è mai inutile, anche quando non produce gli effetti voluti. Da ciò consegue una sorta di immunità delle persone sagge dall’errore. I maestri di saggezza (“phronesis“) sono immuni in quanto guidati dalle virtù e, quindi, le loro azioni non sono mai perdute, mai sbagliate. Infine, siccome la ricerca del piacere non rientra fra le virtù, il piacere stesso non è mai necessario ed è una forma particolare di male.
Antistene riflette sul dolore e persino sulla cattiva reputazione (“adoxia“) arrivando talvolta a considerarle come ‘benedizioni’. Per dire il vero, non sembra valutare tutti i piaceri in modo totalmente negativo. Per esempio, è fra i pochi maestri a lodare i piaceri la cui “origine è nell’anima”. E gli piacciono anche i piaceri derivanti dall’amicizia. A proposito, fra i suoi amici non si annovera Platone (greco: Plátōn, inglese: Plato), con il quale vantava molte divergenze.
Vai alla home page di SOKRATIKO.IT oppure torna in testa alla sezione MAESTRI oppure torna all’inizio di ANTISTENE
CLEANTE

Kleánthēs
Filosofo greco antico, esponente dello Stoicismo (IV secolo a.C.).
E’ un filosofo stoico greco di Asso. Prende il posto di Zenone di Cizio (greco: Zḕnōn ho Kitièus, inglese: Zeno of Citium) come secondo dei maestri (“scholarch“) della scuola stoica di Atene. Questo incarico lo mantiene fino alla età di 32 anni. Si guadagna da vivere come pugile e, successivamente, come portatore d’acqua.
Cleante dà origine a nuove idee nella fisica stoica e sviluppa lo Stoicismo in sintonia con il Materialismo e il Panteismo. Tra i frammenti degli scritti di Cleante, il più esteso a noi pervenuto è “L’Inno a Zeus”, conservato a Stobi. Il suo allievo Crisippo di Soli (greco: Chrýsippos ho Soléus, inglese: Chrysippus of Soli) diventa presto uno dei più importanti pensatori stoici e rientra anch’egli fra i nostri maestri.
CLEANTE E IL PIACERE
Secondo Cleante, il piacere “non è un bene”, “è contrario alla natura” e “senza valore”. Per lui, le passioni (amore, paura, dolore) sono semplicemente debolezze (vedi anche la voce “pathos” nella sezione Parole P-Z di questo sito). A queste passioni manca ogni tensione morale di cui l’anima ha, invece, bisogno. Dice: “le persone camminano nella malvagità per tutta la vita o, comunque, per la maggior parte di essa. Se mai raggiungono la virtù (“aretè“), è tardi e proprio al tramonto dei loro giorni”. Anche per Zenone solo una vita senza passioni (basata sulla ragione) è davvero coerente. Cleante completa la formula stoica, traducendola nel precetto “vivere coerentemente con la natura (“physis“). Il suo obbiettivo, come nel caso di altri maestri stoici, è vivere in piena sintonia con il corso dell’universo, perché l’universo è sotto il governo della ragione.
Cleante considera il Sole un essere divino. È divino perché assolutamente vitale per tutti gli esseri viventi.
CLEANTE E ARISTARCO
Secondo alcuni studiosi, Cleante avrebbe accusato Aristarco di Samo (greco: Aristarkhos ho Samios, inglese: Aristarchus of Samos) di empietà per aver osato mettere in dubbio “il focolare dell’universo” (cioè la Terra). Tuttavia, i manoscritti originali sembrano suggerire il contrario, cioè Cleante sotto accusa da parte di Aristarco.
Vai alla home page di SOKRATIKO.IT oppure torna in testa alla sezione MAESTRI oppure torna all’inizio di CLEANTE
CRISIPPO DI SOLI

Chrýsippos ho Soléus
Filosofo e matematico greco antico, fra i massimi esponenti dello Stoicismo (III° secolo a.C.).
E’ un filosofo stoico greco, originario della Cilicia, il quale presto si trasferisce ad Atene per diventare allievo di Cleante (greco: Kleánthēs, inglese: Cleanthes) nella scuola stoica. Quando quest’ultimo muore, Crisippo diventa il terzo dei maestri della scuola e un prolifico scrittore. Con il proprio pensiero, amplia le dottrine di Zenone di Cizio (greco: Zḕnōn ho Kitièus, inglese: Zeno of Citium), fondatore e primo dei maestri della scuola.
Crisippo escogita un originale sistema di logica proposizionale. Con tale sistema, intende gettare luce sul funzionamento dell’universo e sul ruolo dell’umanità. Ha una visione deterministica del destino, ma cerca comunque margini per la libertà personale. L’etica, egli pensa, dipende dalla comprensione dell’universo e dal conformarsi a esso da parte degli esseri umani.
CRISIPPO E IL DESTINO
Come accennato, Crisippo è fra i maestri per i quali esiste un destino. Per lui, tutte le cose accadono in linea con quanto stabilito dal fato. Se un accadimento sembra fortuito è solo perché noi non siamo in grado di vedere la causa tramite cui si lega anch’esso al destino. L’interrelazione delle cose del mondo consiste nella infinita concatenazione di cause ed effetti. Quindi, niente avviene senza causa o senza rientrare nel quadro totale della realtà.
Per Crisippo, ogni proposizione è o vera o falsa, e questa legge si deve applicare anche alle proposizioni riguardanti eventi futuri.
CRISIPPO E LE PASSIONI
Crisippo insegna una terapia il cui scopo è l’eliminazione dalla nostra anima di tutte le passioni indisciplinate capaci di deprimerci e frustrarci. Il suo obiettivo è la “apatheia” cioè uno stato mentale in cui non si viene disturbati da passioni turbolente e ingovernabili. Questo atteggiamento è espresso bene dalla parola equanimità, non dalla parola indifferenza.
Con Crisippo comincia il successo dei maestri dello Stoicismo come uno dei movimenti filosofici più influenti, per molti secoli, nel mondo greco e romano.
Vai alla home page di SOKRATIKO.IT oppure torna in testa alla sezione MAESTRI oppure torna all’inizio di CRISIPPO DI SOLI
DIOGENE DI BABILONIA O DI SELEUCIA

Dioghénēs ho Babylónios
Filosofo stoico greco antico (III° secolo a.C.).
E’ il capo dei maestri della scuola stoica di Atene ed è uno dei tre filosofi che vanno a Roma nel 155 a.C.
Scrive molte opere, ma nessuno dei suoi lavori sopravvive fino a noi, se non nella forma di citazioni da parte di maestri successivi. Marco Tullio Cicerone (latino: Marcus Tullius Cicero, inglese: Cicero) definisce Diogene “un grande e importante stoico”. È anche presente negli scritti del filosofo epicureo Filodemo di Gadara (greco: Philódēmos ho Gadareus, inglese: Philodemus of Gadara). Queste opere compaiono nei rotoli rinvenuti tra le rovine della Villa dei Papiri a Ercolano (latino e inglese: Herculaneum). In quei documenti, il nome di Diogene di Babilonia emerge più frequentemente di quello di altri maestri oltre Epicuro (greco: Epíkouros, inglese: Epicurus). Ciò prova, ma ci sono anche altre conferme, il ruolo di Diogene di Babilonia come capo della scuola stoica di Atene.
OPERE DI DIOGENE
Dei suoi numerosi scritti, conosciamo non molto più dei titoli. È opportuno citare “Dialektike Techne” (“L’Arte della Dialettica”), “Peri tou tes psyches hēgemonikou” (“Sulle qualità guida dell’anima”). A cui possiamo aggiungere “Peri phones” (“Sulla lingua”), “Peri eugeneias” (“Sull’aristocrazia per nascita”), “Peri nomon” (“Sulle leggi”).
Da quanto tramanda Filodemo, risultano anche altri due scritti attribuibili a Diogene di Babilonia: “Sulla Musica” e “Sulla Retorica”. Secondo Diogene, la musica può placare le emozioni, l’ascolto può generare armonia e proporzione nell’anima. Secondo lui, così come la dieta e l’esercizio fisico sono in grado di rendere sano il corpo, allo stesso modo la musica può essere salutare per la mente e curativa per le malattie psichiche. Inoltre, la musica spinge facilmente le persone all’azione. Diogene porta l’esempio della tromba e di altri strumenti militari. Questi strumenti possono incitare i soldati a essere coraggiosi. Oggi faremmo l’esempio dell’hard rock, con la sua energia martellante. Pertanto, la musica è un’arte capace di condurre alla virtù (“aretè“).
Ci sono passaggi in Cicerone da cui si ricavano altri argomenti trattati da Diogene di Babilonia, come, per esempio, il dovere e il bene supremo.
Vai alla home page di SOKRATIKO.IT oppure torna in testa alla sezione MAESTRI oppure torna all’inizio di DIOGENE DI BABILONIA
DIOGENE IL CINICO

Diogénēs ho Kynikós
Filosofo greco antico, considerato fra i fondatori della scuola cinica (V° secolo a.C.).
E’ uno dei maestri fondatori del Cinismo. Nel primo periodo della sua vita, il padre, un cambiavalute, si ritrova nei guai con la legge. In seguito, anche Diogene finisce in una situazione poco chiara con l’accusa di contraffare monete. Così viene bandito da Sinope e deve trasferirsi ad Atene. È la vita in questa grande città a dargli l’occasione di criticare (anche aspramente) molte convenzioni e abitudini.
In diversi modi, Diogene sembra seguire l’esempio di Eracle (greco: Hēraklḕs, inglese: Heracles), eroe divino la cui forma italica è Ercole (latino: Hercules, inglese: Hercules). Infatti, è palese l’impegno del filosofo per dimostrare la praticabilità concreta della virtù (“aretè“) in barba a qualunque dissertazione teorica.
LE ABITUDINI DI DIOGENE
Questa forte tendenza a “sporcarsi le mani” gli costa presto la reputazione, in particolare per la sua abitudine a dormire e mangiare quando e dove vuole. Spesso si mostra incurante delle “buone maniere” e pure apertamente provocatorio. Chiede l’elemosina per vivere e a volte si concede un pisolino in un grande vaso di ceramica al mercato. Diogene diventa noto anche per l’abitudine di portare con sé, per tutto il giorno, una lanterna. Lui ne sostiene la necessità per cercare (se c’è) un uomo onesto.
Critica Platone (greco: Plátōn, inglese: Plato), contestando in particolare la sua interpretazione del pensiero e dell’esempio di Socrate (greco: Sōkrátēs, inglese: Socrates). E siccome Diogene non si limita mai alle sole parole, comincia a sabotare le lezioni di Platone. Per esempio, mangia davanti a tutti durante le sessioni filosofiche del figlio di Aristone. È anche noto per la sua derisione di Alessandro Magno con l’irriverente richiesta al potente monarca di spostarsi per non fargli ombra. Pertanto, Diogene sarebbe da considerare uno dei maestri fondatori del Cinismo, anche secondo la nostra attuale semantica del termine.
DISAVVENTURE DI DIOGENE
Un giorno, Diogene viene catturato dai pirati e poco dopo si ritrova schiavo di un uomo di Corinto, città del Peloponneso dove poi trascorre il resto della vita.
Trasmette la sua filosofia a Cratete di Tebe (greco: Kratēs ho Thēbaios, inglese: Crates of Thebes), il quale la insegna a Zenone di Cizio (greco: Zḕnōn ho Kitièus, inglese: Zeno of Citium). È Zenone a rimodellare la filosofia del Cinismo nella scuola dello Stoicismo, una delle più apprezzate e durature. Nessuno degli scritti di Diogene sopravvive fino ai nostri giorni e i dettagli della sua vita derivano dagli aneddoti (“chreia“) in seguito raccontati. I più significativi provengono dal libro di Diogene Laerzio (greco: Dioghénēs Laértios, inglese: Diogenes Laërtius) “Vite e dottrine dei filosofi illustri”.
Vai alla home page di SOKRATIKO.IT oppure torna in testa alla sezione MAESTRI oppure torna all’inizio di DIOGENE IL CINICO
EPITTETO

Epíktētos
Filosofo greco antico, esponente dello Stoicismo di epoca romana (I° secolo d.C.).
E’ un filosofo stoico greco, la cui vita inizia da schiavo a Ierapoli (Hierapolis) in Turchia. In seguito, si sposta a Roma dove resta fino al momento del suo esilio. Infine, si trasferisce a Nicopoli (Nicopolis) in Grecia, e qui rimane per il resto della vita.
Grazie all’apprezzamento di cui gode sempre più come filosofo, ottiene il seguito di numerosi allievi, fra i quali spicca lo storico greco, funzionario pubblico, comandante militare e filosofo, Arriano di Nicomedia (greco: Arrianós). È quest’ultimo a scrivere gli appunti poi tramandati a beneficio degli interessati alla filosofia e dei successivi maestri.
FILOSOFIA COME MODO DI VIVERE
Epitteto è molto chiaro e coerente nell’intendere la filosofia come uno stile di vita, non una disciplina teorica. Per lui, tutti gli eventi esterni alla nostra coscienza sono fuori del nostro controllo. Uno stato affettivo è nel nostro controllo mentre non lo è un temporale improvviso. Quindi, dovremmo accettare di buon grado gli eventi del mondo, senza inutili resistenze. D’altro canto, secondo Epitteto, ognuno è responsabile delle proprie azioni, in quanto la decisione di agire prende corpo all’interno della coscienza. Pertanto, gli esseri umani (non solo i maestri) possono esaminare e controllare le proprie azioni grazie a una rigorosa autodisciplina. Nelle raccolte di pensieri denominate “Discorsi” ed “Enchiridion” si trovano le differenze rimarcate da Epitteto fra le cose in nostro potere (“proairetiche“) e quelle al di là del nostro potere (“aproairetiche“).
CONOSCERE SE’ STESSI
Secondo Epitteto, il fondamento di tutta la filosofia è la conoscenza di sé (gnōthi seautón). Ignoranza ed errore (contrari della conoscenza) sono vizi da combattere tramite attenzione e capacità di studio. Per portare a termine questo compito, è di grande aiuto la logica, essendo il mezzo più valido per ragionare e giungere alla certezza nei giudizi.
Per esempio, una prescrizione prioritaria raccomanda di non indulgere nei piaceri superficiali. La prescrizione seguente riguarda le ragioni stesse di una tale raccomandazione, cioè perché le persone non dovrebbero indulgere nei piaceri superficiali. La terza concerne l’esame delle ragioni. Questa è la logica: in primo luogo fornisce la verità, in secondo mostra qual è una motivazione della verità, in terza istanza dimostra in quale modo una determinata ragione è vera. Tutta la terza parte è indispensabile, ma soltanto perché esiste la seconda, la quale è a sua volta necessaria a sostegno della prima.
Vai alla home page di SOKRATIKO.IT oppure torna in testa alla sezione MAESTRI oppure torna all’inizio di EPITTETO
FILODEMO DI GADARA

Philódēmos ho Gadareus
Filosofo greco antico di formazione epicurea (II° secolo a.C.).
E’ un filosofo epicureo. Il termine “philodemos” si riferisce all’amore verso la gente mentre Gadara è una località della Giordania da noi oggi conosciuta come Umm Qais. Filodemo studia con maestri come Zenone di Sidone (greco: Zénōn ho Sidonio, inglese: Zeno of Sidon) ad Atene, poi si trasferisce a Roma e a Ercolano. Filodemo è anche un poeta. Infatti, è famoso soprattutto per i versi della “Antologia greca”. Tuttavia, nel XVIII secolo, alcuni suoi scritti emergono dalla Villa dei Papiri di Ercolano. Questi lavori comprendono testi su etica, teologia, retorica, musica, poesia e storia di alcune scuole filosofiche.
CONTRARIETA’ DI FILODEMO VERSO L’INDUZIONE
Filodemo mette in dubbio il valore del ragionamento induttivo. Non gli piace l’idea di estendere a un livello generale le cose osservate nei singoli casi (anche quando i singoli casi uguali sono molteplici). Il dubbio di Filodemo scaturisce dall’osservazione di tutte le cose uniche e di tutti gli eventi collocabili fuori norma. Infatti, dice: “ci sono nella nostra esperienza diversi eventi rari, non generalizzabili. Per esempio l’uomo di Alessandria alto mezzo cubito, con una testa tanto grande da poterla battere con un martello. Un altro caso riguarda Epidauro il quale si sposò quando era una giovane donna e poi, però, divenne un uomo”.
Filodemo rifiuta il processo della generalizzazione perché, ovviamente, travalica l’ambito delle nostre esperienze. Dice: “non si può dedurre la mortalità degli uomini in Libia dalla mortalità degli uomini intorno a noi“.
Vai alla home page di SOKRATIKO.IT oppure torna in testa alla sezione MAESTRI oppure torna all’inizio di FILODEMO DI GADARA
GAIO MUSONIO RUFO

Gaius Musonius Rufus
Filosofo neostoico romano (I° secolo d.C.).
E’ un filosofo stoico romano. Insegna a Roma durante l’impero di Nerone (latino: Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus, inglese: Nero). Nel 65 d.C. deve sopportare l’esilio per poi tornare a Roma sotto Galba (latino: Servius Sulpicius Galba Caesar Augustus, inglese: Galba). Rimane a Roma quando Vespasiano (latino: Titus Flavius Vespasianus, inglese: Vespasian) bandisce tutti gli altri maestri filosofi dalla città nel 71 d.C. Poi subisce nuovamente l’esilio, in cui resta fino alla morte di Vespasiano.
Di Musonio sopravvive, fino ai nostri giorni, una collezione di estratti ricavati dalle sue lezioni. È anche importante nella storia della filosofia come uno dei maestri di Epitteto (greco: Epíktētos, inglese: Epictetus).
PRATICITA’ DI MUSONIO
La filosofia di Gaio Musonio Rufo si caratterizza per una forte tendenza pratica (come nel caso del suo allievo Epitteto). La filosofia, per maestri come lui, non può limitarsi a parole e prescrizioni, per quanto belle e condivisibili, ma deve qualificarsi come disciplina da praticare e perseguire in un costante dialogo con la propria coscienza. Musonio crede nel potere della filosofia sulle persone e nella capacità di questa disciplina di “curare” le corruzioni nelle menti umane.
La preoccupazione di Musonio è quella di elaborare una serie di regole per la vita quotidiana, con il supporto della logica. Presta poca attenzione agli insegnamenti filosofici dei maestri stoici e, a suo avviso, gli dei sanno tutto senza bisogno di ragionamenti. Inoltre, considera le anime umane molto vicine agli dei e sostiene fermamente la libertà del pensiero razionale (“dianoia“).
CONSIGLI DI MUSONIO PER UNA VITA SEMPLICE
I suoi suggerimenti per una vita semplice sono curati nei minimi dettagli. Infatti, fornisce istruzioni precise per la dieta, per la cura del corpo, per l’abbigliamento e persino per l’arredamento. Arriva fino al punto di precisare la possibilità per ciascuno di lasciar crescere i capelli oltre la lunghezza consueta e di lasciare la barba sul volto in quanto elemento naturale per coprire il viso. Bandisce la carne mentre elogia il cibo fornito e offerto spontaneamente dalla natura.
Vai alla home page di SOKRATIKO.IT oppure torna in testa alla sezione MAESTRI oppure torna all’inizio di GAIO MUSONIO RUFO
IEROCLE

Hieroklês
Filosofo greco antico appartenente al tardo Stoicismo (I° secolo d.C.).
E’ un pensatore stoico greco, noto per la sua opera intitolata “Elementi di Etica”. In questo lavoro si dilunga, fra l’altro, sulla facoltà di cui godono gli animali nel percepire loro stessi continuamente. Per Ierocle, l’auto-percezione costante degli animali è la loro qualità più rilevante. Di converso, noi spesso ci dimentichiamo delle nostre percezioni e contiamo solo sulla mente. Questa tesi è strettamente correlata alla nozione stoica di percezione interna, di percezione del proprio io (“oikeiôsis“). Il primo assunto è: gli animali si auto-conservano. Il secondo è: gli animali sono coscienti di loro stessi nel quadro della loro relazione con gli altri animali. L’intera argomentazione costituisce il punto di partenza di una teoria etica piuttosto vasta.
IL COSMOPOLITISMO STOICO DI IEROCLE
Fra altri frammenti degli scritti di Ierocle troviamo anche una spiegazione del cosmopolitismo stoico. Questa spiegazione è basata sul modello dei cerchi concentrici. Per Ierocle, la realtà in cui sono inseriti tutti gli individui è costituita da una serie di cerchi. Il primo cerchio, più interno, è quello della mente umana. Poi, più esterno, c’è il cerchio della famiglia. A seguire, vengono i cerchi della ‘famiglia allargata’ e della ‘comunità locale’. Ancora più esternamente, c’è la comunità dei paesi vicini, seguita dal territorio e, infine, dall’intero genere umano.
IEROCLE E LA SOCIETA’
Ierocle suggerisce di iniziare a chiamare tutte le persone a cui non si è legati da relazioni parentali con gli appellativi di “zio” o “fratello”, a seconda della loro età. La proposta nasce dal desiderio di diffondere la prassi di considerare tutti come veramente vicini a noi, proprio come zii e fratelli (anche se si tratta, invece, di sconosciuti). E’ per noi interessante notare l’attuale applicazione di questa idea presso molti clan, sette, gang e confraternite. Tale nozione dimostra un interesse speciale di Ierocle per le questioni sociali. Dopotutto, è sbagliato considerare, come alcuni fanno, lo Stoicismo lontano dai temi più sociali e politici. Non abbiamo soltanto il caso di Ierocle, ma anche quelli di maestri quali Seneca (latino: Lucius Annaeus Seneca, inglese: Seneca the Younger) e Marco Aurelio (greco: Marcus Aurelius Antoninus Augustus, inglese: Marcus Aurelius).
Vai alla home page di SOKRATIKO.IT oppure torna in testa alla sezione MAESTRI oppure torna all’inizio di IEROCLE
LUCIO ANNEO SENECA
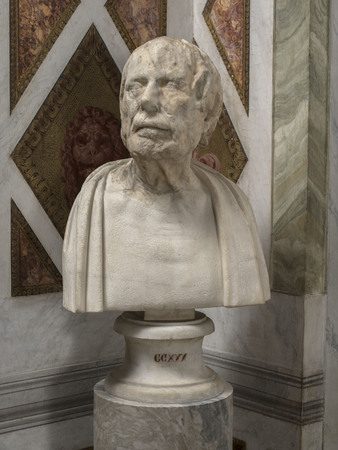
Lucius Annaeus Seneca
Filosofo, drammaturgo e politico romano, tra i massimi esponenti dello Stoicismo eclettico di età imperiale (I° secolo d.C.).
E’ un filosofo stoico romano, uno statista e un drammaturgo. Nato a Cordova (spagnolo: Córdoba) in Spagna, cresce a Roma dove mostra un forte interesse per la retorica e la filosofia.
Quando Nerone (latino: Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus, inglese: Nero) diventa imperatore, nel 54 d.C., Seneca assume il delicato ruolo di suo consulente. Ricoprendo tale posizione, assicura un governo competente durante i primi cinque anni del potere neroniano. Poi, l’influenza di Seneca sull’imperatore diminuisce progressivamente. Il rapporto fra i due si deteriora fino al punto di rottura: nel 65 d.C., Nerone costringe Seneca a suicidarsi. L’accusa contro il filosofo è di complicità nella congiura pisoniana presumibilmente architettata per assassinare Nerone. Tuttavia, la faccenda è confusa e controversa: Seneca forse è innocente. Il suo suicidio, lungo e veramente “stoico”, diventa, in seguito, il soggetto di numerosi dipinti di artisti famosi, per esempio, “Il suicidio di Seneca” di Manuel Domínguez Sánchez (1871), custodito al Museo del Prado.
SCRITTI DI SENECA
Come autore, Seneca raccoglie elogi – da secoli – per le sue opere e per le sue tragedie. I suoi scritti in prosa comprendono una dozzina di saggi e centoventiquattro lettere che trattano questioni morali. Queste opere sono tra le più significative fonti dello Stoicismo antico.
Nei suoi libri, Seneca cita spesso Zenone di Cizio (greco: Zḕnōn ho Kitièus, inglese: Zeno of Citium), Cleante (greco: Kleánthēs, inglese: Cleanthes) e Crisippo di Soli (greco: Chrýsippos ho Soléus, inglese: Chrysippus of Soli). Menziona anche Posidonio di Apamea (greco: Poseidónios ho Apameus, inglese: Posidonius of Apameia), con il quale condivide un certo interesse per i fenomeni naturali. Richiama, inoltre, Epicuro (greco: Epíkouros, inglese: Epicurus), specialmente nelle sue “Lettere”.
Il motto delle “Lettere morali” 48.2 – “vivas oportet si vis tibi vivere” (“occorre tu viva per un altro, se vuoi vivere per te stesso”) – è riportato sul retro della panchina di Waldo Hutchins (1932) a Central Park, Manhattan, New York City.
LETTERE DI SENECA
Le “Lettere a Lucilio” (“Epistulae morales ad Lucilium“) mostrano appieno la ricerca di Seneca nei confronti della perfezione etica. Seneca considera la filosofia come una medicina per le ferite della vita. Suggerisce di sradicare tutte le passioni distruttive, in particolare rabbia e pena. Chi si dimostra incapace di estirparle, dovrebbe almeno moderarle secondo ragione. Per Seneca è importante praticare la povertà e usare le eventuali ricchezze in modo appropriato. Il filosofo si occupa anche di favori, clemenza, l’importanza dell’amicizia e il bisogno di fare del bene agli altri. L’universo è governato da una provvidenza razionale, quindi dobbiamo accettare tutto, comprese le avversità, senza illuderci di poter modificare il corso delle cose.
Vai alla home page di SOKRATIKO.IT oppure torna in testa alla sezione MAESTRI oppure torna all’inizio di SENECA
MARCO AURELIO ANTONINO AUGUSTO

Marcus Aurelius Antoninus Augustus
Imperatore, scrittore e filosofo stoico romano (II° secolo d.C.).
E’ un imperatore romano e filosofo stoico. Studia greco e latino sotto la guida di tutori come Erode Attico (greco: Hērōdēs ho Attikos, inglese: Herodes Atticus) e Marco Cornelio Frontone (latino: Marcus Cornelius Fronto, inglese: Marcus Cornelius Fronto).
Tra il 170 e il 180, durante una campagna militare, scrive (in greco) l’opera da noi oggi conosciuta come “Meditazioni” o “Pensieri”. È una raccolta di considerazioni, a volte brevi altre volte più articolate, scritte soprattutto come pro memoria, come annotazioni a cui lui stesso possa fare riferimento in qualunque momento successivo alla stesura.
Non abbiamo indicazioni sul titolo originale (se c’è mai stato) di questa collezione di appunti e la mancanza di una titolazione è ulteriore prova di un uso personale a cui erano originariamente destinate le sue riflessioni: “Meditazioni”, “Pensieri” o altri nomi, come, ad esempio, “A se stesso”, sono tutti titoli adottati in seguito dai vari editori.
LE MEDITAZIONI DI MARCO AURELIO
Queste annotazioni profonde, sintetiche e stimolanti incarnano mirabilmente la filosofia e la spiritualità stoica. Esse sono anche la testimonianza letteraria di un governo di Marco Aurelio svolto all’insegna del servizio alla collettività e di uno schietto dovere morale.
I primi riferimenti storici a questo diario giungono a noi nel X secolo da Areta di Cesarea (Arethas) e dalla Suda bizantina. L’opera di Marco Aurelio va in stampa nel 1558, a Zurigo, ricavata da un manoscritto perduto in seguito. La più antica copia manoscritta completa e sopravvissuta si trova nella Biblioteca Vaticana e risale al XIV secolo.
MARCO AURELIO E LE PASSIONI
Ecco un passaggio delle “Meditazioni” (2,10) come esempio del punto di vista stoico di questo imperatore e filosofo: “Secondo Teofrasto (greco: Theóphrastos, inglese: Theophrastus, ndr) i peccati commessi per desiderio sono peggiori dei peccati commessi per ira. Questa è una buona filosofia. L’uomo arrabbiato sembra voltare le spalle alla ragione a causa del dolore e degli spasmi interiori. L’uomo motivato dal desiderio, quindi l’uomo sottomesso al controllo del piacere, sembra in qualche modo più auto-indulgente, meno virile, nei suoi peccati. Gli errori commessi per piacere meritano un rimprovero più severo rispetto a quelli motivati dal dolore. L’uomo arrabbiato è più simile a una vittima del peccato, provocato dal dolore per la rabbia. L’altro uomo si precipita a fare il male da solo, mosso all’azione dal desiderio”.
STOICISMO DI MARCO AURELIO
I pensieri sono propri di Marco Aurelio, ma i concetti espressi nelle meditazioni non sono del tutto originali. Fondamentalmente, sono una efficace manifestazione dei principi morali dello Stoicismo. Per esempio, si comprende bene quanto Marco Aurelio debba molte delle sue idee a Epitteto (greco: Epíktētos, inglese: Epictetus).
Il cosmo è un tutto intero ed è governato da una ragione suprema. L’anima umana appartiene alla stessa intelligenza divina. Così se ne sta l’anima, prima di essere corrotta, pura e incontaminata in mezzo alla follia e alla vanità.
Alcuni dei pensieri di Marco Aurelio divergono dalla filosofia stoica e risultano essere piuttosto vicini al Platonismo al punto da poter essere definiti come espressioni del Neoplatonismo.
Vai alla home page di SOKRATIKO.IT oppure torna in testa alla sezione MAESTRI oppure torna all’inizio di MARCO AURELIO
MARCO PORCIO CATONE L’UTICENSE

Marcus Porcius Cato Uticensis
Politico, militare, scrittore, magistrato monetario, oratore e filosofo stoico (I° secolo a.C.).
Conosciuto anche come Catone Minore, è uno statista della tarda Repubblica romana (Res publica Populi Romani). È anche un appassionato seguace della filosofia stoica. Apprezzato oratore, mostra molto spesso testardaggine e tenacia, specialmente nel suo lungo conflitto con Giulio Cesare (latino: Gaius Iulius Caesar, inglese: Julius Caesar). Atteggiamento incorruttibile, integrità morale e una nota avversione per la disonestà sono tra le sue caratteristiche più apprezzabili. L’epiteto “il Giovane” lo distingue dal bisnonno, Catone il Vecchio (latino: Marcus Porcius Cato, inglese: Cato the Elder).
SPIRITO DI SERVIZIO DI CATONE
Alla base della filosofia di Catone c’è il valore delle azioni da compiere in nome del dovere e del servizio alla collettività, senza tenere in troppa considerazione le conseguenze future. Secondo Catone, tutti debbono svolgere un ruolo attivo e partecipare fattivamente alla vita sociale. Tuttavia, quando si è incapaci di attuare i giusti principi bisogna fare un passo indietro. In politica, Catone detesta il compromesso.
Non compone opere, quindi non lascia ai posteri altro insegnamento se non il suo esempio. L’unica sua composizione in nostro possesso è la lettera a Marco Tullio Cicerone (latino: Marcus Tullius Cicero, inglese: Cicero) “Ad Fam. XV.5”: con questa lettera, Catone respinge cortesemente una offerta di lavorare insieme a Cicerone. La scuola degli stoici, molto in voga nella Roma dei primi imperatori, stima molto Catone.
ASCESA DEGLI STOICI AL POTERE DA CATONE IN POI
Dopo Catone, gli stoici continueranno per due secoli a criticare apertamente l’impero, non meno di quanto fa Catone, finché alla fine siederanno loro stessi sul trono imperiale con Marco Aurelio (greco: Marcus Aurelius Antoninus Augustus, inglese: Marcus Aurelius).
L’atteggiamento è comprensibile, visti gli opulenti costumi di alcune figure imperiali, in netto contrasto con i precetti stoici. Per esempio, ci sono molti resoconti sull’ascetismo di Catone: mangia soltanto quanto gli basta per sopravvivere, si infligge ogni tipo di prova di resistenza e adotta un regime fisico costituito da esercizi molto faticosi.
Una delle sue caratteristiche è anche la capacità di ascoltare le altre persone con molta attenzione.
SUICIDIO DI CATONE
Il suo suicidio determina ulteriormente l’inserimento di Catone nella storia dello Stoicismo. In effetti, per lo Stoicismo storico il suicidio è una fine degna per uomini probi e leali. Infatti, c’è una lunga lista di Stoici famosi i quali hanno scelto e praticato la propria fine.
Vai alla home page di SOKRATIKO.IT oppure torna in testa alla sezione MAESTRI oppure torna all’inizio di CATONE UTICENSE
PANEZIO DI RODI
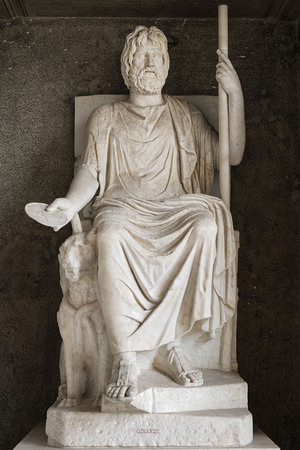
Panaitios ho Rodos
Filosofo greco antico, iniziatore del periodo stoico noto come Media Stoà (II° secolo a.C.).
E’ un filosofo stoico, allievo di Diogene di Babilonia (greco: Dioghénēs ho Babylónios, inglese: Diogenes of Babylon) noto anche come Diogene di Seleucia. Pure Antipatro di Tarso (greco: Antípatros ho Tarséus, inglese: Antipater of Tarsus) è suo maestro ad Atene. Poi si trasferisce a Roma dove contribuisce all’introduzione delle discipline stoiche. Successivamente, ritorna ad Atene e diventa scolarca (“scholarch“) ovvero il capo, l’ultimo capo degli stoici ad Atene. Con Panezio lo Stoicismo diviene decisamente più eclettico.
IL DOVERE IN PANEZIO
L’opera principale di Panezio di Rodi s’intitola “Peri tou Kathikodos” (“Sul dovere”). In questo trattato, il filosofo approfondisce la differenza fra le azioni morali e quelle immorali. Quindi, argomenta su ciò che è utile o non utile. Infine, discute la questione del conflitto tra le cose morali e le cose utili. Essendo uno stoico, potrebbe considerare tale conflitto come solo apparente e non reale. Tuttavia, la terza indagine rimane nella fase di progetto. Il suo discepolo Posidonio di Apamea (greco: Poseidónios ho Apameus, inglese: Posidonius of Apameia) si pone l’obbiettivo di completare l’opera, riuscendoci in parte.
Marco Tullio Cicerone (latino: Marcus Tullius Cicero, inglese: Cicero) scrive il suo “De Officiis” (“Sui doveri”) ispirandosi deliberatamente a Panezio, con l’intenzione di elaborare ulteriormente i suoi concetti.
PENSIERO DI PANEZIO
Panezio mitiga la severità dei primi stoici. In filosofia, assegna il primo posto alla Fisica, non alla Logica. E, nella Fisica, respinge la teoria stoica della conflagrazione dell’universo. Cerca anche di offrire una divisione più semplice delle facoltà dell’anima (altro tema frequente nella filosofia antica). Inoltre, mostra un certo scetticismo nei confronti della divinazione. In campo etico, accetta soltanto una duplice divisione della virtù, teorica e pratica, in contrasto con la “dianoetica” e con l’etica di Aristotele (greco: Aristotélēs, inglese: Aristotle). Tenta di avvicinare lo scopo ultimo della vita agli impulsi naturali e di mostrare l’inseparabilità delle virtù.
PANEZIO E LE PASSIONI
Panezio rifiuta la dottrina – piuttosto diffusa in campo stoico – del contrasto da attuare verso tutte le passioni (“apatheia“) perché considera del tutto in linea con la natura alcune “sensazioni piacevoli”, quindi non da contrastare. Infine, per lui, le definizioni morali dovrebbero essere stabilite in modo semplice affinché comprensibili anche a chi non abbia ancora raggiunto la saggezza.
Vai alla home page di SOKRATIKO.IT oppure torna in testa alla sezione MAESTRI oppure torna all’inizio di PANEZIO DI RODI
POSIDONIO DI APAMEA

Poseidónios ho Apameus
Geografo, storico e filosofo greco antico appartenente alla scuola stoica (II° secolo a.C.).
E’ un filosofo, politico, astronomo, geografo, storico e insegnante greco Stoico originario di Apamea, in Siria.
Per Posidonio, la filosofia è al di sopra di tutte le scienze particolari. È, dunque, una disciplina suprema, la sola capace di spiegare l’intero cosmo. Questo tipo di olismo è abbastanza comune tra gli stoici. In base a tale convinzione, tutte le sue opere, da quelle scientifiche a quelle storiche, implicano sempre basi filosofiche.
FISICA, LOGICA ED ETICA DI POSIDONIO
Posidonio accetta la classificazione stoica della filosofia in Fisica (filosofia naturale, metafisica e teologia), Logica (inclusa la dialettica) ed Etica. Queste tre aree sono (per gli stoici) le parti indipendenti di un tutto organico e naturale. Il filosofo le paragona a un essere vivente. Quindi, la Fisica è la carne e il sangue. La Logica costituisce le ossa e i tendini (tengono insieme l’organismo). Infine l’Etica – la parte più importante – corrisponde all’anima. L’universo, per come lo vede Posidonio, è interconnesso allo stesso modo.
ECLETTISMO DI POSIDONIO
Più o meno come Panezio (greco: Panaitios ho Rodos, inglese: Panaetius) e gli altri stoici del medio periodo, Posidonio è eclettico. Segue non solo gli stoici più antichi, ma anche Platone (greco: Plátōn, inglese: Plato) e Aristotele (greco: Aristotélēs, inglese: Aristotle). Posidonio è il primo stoico a distaccarsi dalla dottrina ortodossa secondo cui le passioni sono giudizi sbagliati: infatti, è d’accordo con Platone nel ritenere le passioni legate alla natura umana.
Oltre alle facoltà razionali, secondo Posidonio, l’anima umana ha proprietà vivaci (rabbia, desiderio di potere, possedimenti, etc.) e anche qualità desiderative (desideri di sesso e cibo). L’etica affronta il problema relativo alla gestione di queste passioni e alla capacità di riportare la ragione a essere la virtù dominante.
Vai alla home page di SOKRATIKO.IT oppure torna in testa alla sezione MAESTRI oppure torna all’inizio di POSIDONIO DI APAMEA
SOCRATE

Sokrates
Primo grande protagonista della filosofia, a noi noto grazie alle opere di Platone (V° secolo a.C.).
E’ considerato il ‘padre’ della filosofia occidentale. Tuttavia, non conosciamo opere scritte direttamente da lui. È il suo ‘allievo’ Platone (greco: Plátōn, inglese: Plato) a lasciare ai posteri circa 30 dialoghi in cui Socrate è il ‘personaggio principale’.
Un altro discepolo di Socrate, Senofonte (greco: Xenophṑn, inglese: Xenophon of Athens), scrive diversi libri di dialoghi (“Memorabili”) e una “Apologia di Socrate”. Quest’ultima opera racconta il processo a Socrate del 399 a.C. Come è noto, il caso giudiziario si conclude con la condanna a morte per il filosofo. Socrate non si rifiuta di bere il veleno, pur se innocente rispetto alle accuse di empietà (ateismo) e di corruzione dei giovani. Tuttavia, la sua scelta di accettare la sentenza non è prova di debolezza, docilità o colpa. Deriva, invece, da rettitudine civica e integrità. Secondo Socrate, tutti i cittadini hanno il dovere di rispettare la legge e di onorare le istituzioni comuni.
STILE DI VITA DI SOCRATE
Attraverso questi resoconti, siamo a conoscenza del modo di vivere (severo), del modo di pensare (acuto), di discutere (innovativo) e di elaborare (ingegnoso) di Socrate. Ama dibattere di argomenti filosofici rilevanti come ‘verità’, ‘giustizia’, ‘virtù’. Evidentemente, gli piacciono le sfide concettuali su nozioni difficili da definire.
Uno dei tratti caratteristici di Socrate è la sua instancabile capacità di insistere come un tafano. Gli piace concentrarsi su qualsiasi argomento egli ritenga degno di una completa esplorazione (per amore della verità). Il filosofo è solito pressare i suoi vari antagonisti fino al punto di farli arrendere e ammettere la propria ignoranza.
UMILTA’ DI SOCRATE
Eppure, Socrate è il primo a dichiarare la propria insufficienza. Infatti, ammette serenamente “io so di non sapere”. Il suo atteggiamento filosofico, quindi, è una manifestazione instancabile di ironia (e umiltà). Queste qualità si basano sulla conoscenza di tutti i suoi (e nostri) limiti, in particolare i limiti della mente.
‘Conosci te stesso’ (conosci la tua fallibilità, conosci la tua imperfezione) è la traduzione italiana di “gnōthi sautón“, cioè proprio la prescrizione basilare della filosofia di questo sito, ovvero la “cura di sé“. In altri termini, l’atteggiamento filosofico della “epimèleia heautoù” (“cura di sé“) inizia a diventare storicamente e filosoficamente cruciale con Socrate.
SOCRATE E IL CONOSCERE SE’ STESSI
Il pilastro di questo approccio filosofico è la necessità per il soggetto di conoscere se stesso. Nessuno potrebbe prendersi cura di sé senza un processo di ricerca nell’anima. Nessuno può prendersi cura di sé senza conoscere la propria anima.
In “Apologia” 29d, Platone ricorda (o immagina) Socrate mentre sta pronunciando queste parole in difesa di se stesso: “cari amici, cittadini di Atene, la più grande città del mondo, così eccezionale per intelligenza e potere, non vi vergognate di essere così tanto interessati ad accumulare denaro, promuovere la vostra reputazione e il vostro prestigio, mentre non avete alcuna cura o preoccupazione per la verità e la saggezza e la crescita della vostra anima?”
SOCRATE PER FOUCAULT
Il 6 gennaio 1982, durante una lezione al College de France, il filosofo francese Michel Foucault afferma: “Socrate ha una funzione essenziale, fondamentale e originale, il compito e la posizione di incoraggiare gli altri a occuparsi di se stessi, a prendersi cura di sé e a non trascurarsi”. L’intero corso del 1982 di Michel Foucault è disponibile in “L’Ermeneutica del soggetto: Corso al Collège de France 1981-1982”.
Vai alla home page di SOKRATIKO.IT oppure torna in testa alla sezione MAESTRI oppure torna all’inizio di SOCRATE
ZENONE DI CIZIO

Zḕnōn ho Kitièus
Filosofo greco antico considerato fondatore dello Stoicismo (IV° secolo a.C.).
E’ un filosofo ellenistico di origine fenicia (Cipro). Molti studiosi lo considerano il fondatore della filosofia stoica, da lui insegnata ad Atene dal 300 a.C. circa.
Lo Stoicismo si fonda sulle idee morali dei cinici. Per gli Stoici l’equanimità e la serenità derivano da una vita in sintonia con la Virtù e la Natura. Infatti, “la felicità è un flusso buono di vita” dice Zenone. Poi aggiunge: “la felicità discende dalla retta Ragione umana quando coincide con la Ragione universale” (“logos“). E il “logos” è la legge/forza/principio alla base di tutto.
ZENONE E LE COSE INDIFFERENTI
Zenone si differenzia dai maestri cinici quando afferma “anche le cose moralmente indifferenti (“adiaphora“) hanno un loro valore. Questo valore è proporzionale a quanto le cose moralmente indifferenti sono coerenti con il naturale istinto di autoconservazione“. Ad ogni modo, anche se le azioni moralmente indifferenti hanno un loro valore, noi dobbiamo comunque privilegiare le “azioni appropriate” (“kathêkon“). Questo perché la felicità dipende solo dalle azioni morali.
La Virtù esiste solo quando la Ragione detta la regola. Il Vizio esiste solo quando la Ragione viene dimenticata. Così la Virtù e il Vizio non possono esistere nella stessa situazione e nel medesimo tempo. Inoltre non possono essere fatti aumentare o diminuire.
ZENONE E LE AZIONI
Le azioni sono o buone o cattive: ciò si deve a impulsi e desideri dipendenti dal libero consenso. Anche stati mentali passivi o emozioni non guidate dalla ragione potrebbero essere immorali e produrre azioni immorali.
Zenone lascia al mondo greco il primo studio articolato delle emozioni umane. In esso elenca quattro emozioni negative: il desiderio, la paura, il piacere e il dolore (“epithumia“, “phobos“, “hêdonê“, “lupê“). Inoltre, è forse responsabile della classificazione delle tre emozioni positive corrispondenti: volontà, pieno abbandono e gioia (“boulêsis“, “eulabeia“, “chara“). Queste sono soltanto tre perché Zenone non indica alcun equivalente buono corrispondente al dolore.
Vai alla home page di SOKRATIKO.IT oppure torna in testa alla sezione MAESTRI oppure torna all’inizio di ZENONE DI CIZIO
